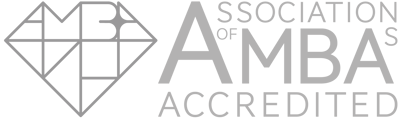Il vino italiano tra vento favorevole e correnti ostili: servono leadership e lungimiranza
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 05/2025 - Settembre
L’annata 2025 si presenta per il settore vitivinicolo italiano con luci e ombre. Da un lato, la produzione promette bene: secondo le stime di Unione Italiana Vini, Assoenologi e ISMEA, la vendemmia dovrebbe raggiungere 47,4 milioni di ettolitri, segnando un +8 % rispetto al 2024, e le uve si presentano in gran parte sane, grazie a una primavera ben calibrata e a una maturazione favorita da escursioni termiche positive. Tuttavia, non mancano criticità: mercato internazionale incerto, dazi, giacenze elevate e domanda domestica che non compensa facilmente la debolezza all’estero.
Allo stesso tempo, anche altri dati confermano il quadro complesso. Secondo il rapporto IWSR, tra i sei trend globali del 2025 il consumatore è più selettivo, più attento alla salute, preferisce esperienze domestiche e prodotti premium con un forte valore percepito – non semplicemente lusso sfrenato. Sul versante export, l’Italia ha mantenuto un valore vicino a quello del primo semestre 2024 (−0,47 %) ma ha perso volumi (−3,1 %), mentre alcune regioni – Veneto in testa – continuano a crescere in valore. Le barriere tariffarie (in particolare il dazio USA al 15 %) hanno già prodotto un impatto non trascurabile, costando al vino italiano decine di milioni. Anche il mercato statunitense dà segnali di debolezza: i consumatori tagliano le spese per ristorazione e alcolici in risposta all’incertezza economica, un fattore da non sottovalutare viste le prospettive di crescita che molti avevano riposto in quel mercato.
Tre sfide che non si possono ignorare
Da questi elementi emergono almeno tre ambiti nei quali chi guida un’azienda vinicola – grande o piccola che sia – dovrà avere competenze mature per fare la differenza:
- Anticipare i segnali del mercato, non inseguirli
Le oscillazioni di domanda, le politiche tariffarie, le pressioni sul prezzo non sono “imprevisti” ma fenomeni la cui probabilità cresce. Avere un management che monitora scenari globali e locali, calibra la produzione (giacenze, qualità, volumi) e pianifica i costi – senza lasciarsi travolgere dall’emotività del momento – sarà sempre più determinante. - Evitare scorciatoie nelle strategie commerciali
Strategie come scontistiche aggressive per guadagnare quota mercato nei momenti difficili possono erodere i margini a lungo termine, danneggiare il posizionamento e perfino far perdere valore al brand. In un contesto dove consumo premium-selective, prodotti “no-alcol” o a basso grado, e occasioni domestiche crescono (anche per ragioni economiche ed etiche), puntare sul valore intrinseco, sulla storia, sulla qualità e sull’esperienza può restituire più benefici che cercare la mera competitività di prezzo. - Coltivare relazioni solide con trade, mercati e consumatori
Non basta avere un buon vino: bisogna saperlo raccontare, distribuirlo bene, promuoverlo in modo coerente, costruire fiducia. Le relazioni con importatori, distributori, ristoratori sono leve essenziali, specie in mercati esteri dove i dazi complicano la partita; ma lo sono anche le connessioni con i consumatori finali – sia attraverso storytelling, sia attraverso canali digitali, eventi, esperienze di consumo che vanno al di là della bottiglia. Il report IWSR segnala che i consumi casalinghi, il digitale e i prodotti con identità chiara valgono sempre di più.
Ecco alcune linee d’azione che le aziende possono adottare:
- Pianificazione dinamica della produzione: considerare modelli che permettano di “aprirsi o comprimersi” in base alla domanda, come suggerito da Unione Italiana Vini, per evitare surplus dannosi.
- Segmentazione del portafoglio prodotti: differenziare tra linee di prestigio, vini quotidiani, sperimentazioni, prodotti a basso contenuto alcolico o analcolici; adattare formati di bottiglia e packaging alle occasioni di consumo emergenti (domestico, aperitivi, RTD, etc.).
- Investire in branding, sostenibilità e comunicazione: la sostenibilità ambientale, le pratiche agricole rispettose del territorio, la qualità certificata, diventano non solo un costo ma un punto di forza competitivo; utilizzare il digitale non solo per vendere ma anche per educare, fidelizzare, costruire reputazione.
- Gestire i canali di export con cura: selezionare mercati con potenziale in crescita, diversificare i rischi geopolitici e tariffari, collaborare con istituzioni (pubblico-privato) per mitigare l’impatto dei dazi o ottenere supporti promozionali.
- Flessibilità finanziaria e controllo dei costi: per non restare scoperti davanti alle crisi, serve una struttura finanziaria in grado di far fronte a “venti contrari”, mantenere margini e investire anche nelle fasi meno floride.
In un settore come quello del vino, fatto di tradizione ma anche di maturi equilibri globali, non basta fermentare bene: serve fermentare strategicamente. Anni come il 2025, con produzioni elevate e qualità eccellente, offrono opportunità – ma queste opportunità rischiano di essere vanificate se non si possiede il coraggio imprenditoriale e la visione manageriale necessari. Le aziende che riusciranno a leggere per tempo i segnali (consumo che cambia, etica che pesa, digitale che non è solo “canale”), che manterranno salda la relazione con tutti gli attori della filiera, che difenderanno il valore dei propri vini oltre il mero prezzo, saranno quelle che, nel medio-lungo termine, consolideranno non solo la resistenza, ma la leadership.
Export vino italiano: il nuovo scenario dopo i dazi USA
Lorenzo Biscontin
CEO Labhornet Srl e Visiting Faculty Wine Business Management, MIB Trieste School of Management
CEO Labhornet Srl e Visiting Faculty Wine Business Management, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 05/2025 - Settembre
Indipendentemente da come la pensi sull’accordo commerciale USA-UE (io personalmente ritengo che l’Europa si sia dimostrata debole siglando un pessimo accordo) i nuovi dazi sul vino sono un fattore esterno che le aziende sono costrette ad assumere come dato e su cui non possono avere nessun controllo.
Vale la pena quindi concentrarsi sull’analisi di come cantine possano muoversi nel nuovo scenario, cercando nuovi sbocchi sui mercati internazionali. Per brevità mi concentrerò solo sui mercati che mostrano nuove dinamiche, tralasciando quelli consolidati come Germania o UK.
Stati Uniti
Il mercato USA subirà un aumento dei prezzi dei vini italiani a causa dei dazi e della svalutazione del dollaro rispetto all'euro. Inoltre il 3-tier-system agisce come amplificatore dei rincari dovuti a dazi e dollaro.
Questo sposterà i vini italiani in fasce di prezzo superiori, dove la domanda è inferiore. Tuttavia, la tipicità dei vini italiani rende difficile la loro sostituzione con vini di altri paesi. Il consumo di vino negli USA è in calo, il che rappresenta una sfida aggiuntiva.
Le strategie suggerite sono di incrementare la comunicazione per aumentare il valore percepito del vino e ampliare l'assortimento proponendo anche vini con prezzo di partenza inferiore a quelli proposti oggi.
Canada
In consumatori canadesi, ed in parte anche i monopoli, stanno portando avanti un booicottaggio di fatto nei confronti di vini e distillati USA. Nel primo semestre del 2025 quindi le importazioni canadesi di vini USA sono crollate e si sono quindi create opportunità per i vini italiani di riempire questo vuoto.
Si prevede che a fine 2025 il Canada ridurrà le importazioni di vino USA per un valore di 250 milioni di $, che equivale a più della metà di tutto il mercato brasiliano e dieci volte l’attuale mercato indiano.
Qui la strategia è semplice: intensificare il lavoro con i propri agenti canadesi per cogliere tutte le opportunità, anche temporanee, in modo da riempire il vuoto lasciato dai vini USA.
Cina
Il consumo di vino in Cina è crollato dal il 2017 in avanti, tornando a valori inferiori a quelli del 1995. Anche così però il paese rimane il 9° importatore mondiale a volume ed il 7° a valore.
Da notare come dal COVID in avanti Il mercato cinese sia profondamente cambiato, con un drastico calo dei consumi di vino in banchetti ed occasioni ufficiali e degli acquisti per regalo (status) ed un aumento degli acquisti per consumo proprio (esperienze). Questo ha portato un forte aumento degli acquisti online, che coprono oggi più del 50% del totale ed un ringiovanimento della platea dei consumatori, in particolare di giovani donne che vivono in aree metropolitane e urbane.
Crescono le vendite di vini bianchi (+8,5% nel 2024) e spumanti (+18,8% nei primi 5 mesi del 2025) e si stima che rappresentino tra il 10% ed il 20% del consumo effettivo, ovvero al netto delle giacenze nei magazzini degli importatori.
È necessario un approccio strategico a medio termine, con un focus sul canale online sia per la distribuzione che per la costruzione dell’immagine di marca. Il web significa disintermediazione, quindi le classiche strategie e tattiche basate sul ruolo determinante degli intermediari qui servono a poco.
Brasile
Le importazioni di vino in Brasile sono in crescita: 518 milioni di US$ nel 2024 e 45 milioni di consumatori abituali nel 2022. Il mercato si sta ampliando anche a vini più complessi e costosi e l'Italia ha un'immagine molto positiva in Brasile. L’altro punto di forza è la varietà e tipicità della proposta rispetto agli altri Paesi concorrenti come Cile e Argentina.
Attenzione alla burocrazia dell’amministrazione brasiliana, che è particolarmente onerosa. Però il Brasile è nun mercato che dove oggi si possono ottenere risultati interessanti anche nel breve periodo.
India
Per l’India vale un po’ lo stesso discorso che valeva per la Cina 15 anni fa: la dimensione della popolazione è tale che non si può non considerare nelle proprie strategie di sviluppo. In realtà si tratta ancora di un mercato molto piccolo che nel 2024 ha importato vino per 26 milioni di US$. Se vi dicono, o trovate in rete, che supera i 400 milioni non credeteci: è successo nel 2023 per un boom del vino spagnolo a valore del 30.000 % che implicava un prezzo di importazione medio al litro del vino spagnolo di 518 US$ che nessuno è riuscito a spiegare. Ovvero si è trattato un errore nelle rilevazioni.
Ciò detto, la domanda di vino in India si concentra nelle aree metropolitane, sostenuta da consumatori giovani (comprese le donne) che vedono nel vino un’alternativa più sana e sofisticata agli spirits (l’India è il quinto mercato mondiale di spirits in valore ed il primo consumatore di wishkey). Questi giovani consumatori stanno aprendo il consumo anche a spumanti, rosè e vini bianchi in aggiunta ai tradizionali vini rossi (un po’ come sta succedendo in Cina).
Attenzione che la vendita di alcolici è gestita a livello dei singoli stati ed in alcuni di questi il consumo di alcol è proibito. Operativamente questo implica che i vini vanno registrati anche a livello statale, un po’ come succede negli USA.
Paese sicuramente interessante, ma da guardare nel lungo periodo (oltre i 5 anni).
Africa
La prima cosa da dire è che l’Africa non è un singolo Paese ed è molto più grande di quello che le mappe geografiche lasciano intendere. Attualmente i Paesi africani con le maggiori importazioni di vino, escludendo il Sud Africa, sono (dati 2024 in hl):
- Costa d’Avorio: 600.000
- Angola: 300.000
- Namibia: 260.000
- Marocco: 250.000
- Togo: 150.000
La differenza tra le posizioni a volume ed a valore evidenzia come i Paesi africani importino vini di prezzo medio più basso rispetto al resto del mondo. Sarebbe però sbagliato pensare che questi mercati siano interessati solamente a vini economici: sul mercato ugandese sono presenti le più note maisons di champagne e si prevede che le vendite di spumanti nel 2025 superino il milione di US$.
Le previsioni demografiche, molto più attendibili di quelle più economiche, dicono che nel 2050 gli africani cresceranno dagli attuali 1,4 miliardi a 2,5 miliardi e sarà africano 1 abitante della terra su 4.
Io non mi stupirei se alcuni mercati africani nel medio periodo potessero dare maggiori soddisfazioni rispetto all’India.
Export Agroalimentare italiano: analisi strategica dei Distretti 2024
Luca La Paglia
Marketing & Export Manager wine&food e diplomato Wine Business Management, edizione 10
Marketing & Export Manager wine&food e diplomato Wine Business Management, edizione 10
Wine Newsletter 05/2025 - Settembre
L'analisi del "Monitor dei distretti agroalimentari" di Intesa Sanpaolo (fonte Istat) offre una fotografia strategica dell'eccellenza italiana che va oltre i numeri: rivela dinamiche competitive e opportunità manageriali decisive per il futuro dell'export nazionale.
Il quadro macro: performance e posizionamento competitivo
I risultati 2024 confermano la solidità strutturale del sistema agroalimentare italiano. L'export dei distretti agroalimentari ha superato 28 miliardi di euro, registrando una crescita del 7,1% rispetto al 2023 (+1,9 miliardi). Questo segmento rappresenta il 42,5% del totale export agroalimentare nazionale, che complessivamente ha raggiunto 67,5 miliardi di euro con una crescita dell'8,3% anno su anno.
Questi dati testimoniano non solo la resilienza del settore, ma anche la capacità di generare valore aggiunto attraverso modelli distrettuali che combinano tradizione, innovazione e specializzazione territoriale.
Analisi settoriale: motori di crescita e dinamiche competitive
- Comparto oleario: leadership di mercato e sfide manageriali
Implicazioni manageriali: Il successo oleario riflette l'efficacia di strategie di premium positioning e autenticità territoriale. Tuttavia, la gestione della volatilità stagionale, la protezione della qualità post-raccolta e la lotta alla contraffazione richiedono investimenti in sistemi di controllo qualità, tracciabilità digitale e brand protection internazionale.
- Filiera vitivinicola: differenziazione e posizionamento premium
Considerazioni strategiche: La divergenza nelle performance evidenzia l'importanza critica della gestione del portfolio brand e della comunicazione territoriale. I distretti vincenti combinano efficacemente heritage e innovazione, mentre quelli in difficoltà necessitano di strategie di rilancio basate su differenziazione qualitativa e storytelling territoriale.
- Settori complementari: diversificazione e sinergie
Geografia dei mercati: opportunità e risk management
L'analisi geografica dell'export rivela dinamiche geopolitiche significative:
- Germania: conferma la leadership come primo partner commerciale (+6,9%)
- Stati Uniti: mercato in forte espansione (+14,9%), particolarmente strategico per settori premium
- Economie emergenti: rappresentano il 20% del totale con crescita del +7,7%, superiore alle economie avanzate (+6,9%)
Framework strategico: leve competitive per il management
- Value Proposition e Brand Equity
- Diversificazione geografica e Portfolio Risk
- Sostenibilità come driver competitivo
- Collaborazione intersettoriale ed economie di scala
Riflessioni manageriali
I dati 2024 confermano che l'eccellenza agroalimentare italiana possiede fondamenta solide ma richiede visione manageriale strategica. Il successo futuro dipenderà dalla capacità di:
- Integrare tradizione e innovazione in proposte di valore distintive
- Gestire la complessità geopolitica attraverso diversificazione intelligente
- Trasformare la sostenibilità da compliance a competitive advantage
- Sviluppare ecosistemi collaborativi che amplificano le economie distrettuali
La classifica delle prime 115 aziende vinicole italiane
Wine Newsletter 05/2025 - Settembre
Ogni anno la giornalista Anna Di Martino cura per L’Economia del Corriere della Sera una classifica approfondita delle 115 maggiori aziende vitivinicole italiane, analizzandone fatturato, export, redditività, numeri di bottiglie e investimenti. Le aziende selezionate rappresentano oltre il 60% del giro d’affari del settore e sono suddivise tra imprese private e cooperative, per fotografare le diverse dinamiche aziendali. L’obiettivo è mettere in luce le performance più significative – positive o negative – che disegnano lo stato di salute del vino italiano in anni difficili.
Leggi l'articolo >>
Vino e gestione del rischio: affrontare il cambiamento tra mercati e consumatori
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 04/2025 - Luglio
Nel contesto dell’impresa vinicola moderna, il concetto di rischio assume un significato profondamente diverso rispetto al passato. Lontano dall’essere un’anomalia da evitare, oggi il rischio rappresenta una condizione fisiologica, una costante dell’attività d’impresa da conoscere, governare e, quando possibile, trasformare in leva strategica.
Nel settore vitivinicolo – fortemente influenzato da variabili culturali, agricole e identitarie – il rischio ha assunto tradizionalmente forme limitate: eventi climatici estremi, fluttuazioni del cambio per gli esportatori, o crisi produttive. Ma oggi l’evoluzione dei mercati e dei consumi ha ampliato e reso ancor più complesso il perimetro del rischio aziendale.
Su questi temi, lo scorso 2 luglio 2025 abbiamo organizzato uno del ciclo di 3 seminari “Wine on Tour”, a Torrazza Coste (PV), ospiti del Consorzio Vini Oltrepò Pavese, del quale sintetizziamo gli interventi.
Una visione sistemica del rischio
La gestione del rischio nelle imprese vinicole non può più essere affrontata con logiche settoriali. È indispensabile adottare una visione sistemica, capace di cogliere le interconnessioni tra produzione, finanza, compliance normativa, reputazione e distribuzione. Un evento apparentemente circoscritto – come una vendemmia scarsa – può generare effetti a catena: dalla perdita di fiducia nei canali distributivi, fino a difficoltà finanziarie o danni d’immagine.
Le aree di rischio si articolano oggi in quattro grandi categorie: produttivo, normativo, finanziario e – soprattutto – di mercato. È proprio quest’ultima la sfida più complessa, poiché tocca la relazione profonda tra impresa e consumatore, tra identità del prodotto e sua rilevanza percepita.
Gestione del rischio di mercato nel settore vino: adattarsi ai nuovi consumatori per restare competitivi
Nel contesto attuale, il rischio di mercato nel settore vitivinicolo è più che una semplice fluttuazione delle vendite: è il sintomo di un mutamento strutturale dei consumi, delle preferenze e delle percezioni del consumatore. Il rischio di mercato, oggi più che mai, è alimentato da un cambiamento culturale del consumo del vino. Nuove abitudini di consumo, sensibilità salutistiche, contesti d’uso informali, predilezione per bollicine e vini leggeri stanno rivoluzionando la domanda.
Un’azienda focalizzata su rossi corposi da 15°, un tempo premiati dal mercato, può ritrovarsi oggi in difficoltà se non intercetta per tempo i segnali di cambiamento. Il rischio non è solo di vendite in calo, ma di obsolescenza del prodotto: di produrre qualcosa che il mercato non riconosce più come rilevante.
Una gestione strategica di queste dinamiche può quindi trasformare una minaccia in un'opportunità di crescita.
Dall’analisi al presidio del rischio: il ruolo del marketing
In questo contesto, il marketing non è più solo un comparto operativo, ma deve assumere un ruolo strategico. È la funzione deputata a interpretare i comportamenti dei consumatori, leggere i trend competitivi e supportare le scelte di posizionamento e innovazione.
Per governare efficacemente i rischi commerciali legati a mercato e consumatori, serve conoscere e padroneggiare alcuni strumenti chiave. Due, in particolare, si rivelano particolarmente efficaci:
- PEST/PESTLE Analysis, per l’analisi del contesto macro-ambientale (politico-normativo, economico, socio-culturale e tecnologico) e l’individuazione di variabili esterne che, se correttamente interpretate, possono rappresentare anche opportunità. Consente di monitorare fattori diversi, di natura politica (dazi), economia, ambiente, tecnologia digitale, normative (etichettatura alcolici), sostenibilità…
- SWOT Analysis, per confrontare i punti di forza e debolezza interni con le opportunità e minacce esterne, al fine di valutare la sostenibilità di scelte strategiche quali l’ingresso in nuovi mercati, il lancio di prodotti o la diversificazione del business. Permette di valutare capacità produttive, innovazione, brand vs rischi su trend e competitor
Le nuove competenze per un’impresa vinicola resiliente
Gestire il rischio oggi significa dotarsi di nuove competenze. Non basta più “saper fare il vino”. Le aziende vinicole, grandi e piccole, hanno bisogno di strumenti per leggere i dati, comprendere le evoluzioni del contesto, innovare l’offerta e orientarsi al cliente. Questo richiede una transizione culturale profonda: dal focus sulla produzione al presidio attivo del mercato.
Tra le competenze chiave necessarie identifichiamo:
- Analisi dei dati e dei comportamenti di consumo: saper interpretare insight quantitativi e qualitativi (vendite, canali, sentiment online, preferenze emergenti)
- Marketing strategico e digitale: dalla segmentazione all’adattamento della comunicazione nei canali digitali (e-commerce, social, CRM)
- Lettura dei trend e gestione del cambiamento: monitoraggio continuo dei segnali deboli, dei nuovi consumatori e delle tensioni geopolitiche e normative che possono influire sulla domanda
- Innovazione di prodotto e design dell’offerta: sviluppare linee alternative, nuovi formati, vini a basso tenore alcolico o bio, packaging smart e storytelling coerente
- Cultura della customer centricity: non solo ascoltare, ma co-progettare con il cliente, integrando esperienze fisiche e digitali e rafforzando la brand loyalty
- Capacità di misurare e comunicare la sostenibilità: l’attenzione a ESG (Environmental, Social, Governance) diventa leva di differenziazione presso le nuove generazioni e i mercati internazionali
- Competenze narrative e di branding: raccontare il vino non solo per caratteristiche tecniche, ma per valori, storie, legami col territorio, identità del produttore
- Digitalizzazione dei processi commerciali e distributivi: piattaforme di vendita online, gestione omnicanale, logistica intelligente e fidelizzazione automatizzata.
Conclusione: trasformare la minaccia in strategia
Il rischio in azienda vinicola non è un nemico da combattere on da evitare, ma una realtà da conoscere, interpretare e trasformare. I consumatori stanno evolvendo: bevono meno, ma in modo più selettivo, puntano al valore, al benessere, alla trasparenza. Le aziende vinicole che sapranno anticipare i cambiamenti del mercato e comprendere l’evoluzione dei consumatori per poi adattarsi – segmentando l’offerta, innovando format, semplificando linguaggio e investendo in marketing digitale – non solo resisteranno alla contrazione del mercato, ma ne usciranno rafforzate e rilevanti.
In un mondo dove il consumo diventa sempre più selettivo, governare il rischio di mercato significa governare il futuro aziendale. Il vino è cultura, identità, ma anche strategia. E oggi, più che mai, visione manageriale.
Chi fa vino oggi, non fa solo vino. Fa impresa.
Ivan Rossi
Unicredit, diplomato Wine Business Management, 11a edizione
Unicredit, diplomato Wine Business Management, 11a edizione
Wine Newsletter 04/2025 - Luglio
Fare vino, oggi, significa costruire valore lungo l’intera filiera, non solo in vigna o in cantina. L’impresa vitivinicola moderna è un organismo complesso, esposto a rischi tecnici, climatici e – soprattutto – economico-finanziari. Eppure, troppo spesso questi ultimi vengono sottovalutati o affrontati in modo reattivo.
Il paradosso: si può fallire anche con vini premiati
Una peculiarità del comparto è la distanza temporale tra spesa e incasso, che rende strutturale lo squilibrio finanziario. Il ciclo di vita di un vigneto prevede una lunga fase improduttiva: si impianta oggi, si inizia a produrre tra 4 o 5 anni, si rientra dell’investimento forse dopo diversi anni. Anche nella gestione della singola annata, gli investimenti agronomici e di vinificazione sono anticipati rispetto al momento della vendita, spesso di molti mesi, se non anni. Chi produce vini da invecchiamento o lavora con canali a ciclo lungo (come export o horeca), sa bene cosa significa avere magazzino e capitale immobilizzato per lunghi periodi.
Inoltre, il sistema vino è profondamente esposto alla ciclicità del mercato, all’inflazione dei costi di produzione, alla dipendenza da pochi buyer o distributori. Chi lavora in cantina lo sa: basta una campagna vendite sotto le aspettative o un ritardo nei pagamenti per mettere in crisi la programmazione finanziaria. Molte imprese vitivinicole, anche solide dal punto di vista agronomico o commerciale, si trovano in difficoltà perché mancano strumenti strutturati di gestione del rischio economico.
A preoccupare non sono tanto le grandi crisi, quanto le piccole variabili fuori controllo: un cambio sfavorevole, una rata che aumenta, un fornitore che ritarda.
Le minacce invisibili
Ogni decisione, anche tecnica, ha un impatto economico, e spesso non lo vediamo arrivare.
Il rischio di liquidità, in questo contesto, è tra i più sottovalutati. La stagionalità del vino implica flussi in entrata e uscita che non coincidono: si investe oggi per vendere tra sei, dodici o anche ventiquattro mesi. Se l’azienda non dispone di una pianificazione finanziaria dettagliata, rischia di dover fare i conti con la mancanza di liquidità operativa proprio nei momenti chiave: vendemmia, imbottigliamento, promozione. Le banche, per quanto partner potenziali, non sempre supportano l’azienda con la velocità necessaria, e i costi di finanziamento possono aumentare sensibilmente in assenza di un buon rating o di garanzie adeguate.
Un rischio meno visibile, ma altrettanto cruciale, è legato alla concentrazione commerciale. In molti casi, una percentuale significativa del fatturato è legata a un numero ristretto di clienti o distributori, spesso localizzati in pochi mercati. Questa dipendenza rende l’azienda vulnerabile a cambiamenti repentini nei comportamenti di acquisto o nella solidità finanziaria delle controparti. A peggiorare il quadro, manca quasi sempre un sistema strutturato di scoring del cliente condiviso tra le funzioni tecniche e amministrative. Le valutazioni commerciali sono spesso informali o basate su rapporti personali, mentre la gestione del rischio di controparte resta reattiva e poco documentata. Strumenti come l’assicurazione del credito, le fideiussioni, il factoring o le lettere di credito sono ancora poco diffusi, soprattutto tra le piccole e medie cantine. In assenza di queste protezioni, l’insolvenza o il ritardo nei pagamenti di un solo partner commerciale può tradursi in gravi problemi di liquidità e mettere a rischio la stabilità dell’intera filiera produttiva.
I rischi legati al tasso d’interesse sono un altro elemento di fragilità diffusa. Molte aziende vitivinicole hanno contratto mutui o leasing a tasso variabile, magari negli anni in cui l’Euribor era vicino allo zero. L’impennata dei tassi registrata tra il 2022 e il 2024 ha colto molte imprese impreparate, generando un aumento significativo del costo del debito. La differenza di pochi punti percentuali ha trasformato piani di ammortamento sostenibili in zavorre per la gestione. Anche in questo caso, l’assenza di coperture adeguate, come gli swap o le opzioni su tasso, è stata pagata cara.
Per le aziende che esportano, il rischio di cambio rappresenta un fattore cruciale. Vendere in dollari, sterline o yen significa esporsi alla volatilità delle valute. Il rafforzamento dell'euro rispetto alla moneta di riferimento può ridurre drasticamente il margine, soprattutto per i contratti con listini fissi o senza adeguamento valutario. Ma non è solo una questione di margine unitario: quando una valuta estera si deprezza, il potere d'acquisto dei clienti internazionali si riduce e, con esso, anche i volumi esportati. In altre parole, a un certo punto il buyer non compra meno perché il vino costa di più, ma perché può permettersi meno bottiglie. Solo una minima parte delle imprese utilizza strumenti di copertura finanziaria per proteggersi da queste fluttuazioni. In molti casi manca la cultura finanziaria necessaria per comprendere e implementare operazioni di hedging; in altri, non si percepisce la gravità del rischio fino a che l'effetto non è già nei conti.
L'incremento dei costi energetici, dei materiali da imballaggio e della logistica è un ulteriore elemento che ha messo sotto pressione i margini di molte cantine. Bottiglie, cartoni, capsule, trasporti: tutto ha subito rincari anche superiori al 30% nel giro di due anni. Se non si ha una contabilità analitica in grado di calcolare con precisione il costo per bottiglia, si rischia di vendere sottocosto senza accorgersene. Molte cantine continuano a costruire i listini con metodi empirici, legati al posizionamento e alla concorrenza, senza tenere conto delle variazioni strutturali dei costi.
Anche le scelte agronomiche ed enologiche impattano il rischio economico. Optare per vitigni tardivi in zone esposte alla siccità, adottare tecniche costose di affinamento senza avere un mercato pronto ad assorbirne il prezzo, puntare tutto su annate premium in contesti instabili: tutte queste sono decisioni che, se non valutate anche in ottica economico-finanziaria, possono amplificare il rischio complessivo d’impresa. La qualità è imprescindibile, ma la sostenibilità è altrettanto centrale. Sostenibilità intesa non solo in termini ambientali, ma anche di gestione del rischio e visione strategica.
Conoscere, gestire e mitigare il rischio
Il punto di partenza per una gestione efficace del rischio economico-finanziario in cantina è l’adozione di un processo strutturato. Questo processo si articola in alcune fasi chiave: identificazione, analisi, valutazione, gestione e monitoraggio. La una domanda fondamentale in questo processo è quale profilo di rischio siamo disposti a sostenere? Comprendere la propria propensione al rischio, la capacità di assorbirne gli effetti e gli obiettivi strategici dell’impresa è il passo iniziale per selezionare strumenti e soluzioni coerenti.
Una volta che si è compreso quali siano i rischi più rilevanti, è possibile predisporre strategie di mitigazione ex ante, come la diversificazione (di mercati, canali, clienti, ...), le coperture assicurative, la pianificazione finanziaria o l’adozione di strumenti finanziari. Allo stesso tempo, si possono predisporre strumenti di gestione ex post, per rispondere a eventi già in atto: linee di credito flessibili, rinegoziazioni con clienti o banche, dismissioni mirate. La logica non è quella della difesa passiva, ma di una proattiva costruzione di resilienza: anticipare i problemi prima che diventino crisi.
Le contromisure specifiche
Gestire il rischio significa quindi dotarsi di strumenti e processi adatti - in primis, un sistema di controllo di gestione capace di monitorare ricavi, costi e margini effettivi. Adottare un sistema di pianificazione finanziaria dinamica, con scenari alternativi e stress test su cassa e margini, accompagnato ad un processo di forecasting periodico permette di validare l'obiettivo aziendale e correggere in corsa il piano redatto. Poi si arriva agli strumenti tecnici dedicati: assicurazioni sul credito, contratti su valute, strumenti a protezione dei tassi. Serve, soprattutto, una cultura aziendale che integri le competenze enologiche con quelle economico-finanziarie, evitando compartimenti stagni tra produzione e amministrazione.
Un nuovo ruolo per l’imprenditore del vino
In molte realtà questa evoluzione è già in corso: cantine strutturate hanno inserito - direttamente, tramite fractional manager, consulenti o studi esterni - controller, CFO, export finance manager. Ma è fondamentale che anche le piccole e medie aziende comprendano il valore strategico della gestione del rischio. Non servono soluzioni complesse, ma approcci consapevoli. Il rischio non si elimina, si governa. E chi sa farlo bene, oggi, ha un vantaggio competitivo enorme.
Per questo, parlare di rischio economico in cantina non è un discorso da "ragionieri": è una questione di visione imprenditoriale. La capacità di navigare tra incertezze, senza subirle ma anticipandole, è la vera competenza chiave della viticoltura di questo momento storico. La qualità è un prerequisito. La gestione del rischio è una leva strategica. E non è mai troppo presto per iniziare a usarla.
Gestione integrata dei rischi nel settore vitivinicolo
Ottorino Capparelli
Governance, Risk & Compliance Director, Howden Consulting
Governance, Risk & Compliance Director, Howden Consulting
Wine Newsletter 04/2025 - Luglio
Nel contesto attuale, caratterizzato da crescente instabilità normativa, impatti del cambiamento climatico e nuove pressioni da parte di stakeholder e mercati, la gestione integrata dei rischi è diventata una priorità per le imprese del settore vitivinicolo. Questo approccio evidenzia le principali aree di vulnerabilità e le strategie di mitigazione.
Dall'analisi condotta da Howden Consulting (https://www.howdengroup.com/it-it/howden-agricoltura) su un ampio panel di PMI italiane, emerge una significativa discrepanza tra la percezione e la reale esposizione ai rischi. Le aree di vulnerabilità si concentrano in particolare su quattro ambiti: operativo, compliance, finanziario e strategico. Tra le principali criticità riscontrate vi sono l'assenza di politiche formalizzate in materia di cybersecurity, la mancanza di piani di continuità operativa, la scarsa diffusione del Modello 231, la carenza di pianificazione finanziaria strutturata e la limitata integrazione degli obiettivi ESG nei piani aziendali.
Un'attenzione specifica è stata dedicata al tema della gestione della manodopera stagionale per la vendemmia, spesso affidata a cooperative o terzisti mediante appalti o subappalti. Questa prassi, se non adeguatamente presidiata, può esporre le aziende a responsabilità solidali e penali in caso di violazioni in ambito giuslavoristico, previdenziale e di sicurezza sul lavoro. I rischi includono il coinvolgimento – anche indiretto – in fenomeni di sfruttamento lavorativo o intermediazione illecita (Legge 199/2016), con potenziali ricadute reputazionali, legali e ESG. La corretta valutazione e vigilanza sui contratti di appalto rappresenta quindi un presidio strategico.
Sono stati inoltre messi in luce i rischi legati al cambiamento climatico, già visibili attraverso l'aumento di eventi meteorologici estremi come gelate, grandinate e siccità. Sono stati analizzati tre scenari evolutivi – Business as Usual, Transizione ordinata, Frammentazione – con impatti differenziati su rese, qualità e sostenibilità delle coltivazioni. In tale contesto, la resilienza climatica delle aziende diventa una leva di competitività e continuità operativa.
Tra le principali strategie di mitigazione e adattamento si segnalano l'utilizzo integrato di strumenti di difesa passiva come il Fondo Agricat, assicurazioni agevolate e parametriche, fondi mutualistici; l'adozione di tecnologie innovative come la viticoltura di precisione, l'intelligenza artificiale, le biotecnologie, il miglioramento genetico e pratiche di economia circolare. L'integrazione di queste soluzioni consente una gestione più efficace e predittiva dei rischi, migliorando anche l'efficienza produttiva e la sostenibilità ambientale.
In conclusione, l'evoluzione del contesto normativo (CSRD, tassonomia UE, ESG reporting), unita alla trasformazione del mercato assicurativo e alla crescente attenzione degli investitori verso criteri di sostenibilità, impone al settore vitivinicolo un cambio di paradigma. La gestione integrata dei rischi non è più un tema tecnico, ma una componente essenziale della strategia aziendale per tutelare il valore, attrarre capitali e garantire una crescita sostenibile nel lungo periodo.
Costruire un Brand di successo nel mercato del vino: strategie per tempi di incertezza
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2025 - Giugno
In un contesto internazionale sempre più complesso, l'industria vinicola italiana si trova ad affrontare nuove sfide. L'introduzione di dazi statunitensi sui vini europei, annunciata lo scorso aprile, rappresenta una minaccia significativa per il settore (che si tratti di 10 o 25%). Secondo le stime dell'Unione Italiana Vini (UIV), tali misure potrebbero comportare perdite fino a 1 miliardo di euro per l'export italiano, con una contrazione del 25% delle esportazioni verso gli Stati Uniti, il principale mercato di riferimento per il vino italiano.
In questo scenario, ogni azienda vinicola deve adottare strategie proattive per affrontare le nuove dinamiche di mercato. È fondamentale che le imprese prendano in mano il proprio destino attraverso una gestione oculata del marketing. Le riflessioni che seguono possono essere applicate sia alla ridefinizione di un marchio esistente, sia alla creazione di un nuovo brand, eventualmente destinato a un pubblico o a un prodotto differente.
Il marketing è un elemento imprescindibile per il successo di qualsiasi azienda vinicola
Come ha avuto più volte modo di scrivere (https://wbmonline.com.au/shop/) il prof. Larry Lockshin, professore emerito alla South Australia University ed uno dei più brillanti ricercatori australiani, “Il marketing di successo è simile alla gestione di un vigneto di qualità: richiede pianificazione prima dell’impianto e cure costanti nel tempo. Purtroppo, così come alcuni vigneti vengono gestiti senza una visione precisa, molte aziende vinicole operano senza una strategia di marketing coerente”.
In un’azienda vinicola, tutto dovrebbe partire dagli obiettivi e dalla definizione di cosa desidera raggiungere, in modo realistico. Una volta chiariti gli obiettivi, è necessario sviluppare un piano e una strategia concreti. Molti produttori, invece, fissano obiettivi troppo generici o irrealistici rispetto ai tempi e alle risorse disponibili. O non li fissano proprio.
È curioso osservare, secondo Lockshin, come molte cantine investano in consulenze agronomiche ed enologiche, ma trascurino il marketing pensando di poterlo gestire internamente. Come per ogni fornitore, è fondamentale richiedere referenze e confrontarsi direttamente con altri clienti per valutarne l’efficacia. Un buon consulente aiuta a mantenere la strategia realistica e concreta.
Se l'azienda decide di pianificare in autonomia, deve considerare non solo la quantità di vino che può produrre, ma anche quanto potrà realmente vendere e a quali livelli qualitativi. Contemporaneamente alla definizione della strategia produttiva, è necessario pianificare i canali di vendita e stabilire realisticamente quanto vino si potrà vendere e a quali prezzi in ciascun canale. Ad esempio, è importante considerare il prezzo netto che l’azienda incassa, non solo il prezzo di listino.
Che si venda direttamente, tramite importatori, distributori o attraverso vendite a ristoranti, enoteche e negozi, esistono sempre dei costi: operativi, di marketing, scontistiche per i partner commerciali. Vendere direttamente comporta, ad esempio, spese di spedizione, gestione degli ordini e software di e-commerce nell’online; personale, utenze, bottiglie non finite o l’acquisto di nuovi calici in una sala degustazione: tutte voci da includere in un budget, spesso sottostimate o trascurate dalle aziende!
Alla base di tutto, oltre alla strategia, c’è il marchio.
L’obiettivo del marketing è far sì che il marchio venga notato dal consumatore. Se il brand non emerge dallo scaffale, in una carta dei vini o online, non si generano le vendite. Il marchio è quindi la chiave per essere scelti dai consumatori. Ma prima ancora di lavorare sulle etichette o sulla vestizione delle bottiglie, l’azienda deve avere chiari quali valori vuole rappresentare il proprio marchio. Che valore offre al consumatore in cambio del suo investimento? Oggi, quasi tutti i vini garantiscono una qualità adeguata al prezzo: questo è il requisito minimo per entrare nel mercato. Se il "prodotto base" non soddisfa le aspettative, nessun marketing, anche innovativo, potrà compensare questa mancanza, tantomeno un riconoscimento o un premio sporadico.
Ma ammesso che la qualità sia in linea, perché un consumatore dovrebbe scegliere proprio quel vino a 10, 20 o 50 euro anziché un altro simile? Qui entra in gioco l’identità del marchio. Quali sono i valori e la storia che accompagnano il vino? Un bravo esperto di marketing e un ottimo designer, sapranno aiutare l’azienda a tradurre questi concetti astratti in elementi visibili: etichetta, sito web, social media, esperienze in cantina, comportamento del personale.
Non va dimenticato il ruolo dell’inconscio: come ha più volte dimostrato lo stesso Lockshin, i consumatori prendono decisioni d’acquisto rapidamente, basandosi su elementi visivi e sensoriali. Se il vino è riconoscibile per colore, font o logo, le probabilità di essere scelto aumentano notevolmente. Il marketing non deve puntare a essere semplicemente "diverso", ma a essere distintivo e riconoscibile, con una storia propria che sappia parlare al cliente.
Una volta costruita un’identità forte, non va cambiata senza una ragione seria. “Così come non si espianta un vigneto senza motivo, allo stesso modo non si stravolge il marchio, il logo o l’immagine aziendale senza una valida motivazione” scrive Lockshin. Tuttavia, se l’azienda decide di aggiornare il marchio esistente, il cambiamento va fatto gradualmente. I clienti fedeli si riconoscono nell’attuale immagine: un cambiamento drastico potrebbe confonderli. Meglio optare per un’evoluzione graduale nell’arco di diversi anni.
Infine, Lockshin segnala un’opportunità: numerose ricerche dimostrano che il momento migliore per investire nella formazione e nel marketing è proprio durante una crisi. Quando la concorrenza taglia i budget di marketing, rallenta lo sviluppo di nuovi prodotti o non innova nelle sue competenze, le aziende che invece investono in questo campo ottengono performance migliori nel medio e lungo termine. Per chi ne ha la possibilità, questo è il momento ideale per rafforzare i rapporti con i partner commerciali, rilanciare il marketing digitale e cercare nuove opportunità sui mercati internazionali.
Sostenibilità nel settore vinicolo: oltre le promesse, verso un futuro concreto
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2025 - Giugno
La sostenibilità, un tema centrale nel dibattito globale da quasi un decennio, sembrava talvolta vacillare, quasi che il mondo attendesse un suo fallimento.
Tuttavia, come evidenzia una ricerca di Euromonitor International, "The Evolution of Sustainability: Are We Abandoning It?" (Euromonitor, 2024, disponibile qui), questa percezione è fuorviante. Nonostante le sfide e le battute d'arresto, il movimento per la sostenibilità continua la sua evoluzione, trasformandosi da semplice "parola d'ordine" a elemento integrante delle strategie aziendali e delle scelte dei consumatori. Questo cambio di paradigma offre spunti cruciali anche per il settore vinicolo, un comparto profondamente legato al territorio e alle sue risorse.
Il percorso della sostenibilità, segnato da ambiziosi obiettivi come quelli scaturiti dall'Accordo di Parigi del 2015, ha visto aziende di diversi settori impegnarsi in target sfidanti, talvolta con scadenze poco realistiche. Il settore vinicolo non è stato esente da questo entusiasmo iniziale, con molte aziende che hanno abbracciato certificazioni e promesse di riduzione dell'impatto ambientale. Tuttavia, la pandemia del 2020 e le successive crisi geopolitiche ed economiche hanno posto nuove sfide, rischiando di far deragliare alcuni di questi impegni.
Nonostante queste difficoltà, il settore vinicolo dimostra una resilienza e una consapevolezza crescente riguardo alla sostenibilità. Sebbene i dati generali, come quelli riportati da Euromonitor, indichino una flessione nei comportamenti "green" dei consumatori a livello globale (con un calo dei tassi di riciclaggio e della percezione positiva verso gli acquisti sostenibili), è fondamentale analizzare come questa tendenza si declina nel contesto specifico del vino. I consumatori di vino, soprattutto quelli di fascia medio-alta, mostrano una crescente attenzione verso l'origine del prodotto, i metodi di produzione e l'impatto ambientale delle aziende vinicole. La trasparenza e la tracciabilità diventano elementi chiave per conquistare la fiducia di un consumatore sempre più informato ed esigente. Come evidenzia anche un articolo della testata Wine Business, la domanda di vini prodotti in modo sostenibile è in aumento.
Il ruolo dell’innovazione nelle aziende vinicole
Le aziende vinicole, dal canto loro, stanno rispondendo a queste esigenze, spesso andando oltre le semplici dichiarazioni di intenti. L'innovazione gioca un ruolo cruciale in questo processo. Proprio come in altri settori si assiste a un boom di nuovi prodotti con claim di sostenibilità, come sottolinea l'articolo di Euromonitor, anche nel vino si moltiplicano le iniziative concrete.
Pensiamo all'utilizzo di pratiche agricole biologiche e biodinamiche, alla riduzione dell'uso di fitosanitari, alla gestione efficiente delle risorse idriche, all'adozione di energie rinnovabili e all'ottimizzazione del packaging.
L'innovazione nel packaging, in particolare, rappresenta un'area di grande potenziale per il settore vinicolo. La tradizionale bottiglia di vetro, seppur iconica, ha un impatto ambientale significativo in termini di produzione e trasporto. Si stanno esplorando alternative più leggere, materiali riciclati e soluzioni di confezionamento innovative che riducano l'impronta carbonica. L'esempio di altri settori che sperimentano materiali compostabili o riciclati, menzionato nell'articolo di Euromonitor come una delle strategie chiave per integrare la sostenibilità, può ispirare nuove soluzioni anche per il vino.
Tuttavia, la comunicazione della sostenibilità rimane una sfida per molte aziende. Anche nel settore vinicolo, spesso si riscontra un divario tra l'impegno concreto e la sua effettiva percezione da parte del consumatore. Molte cantine investono in pratiche sostenibili ma faticano a comunicarlo in modo efficace, rischiando di non ottenere il riconoscimento meritato. È fondamentale superare la fase delle generiche promesse e concentrarsi sulla narrazione di azioni concrete e misurabili, che dimostrino l'impegno reale dell'azienda verso la tutela del territorio e dell'ambiente.
Il futuro della sostenibilità nel settore vinicolo non dipende solo dalle iniziative delle singole aziende, ma anche dal contesto politico e normativo. Le politiche agricole e ambientali, sia a livello nazionale che europeo, giocano un ruolo cruciale nel definire gli incentivi e i vincoli per le pratiche sostenibili. L'attenzione verso la riduzione dell'uso di pesticidi, la tutela della biodiversità e la gestione delle risorse idriche avrà un impatto significativo sul modo di produrre vino nei prossimi anni, soprattutto alla luce degli effetti dei cambiamenti climatici.
Conclusioni
In conclusione, la sostenibilità nel settore vinicolo non è un trend passeggero o una moda da cavalcare, ma una necessità strategica per garantire la longevità delle aziende e la tutela di un patrimonio unico. Il passaggio da promesse generiche a azioni concrete, supportate dall'innovazione e da una comunicazione trasparente, rappresenta la chiave per affrontare le sfide del futuro e costruire un settore vinicolo più resiliente e rispettoso dell'ambiente. Proprio come la ricerca di Euromonitor evidenzia per altri settori, anche per il vino siamo entrati in una nuova fase della sostenibilità: una fase in cui essa non è più un optional, ma un elemento intrinseco al prodotto, alle operazioni aziendali e alle scelte dei consumatori. La sfida ora è rendere questa integrazione pratica, accessibile ed efficace per tutti gli attori della filiera.
Il vino più sostenibile è quello sfuso?
da Pambianco News, con l'intervento di anche Alberto Serena, CEO di Montelvini, diplomato Wine Business di MIB Trieste
Wine Newsletter 03/2025 - Giugno
Il vino sfuso, servito con impianti alla spina, cresce a volume e a valore, va incontro alle esigenze di diverse tipologie di locali e consumatori ed ha molte altre frecce al suo arco, a partire dai temi legati alla sostenibilità.
→ Vai all'Articolo
Wine Business Management on Tour: seminari gratuiti
Wine Business Management on Tour: Roadshow di seminari gratuiti
Wine Newsletter 03/2025 - Giugno

MIB Trieste School of Management porta in alcuni dei luoghi simbolo della produzione vinicola una serie di Seminari gratuiti di approfondimento, che consentiranno a produttori, consulenti, professionisti e figure tecniche di confrontarsi sui temi più attuali della filiera Wine.
Questi incontri arrivano in un momento molto delicato per il settore, che sta subendo importanti discontinuità strutturali, tra calo dei consumi, rallentamento dei mercati ed export in ri-bilancimento, incognite su dazi e accise, pressione sui margini e nuovi regolamenti UE sull'ESG.
I Seminari del Wine on Tour vogliono offrire strumenti concreti per leggere e anticipare questi cambiamenti, combinando analisi di scenario, casi operativi e momenti di confronto diretto tra operatori.
Gli incontri saranno anche l'occasione per conoscere il Programma in Wine Business Management e alcuni dei suoi protagonisti.
Orari e partecipanti
Gli incontri si svolgeranno sempre dalle 16.00 alle 19.00, per agevolare quanto possibile la partecipazione di chi lavora. Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti a tutti gli interessati, previa registrazione online.
Come funziona?
Esperti e professionisti, selezionati dalla nostra Scuola, guideranno sessioni di approfondimento su temi particolarmente caldi e attuali, che saranno seguite da un dibattito con Q&A dei partecipanti.- Analisi dei mercati - Prospettive 2025, dinamiche on-trade/off-trade, nuovi canali ed export emergenti.
- Trend di consumo - low-no alcol, nuovi consumatori, sostenibilità percepita, pricing.
- Gestione del rischio - Volatilità dei costi di filiera, climate change, coperture assicurative e strumenti finanziari.
- Nuovi ruoli professionali - L’evoluzione dell’enologo-manager, data-driven viticulture e supply-chain integration.
- Distribuzione omnicanale - Dalla logistica integrata al digitale, passando per il retail esperienziale.
E dopo il Seminario?
Ogni tappa si chiuderà con un Aperitivo di Networking, occasione conviviale in cui il Direttore del programma WBM Pierpaolo Penco, studenti e diplomati risponderanno alle domande dei partecipanti e approfondiranno i temi emersi.
-
Conosci il Team del Master
-
Scopri le specializzazioni Wine Business Management
-
Verifica le opportunità di finanziamento e le borse di studio al merito
Come partecipare
La partecipazione è gratuita: è sufficiente compilare un breve form di iscrizione, dopo aver selezionato la tappa di interesse.
A seguire, il team WBM ti contatterà per fornirti tutti i dettagli.
→ Wine on Tour 2025: Scopri le tappe
A seguire, il team WBM ti contatterà per fornirti tutti i dettagli.
→ Wine on Tour 2025: Scopri le tappe
Leadership femminile e transizione del vino: un nuovo asse strategico
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2025 - Aprile
Il comparto vitivinicolo italiano si trova oggi a un punto di svolta. Dopo quarant’anni di straordinaria evoluzione – dalla crisi reputazionale del metanolo del 1986 al consolidamento sui mercati internazionali – il settore è entrato in una fase di transizione profonda, che impone un ripensamento dei modelli di crescita, della struttura produttiva e dell’approccio al mercato.
In passato, la trasformazione ha avuto come driver principali la qualità, la riscoperta dei vitigni autoctoni, l’adozione di pratiche enologiche innovative e una nuova narrazione del vino come simbolo di lifestyle. Da bene alimentare di uso quotidiano, il vino è diventato espressione di cultura, territorio ed esperienza, sostenuto dalla domanda di consumatori Baby Boomers e Gen X, sensibili al valore simbolico del prodotto.
Un nuovo contesto
Oggi, però, il contesto è mutato. Le nuove generazioni consumano meno vino, lo percepiscono in modo diverso e pongono al centro valori come salute, sostenibilità̀, autenticità̀. A ciò si aggiungono pressioni normative crescenti (etichette sanitarie, limiti pubblicitari, restrizioni al consumo), ostacoli commerciali internazionali, incremento della concorrenza e tensioni sui costi di produzione. In breve, siamo alla fine di un ciclo e davanti alla necessità di costruirne uno nuovo.
In questo scenario, la leadership femminile si impone come uno degli elementi chiave per guidare il cambiamento. Non solo per una questione di equità̀ o inclusione, ma per la qualità̀ delle visioni, delle competenze e delle strategie che molte donne stanno portando nelle imprese vitivinicole italiane. Durante il Convegno su “Donne e lavoro”, ospitato nella sede di MIB a Palazzo Ferdinandeo lo scorso 20 marzo, abbiamo visto da vicino alcune di queste esperienze: da Donatella Cinelli Colombini a Marina Cvetič Masciarelli, da Anna Brisotto alla nuova start-up delle sorelle Demontis, fino a quella della nostra Alumna Elena Parovel.
Una nuova Leadership al femminile
Negli ultimi anni, le donne del vino sono diventate protagoniste a tutti i livelli della filiera. Non più soltanto eredi silenziose o figure di supporto, ma imprenditrici consapevoli, enologhe affermate, agronome innovative, export manager competenti, comunicatrici strategiche. Questo cambiamento non è solo quantitativo, ma culturale. Le donne portano una leadership diversa: più orientata alla costruzione di relazioni, alla cura della reputazione aziendale, all’ascolto dei consumatori, alla lettura dei segnali deboli del mercato. Spesso più propense a investire nella formazione, nella collaborazione e nella sostenibilità̀, le donne si dimostrano capaci di integrare sensibilità̀ e pragmatismo nella gestione d’impresa.
Il loro contributo è particolarmente evidente nelle PMI familiari, che costituiscono l’ossatura del tessuto vitivinicolo italiano. Qui, le donne stanno accompagnando con successo fasi cruciali di passaggio generazionale, portando innovazione organizzativa, attenzione alla comunicazione digitale e una governance più aperta. Molte realtà guidate da imprenditrici hanno saputo distinguersi per resilienza e capacità di adattamento anche in periodi critici, come la pandemia o l’attuale rallentamento dei consumi.
Competenze aggiornate per un altro modello
Il settore sta passando da un modello basato sul prodotto a uno fondato sul valore immateriale: reputazione, storytelling, sostenibilità̀, identità̀. In questo passaggio, le donne sono protagoniste naturali. Il loro approccio multidisciplinare, la loro capacità di tenere insieme tradizione e innovazione, la loro sensibilità̀ ai temi ambientali e sociali, costituiscono un vantaggio competitivo di lungo periodo.
A supportare questa evoluzione vi sono anche percorsi formativi specifici. Il Corso executive in Wine Business Management, promosso dal MIB Trieste School of Management, è un esempio concreto di come la formazione possa accompagnare la trasformazione del settore. Nelle sue tredici edizioni, il corso ha visto crescere costantemente la partecipazione femminile, oggi attestata al 40%. Grazie anche alla convenzione con l’Associazione Italiana Donne del Vino, molte imprenditrici e professioniste hanno potuto accedere a un percorso che unisce strategia, marketing, gestione e visione internazionale.
In conclusione, la transizione in atto nel vino italiano non può̀ prescindere dalla valorizzazione delle competenze femminili. La leadership delle donne non è solo un’opportunità̀: è una risorsa strategica per costruire un futuro più̀ solido, sostenibile e connesso con i nuovi bisogni del mercato globale.
Donne nel Vino: da presenza crescente a forza trasformatrice
Giulio Somma
Direttore Corriere Vinicolo
Sintesi dell’intervento introduttivo al Convegno “Donne e Lavoro: Essere Imprenditrici nel mondo del Vino” del 20 marzo 2025
Direttore Corriere Vinicolo
Sintesi dell’intervento introduttivo al Convegno “Donne e Lavoro: Essere Imprenditrici nel mondo del Vino” del 20 marzo 2025
Wine Newsletter 02/2025 - Aprile
È con un senso di responsabilità, e una punta di consapevole imbarazzo, che mi trovo oggi a moderare questa autorevole platea femminile. Un uomo chiamato a stimolare un dibattito che deve essere tutto e solo delle donne, in un settore, quello del vino, dove per secoli – e ancora troppo spesso – la "diversità" è stata rappresentata dalla presenza femminile.
Se oggi il "diverso" sono io, rispetto a un parterre de "Reine", è bene ricordare come ancora troppi uomini si sentano in diritto di parlare delle donne, quando invece sarebbe il momento di agire concretamente per una reale parità di genere. Personalmente, ho sempre cercato di portare il massimo rispetto verso le colleghe e le amiche con cui ho condiviso il percorso professionale e personale, ma non lo considero un merito, bensì un comportamento dovuto.
Confesso una certa idiosincrasia culturale verso quegli uomini che si ergono a paladini dei diritti femminili, soprattutto coloro che si vantano di aver concesso spazi o diritti alle donne in ambito lavorativo, riaffermando così un'egemonia culturale maschile su una conquista che è invece tutta al femminile. Spero di non cadere in questo tranello, pur riconoscendo che, in quanto uomo, il mio sguardo sul tema del gender è inevitabilmente diverso e, auspico, stimolante per il dibattito odierno.
Un contesto in fermento: la leadership femminile conquista nuove vette
Come ci ricordava il Sole24Ore dell'8 marzo, la leadership femminile sta raggiungendo traguardi importanti, sia a livello europeo (con donne ai vertici di Commissione, Parlamento, BCE e BEI) che italiano (con figure di spicco alla guida del Governo, dei principali partiti politici, della Ragioneria dello Stato e della Borsa). Non possiamo dimenticare la prima presidente della Cassazione, Margherita Cassano, e il capo Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, Lina Di Domenico. Nelle aziende quotate, le consigliere hanno raggiunto il 43%, un balzo significativo rispetto al 7% del 2011. Anche il mondo accademico e bancario vede una crescente presenza femminile in ruoli apicali.
Il vino al femminile: una rivoluzione silenziosa ma potente
Cosa succede nel mondo del vino? L'impegno delle donne nel settore vitivinicolo è cresciuto in modo straordinario e continuerà a evolversi nei prossimi anni. Un percorso rivoluzionario, iniziato ben prima che si parlasse di pari opportunità, quote rosa o gender gap, e che ha cambiato, e sta cambiando, il volto di questo mondo. Oggi vediamo sempre più donne raggiungere posizioni di vertice nei consorzi e nelle loro aziende, un traguardo impensabile fino a un decennio fa.
La strada da fare è ancora lunga, ma il trend è chiaro: cresce il numero di giovani donne che scelgono percorsi scientifici e diventano agronome ed enologhe, spesso con risultati eccellenti. Secondo un'indagine di Nomisma Wine Monitor del 2022, sebbene la presenza femminile in vigna e cantina si attesti al 14%, essa si intensifica progressivamente lungo la filiera, raggiungendo l'80% nel marketing e comunicazione, il 51% nelle vendite e il 76% nell'accoglienza enoturistica. La proverbiale capacità femminile di essere multitasking si riflette anche nella gestione di agriturismi e fattorie didattiche, forme di valorizzazione del territorio e della cultura rurale che le vedono protagoniste.
Questa presenza importante è stata accompagnata da una precisa presa di coscienza, testimoniata dalla nascita e crescita dell'associazione Donne del Vino, fondata nel 1988 e oggi con 1200 socie, la più grande e organizzata associazione di enologia al femminile al mondo, apripista per altre realtà nel settore agroalimentare. Ricordo con piacere e orgoglio la nascita, insieme a Donatella Cinelli Colombini, del mensile D-News, che da sette anni racconta le vicende dell'associazione. E nel mondo del giornalismo e della comunicazione del vino, la presenza femminile è ormai quasi totalitaria.
Luci e ombre: il gender gap nel settore vinicolo
Tutto bene, allora? Purtroppo, no. Al di là dei tragici episodi di femminicidio che hanno colpito anche donne del nostro mondo, ma che derivano da logiche di devianza psichica maschile indipendenti dal contesto lavorativo, il gender gap nell'industria del vino è una questione reale e diffusa a livello globale, come recentemente ricordato da Cristina Mercuri.
Secondo diverse ricerche, una percentuale significativa di donne che lavorano nel settore ha subito atteggiamenti violenti (Women in Wine), molte osservano gli uomini essere promossi più rapidamente (Fondazione Libellula), e solo una minoranza occupa posizioni di leadership (Wine Business Monthly). Inoltre, esiste un divario salariale medio tra uomini e donne (Curious Vines), e una percentuale di donne abbandona o richiede il part-time dopo la nascita di un figlio per mancanza di servizi di supporto (Istat).
A pesare su questo gender gap sono bias storico-culturali profondamente radicati: un'industria vinicola a lungo dominata dagli uomini, stereotipi di genere diffusi, difficoltà di accesso alla leadership, doppi standard e discriminazioni, molestie e abusi sul posto di lavoro. Una situazione che porta ancora oggi a sentire affermazioni come quella di Queena Wong: "Quando una donna entra in un'azienda vinicola, deve lavorare il doppio per ottenere la metà del riconoscimento".
Verso una nuova cultura: il ruolo trasformativo delle donne nel vino
Nonostante tutto, il mondo del vino continua ad essere all'avanguardia tra i settori agroindustriali per presenza e ruoli al femminile – Donatella Cinelli Colombini parla di "parità di genere asimmetrica" – dove le donne non sono solo tante e sempre di più, ma hanno iniziato a incidere sui processi di sviluppo del comparto.
Ed è proprio su questo punto che desidero soffermarmi e concludere questa breve riflessione iniziale, perché è qui che vorrei sollecitare le relatrici che ascolteremo. Riprendendo il Sole24Ore: "Mai c'erano state tante donne al potere. Mai, dunque, una così ampia possibilità di fare la differenza per le altre. Sarà anche su questo fronte che verranno giudicate". Insomma, faranno la differenza?
Riportando questa domanda nel nostro contesto: la diversità di genere nel lavoro, nella gestione e conduzione delle aziende vinicole ha portato o porterà ad una reale differenza di cultura manageriale e imprenditoriale?
Oggi più che mai, il momento di grande difficoltà che sta attraversando il vino ha un gran bisogno di un pensare e un agire diverso. Di fronte a un futuro incerto, dove il vino sembra più un pugile suonato che un atleta palestrato, mi permetto una provocazione: tra tante analisi e ricette già viste, non ho ancora riscontrato, forse per mia distrazione, una lettura al femminile della crisi che stiamo attraversando. Sono ancora prevalentemente gli uomini a parlarne. Perché?
Sono convinto – anche per tante esperienze dirette – che oggi più che mai servirebbero sensibilità e lucidità diverse, capacità di intuire e gestire complessità dove la cultura femminile – proprio per la sua radicale diversità da quella maschile – potrebbe rivelarsi decisiva. Se ancora questa voce non è emersa dal gran brusio, spero che dalle testimonianze che ascolteremo oggi uscirà qualche suggestione, un'idea che potrebbe aiutarci a immaginare in maniera nuova il futuro.
Per questo motivo ho invitato le relatrici a evidenziare le specificità al femminile delle loro storie, mettendo in luce, laddove possibile, le differenze che hanno marcato le loro esperienze rispetto a quelle simili gestite da uomini.
Il Vino si tinge di rosa: cresce l'impegno per valorizzare il ruolo delle donne
Pierpaolo Penco
Responsabile area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2025 - Aprile
Negli ultimi anni, il mondo del vino sta assistendo a una crescente attenzione verso il ruolo e il contributo fondamentale delle donne. Un tempo relegate a ruoli marginali o di supporto, le professioniste del vino stanno emergendo con forza, conquistando posizioni di leadership, influenzando le scelte produttive e lasciando un segno indelebile nel panorama enologico globale. Questa evoluzione non è solo un segnale di un settore che si apre a una maggiore inclusività, ma anche un riconoscimento del talento, della competenza e della sensibilità che le donne apportano a ogni fase della filiera, dalla vigna alla cantina, dalla comunicazione al mercato.
Nuove Fiere di settore
Un indicatore tangibile di questo cambiamento è la proliferazione di eventi e organizzazioni specificamente dedicate a celebrare e supportare le donne nel vino. Tra questi spicca la Women in Wine Expo, un'iniziativa internazionale che ha fatto della promozione della parità di genere la sua missione principale. Nata nel 2019 con le prime edizioni in Belgio e nei Paesi Bassi, la Women in Wine Expo ha rapidamente guadagnato prestigio, ospitando eventi di alto livello in Georgia (2022), nel Regno Unito (2023) e, più recentemente, in Portogallo (2024). Queste esposizioni non sono semplici vetrine per i vini prodotti da donne, ma rappresentano importanti momenti di networking, di scambio di conoscenze e di ispirazione per le professioniste del settore provenienti da tutto il mondo. L'obiettivo è chiaro: elevare il profilo delle donne nel vino, fornire loro strumenti per la crescita professionale e sensibilizzare l'intera industria sull'importanza di una rappresentanza equa e inclusiva.
I Consorzi Vinicoli
L'impegno per valorizzare il talento femminile si manifesta anche attraverso la nascita e l'affermazione di concorsi vinicoli pensati appositamente per dare risalto alle produzioni delle donne. L'International Women's Wine Competition e i Women's Wine & Spirits Awards sono due esempi emblematici di come il settore stia cercando di superare dinamiche di genere che spesso hanno penalizzato le enologhe e le produttrici. Questi concorsi non solo offrono una piattaforma per premiare l'eccellenza dei vini femminili, ma svolgono anche un ruolo cruciale nell'educare i consumatori e nel mettere in luce le specificità e la qualità che le donne apportano alla produzione vinicola. In particolare, i Women's Wine & Spirits Awards si distinguono per avere una giuria composta esclusivamente da acquirenti di vino e spirits, offrendo una prospettiva unica sulle preferenze del mercato femminile e contribuendo a sfatare stereotipi di genere nel consumo di alcolici.
Altre Organizzazioni a supporto delle Donne nel Vino
Accanto agli eventi e ai concorsi, un ruolo fondamentale è svolto dalle organizzazioni che si dedicano attivamente al supporto e alla promozione delle donne nel vino.
Women of the Vine & Spirits, con la sua portata internazionale, rappresenta una comunità globale impegnata a sostenere le donne in tutti i settori dell'industria delle bevande alcoliche. Attraverso eventi, programmi di mentorship e risorse formative, l'organizzazione mira a creare un ambiente di lavoro più equo e inclusivo, offrendo alle donne gli strumenti necessari per avanzare nella loro carriera e raggiungere posizioni di leadership.
In Italia, Le Donne del Vino rappresenta una realtà consolidata e influente. Fondata nel 1988, l'associazione riunisce oltre mille professioniste del settore, tra produttrici, enologhe, sommelier, ristoratrici, giornaliste ed esperte di marketing, alcune delle quali frequentano regolarmente i Corsi in Wine Business di MIB Trieste. Le Donne del Vino non solo promuovono la cultura del vino attraverso eventi e iniziative, ma si impegnano attivamente per favorire la crescita professionale delle socie, per combattere gli stereotipi di genere e per valorizzare il contributo femminile alla storia e all'innovazione del vino italiano.
Conclusione
Questa crescente attenzione al ruolo delle donne nel vino non è solo una questione di giustizia e di pari opportunità, ma anche una risorsa preziosa per l'intero settore. La diversità di genere porta con sé nuove prospettive, approcci innovativi e una maggiore sensibilità verso le esigenze di un mercato sempre più complesso ed esigente, come emerso anche dal Convegno su “Donne e lavoro” ospitato dal MIB lo scorso 20 marzo 2025.
In conclusione, il mondo del vino sta vivendo una fase di trasformazione significativa, in cui il contributo delle donne è finalmente riconosciuto e valorizzato in tutta la sua pienezza. Gli eventi, i concorsi e le organizzazioni dedicate rappresentano segnali tangibili di questo cambiamento, ma sono anche strumenti potenti per accelerare ulteriormente il processo di inclusione e per costruire un futuro del vino più equo, diversificato e ricco di talento femminile. Il "vino si tinge di rosa" non è solo un'immagine evocativa, ma una realtà in continua evoluzione, destinata a lasciare un segno indelebile nella storia dell'enologia mondiale.
Wine Business - Sfide e Trend 2025: cosa avere nel proprio bagaglio
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2025 - Marzo
Il 2024 ha evidenziato una crescita delle vendite in valore, nonostante un calo dei volumi venduti, con i consumatori che hanno privilegiato vini di fascia alta, confermando la polarizzazione verso prodotti di qualità.
All’inizio del 2025 il settore vitivinicolo internazionale si trova a fronteggiare una serie di sfide e opportunità, che richiedono competenze manageriali avanzate.
Le principali sfide e i trend emergenti, evidenziate da diverse fonti, sono:
- Cambiamenti nelle preferenze dei consumatori: si osserva una crescente attenzione verso il consumo moderato, con un aumento della domanda di vini a basso contenuto alcolico o totalmente dealcolati
- Instabilità geopolitica e commerciale: Le tensioni commerciali internazionali, come i dazi imposti da alcuni paesi, influenzano le esportazioni. In attesa delle decisioni annunciate dalla nuova Amministrazione USA, si teme un “effetto domino” nei dazi alle esportazioni, con la possibilità che altri paesi si uniscano nell’imposizione di tariffe, con conseguenze negative per il settore
- Cambiamenti climatici: gli eventi climatici estremi stanno influenzando la produzione vinicola, richiedendo strategie di adattamento e resilienza
- Evoluzione del mercato: il mercato dei vini fermi affronta sfide cruciali come inflazione, moderazione, premiumisation e instabilità geopolitica. I produttori sono chiamati a innovare per conquistare consumatori più esigenti e consapevoli
Saper pianificare all’interno di scenari diversificati
Per navigare efficacemente in questo contesto complesso, occorre dotarsi di capacità e competenze specifiche. Manager con formazione tecnico-produttiva devono integrare le loro conoscenze con abilità gestionali, mentre quelli con background commerciale devono comprendere le dinamiche produttive. Le soft skills, come la capacità di adattamento, la leadership e la gestione del cambiamento, sono cruciali per gestire sistemi sempre più competitivi e interconnessi.
Nel settore vinicolo, la capacità di pianificare scenari diversi è fondamentale per garantire la crescita e la sostenibilità dell’azienda. Questo implica un’attenta analisi dei trend di mercato, considerando l’evoluzione delle preferenze dei consumatori, l’aumento della domanda di vini biologici e naturali, e l’impatto delle nuove tecnologie nella produzione e distribuzione.
- Il contesto geo-politico
- Le mutabili preferenze dei consumatori
- I vini dealcolati
- Le strategie ESG
- Le strategie innovative
Conclusioni
In un settore in continua evoluzione come quello vitivinicolo, per affrontare queste sfide, è indispensabile investire nella formazione continua, aggiornandosi sulle nuove tecnologie di vinificazione, sulle strategie di marketing digitale e sulle normative internazionali del settore. Una solida visione strategica, unita alla capacità di anticipare le tendenze del mercato e alle competenze nella gestione della filiera produttiva, permette di sviluppare piani d’azione efficaci, garantendo la competitività dell’azienda e la valorizzazione del territorio.
A novembre 2025 MIB Trieste darà vita alla XIII edizione del Corso in Wine Business Management, percorso che vede al centro della propria didattica proprio il trasferimento ai partecipanti di competenze chiave per affrontare queste sfide, anche grazie alla condivisione di esperienze aziendali e aggiornate best practice provenienti da realtà diverse, in alcuni casi esterne al settore del vino ma che possono portare al vino stesso nuove prospettive e chiavi di lettura.
Sostenibilità e packaging del vino: verso una bottiglia "naked"?
Ivan Rossi, MBA (Diplomato XI edizione del Corso in WBM)
Wine Newsletter 01/2025 - Marzo
"Non ereditiamo la terra dai nostri antenati, la prendiamo in prestito dai nostri figli." - Proverbio nativo americano.
Questo principio si applica perfettamente al settore vitivinicolo, dove la sostenibilità sta diventando un criterio imprescindibile. Il packaging del vino, in particolare, è oggi al centro di un dibattito: come ridurre l'impatto ambientale senza sacrificare identità e appeal del prodotto? In questo scenario, si fa strada l'idea della bottiglia "naked", ovvero priva di capsula.
Le funzioni base: igienico-sanitarie, preservazione e amministrative
La capsula non fa parte solo dell’estetica della bottiglia: svolge un ruolo importante per la protezione della chiusura e per garantire la qualità del vino, proteggendolo da contaminazioni esterne e fungendo da barriera contro polvere, batteri e parassiti (La Repubblica). In ambienti umidi, come le cantine da affinamento, rappresenta una barriera contro le infestazioni, come la tignola, le cui larve possono danneggiare il sughero compromettendo la qualità del vino (Vigne, Vini e Qualità).
Inoltre, aiuta a limitare il contatto con l'aria, rallentando il processo di ossidazione. Questo è particolarmente utile per i vini destinati all’invecchiamento, che beneficiano del sigillo aggiuntivo offerto dalla capsula per mantenere il tappo integro nel tempo.
In ultimo, la capsula può assolvere anche a funzioni “amministrative” e di segnalazione. Ad esempio, in Francia il capsule congé, un sigillo fiscale tondo posto sopra la copertura del tappo, attesta che sulla bottiglia è stata pagata l'imposta sul valore aggiunto. Il colore del capsule congé varia a seconda della categoria del vino: per i vini a denominazione di origine controllata (AOC), come lo Champagne, il bollino è stampato in verde. Queste normative non solo garantiscono la qualità e l'origine dei vini, ma aiutano anche i consumatori a riconoscere rapidamente la categoria del vino attraverso elementi visivi come il colore e le diciture sull'etichetta.
Branding, immagine e riconoscibilità - La capsula come vettore
Sebbene la capsula possa sembrare un elemento secondario, essa svolge un ruolo fondamentale nella costruzione del brand e nella riconoscibilità del prodotto, fornendo uno spazio aggiuntivo per il marchio e la promozione dell'immagine di un'azienda vinicola.
In Germania, alcuni produttori di Riesling utilizzano colore e forma per indicare specifiche caratteristiche qualitative del vino, offrendo ai consumatori un'indicazione visiva immediata. Questa pratica, sebbene non standardizzata a livello nazionale, è adottata da diverse cantine per comunicare informazioni aggiuntive sul prodotto. Termini come "Goldkapsel" (capsula dorata) o "Lange Goldkapsel" (lunga capsula dorata) sono utilizzati per designare imbottigliamenti speciali, spesso con una concentrazione e complessità superiori.
Alcune regioni vitivinicole ne hanno fatto un simbolo distintivo, che va oltre la mera funzionalità di protezione del tappo. Nel 2009, i produttori altoatesini hanno introdotto una capsula comune che riporta sulla testa la dicitura “Südtirol” con relativo logo per rafforzare la riconoscibilità dei loro vini. Questa iniziativa mirava a coinvolgere l'intera produzione a denominazione di origine, sottolineando l'importanza dell'origine geografica e della qualità associata. Come nel Sudtirolo, anche in Austria con la banderole rosso bianco rosso, nel Collio con il distintivo color giallo e nel Chianti Classico con il galletto, la capsula è parte integrante e caratteristica dell’identità visiva del vino. Nel caso dello Champagne, addirittura, il Comité Champagne ha sottolineato che una bottiglia priva di coiffe potrebbe essere effervescente (AIS Lombardia). Essa, infatti, rappresenta un elemento di continuità con la tradizione e trasmette un senso di autenticità e qualità.
È evidente come la capsula racchiuda elementi di design che contribuiscono a costruire l’esperienza di prodotto: basti pensare che tra due persone sedute a tavola il collo della bottiglia si trova sempre all’altezza degli occhi. Non solo, in contesti come i ristoranti, le feste o i catering, dove le bottiglie possono essere disposte in orizzontale o immerse in glacette, la capsula diventa l'unico elemento di packaging visibile. In queste situazioni, la sua assenza potrebbe penalizzare la visibilità e la riconoscibilità del brand, compromettendo la capacità del prodotto di distinguersi dagli altri.
Questo è particolarmente vero per vini di alto valore, dove ogni dettaglio del packaging contribuisce a comunicare il prestigio e la qualità del prodotto. Non a caso, come per le etichette, è stata resa disponibile una versione fluo grazie ad una nuova tecnologia di stampa che consente di illuminare marchi o messaggi al buio esponendo la bottiglia alle luci UV, consentendo di illuminare dettagli, di svelare un messaggio nascosto invisibile alla luce del giorno, e trasformare il singolo prodotto in un punto di attenzione.
La sostenibilità come nuovo imperativo
Negli ultimi anni, la sostenibilità è diventata un tema centrale in quasi tutti i settori, e l’industria del vino non fa eccezione. Il packaging è stato uno dei primi ambiti di intervento: il ruolo della capsula è stato profondamente ripensato e messo in discussione, con diverse soluzioni che spaziano dal ripensamento dei materiali impiegati fino a soluzioni radicali, quale la bottiglia “naked”.
La capsula è spesso costituita da alluminio, stagno o plastiche. Questi materiali, pur offrendo una buona protezione per il tappo e un’estetica piacevole, presentano notevoli problematiche in termini di impatto ambientale. Le capsule tradizionali contribuiscono all'inquinamento e alla produzione di rifiuti: anche quando vengono utilizzati materiali potenzialmente riciclabili come il metallo, il processo di produzione e riciclo richiede energia, e spesso finiscono in discarica anziché essere riciclate. Eliminandole, si riduce la quantità di rifiuti prodotti e si contribuisce a un approccio più sostenibile nel packaging del vino. Retailer come Berry Bros & Rudd e Waitrose hanno già eliminato le capsule da alcune linee di prodotto a marchio proprio per ridurre i rifiuti da imballaggio, riscontrando feedback positivi dai consumatori attenti all'ecologia.
Le capsule rappresentano un costo aggiuntivo sia alla produzione del vino che alle spese aziendali, specialmente con le nuove normative sulla responsabilità estesa del produttore in materia di imballaggi. Eliminandole, i produttori possono ridurre gli oneri di produzione e destinare le risorse ad aspetti più critici, come la gestione dei vigneti e le tecniche di vinificazione, contribuendo a contenere i prezzi per i consumatori.
Oltre al loro impatto negativo sull’ambiente, le capsule in stagnola si trascinano anche una questione etica. Le miniere hanno effetti devastanti sull’ambiente legati allo sconvolgimento di fauna e flora del territorio, contaminazione delle acque ed inquinamento del suolo; inoltre, nelle nazioni dove si trovano spesso non vengono rispettati i diritti dei lavoratori e si ricorre al lavoro minorile.
Materiali alternativi: un futuro più green?
Molti attori della filiera vitivinicola hanno colto l’opportunità di testare alternative più sostenibili, aiutati anche dalle recenti novità in ambito di normative europee: ad esempio, il Regolamento UE 2023/1606 ha introdotto la possibilità di eliminare le capsule nei vini spumanti, offrendo ai produttori maggiore libertà di scelta.
La ricerca di materiali alternativi ha condotto alla sperimentazione di nuove soluzioni con impatti ambientali più ridotti. Alcuni produttori stanno esplorando alternative come strisce di carta sigilli di ceralacca o nuove chiusure, in quanto l'eliminazione totale potrebbe essere una rivoluzione troppo radicale per un mercato ancora legato alla tradizione.
Moët & Chandon, in collaborazione con Amcor, ha recentemente sviluppato una capsula "Essentielle" composta da alluminio e carta, eliminando completamente l'uso della plastica e riducendo del 31% l'impronta di carbonio rispetto alle soluzioni tradizionali.
Il caso di Champagne Telmont è emblematico: per la sua cuvée biologica lanciata nel 2023, Telmont ha eliminato non solo la capsula in alluminio, ma anche il muselet e la placca metallica, utilizzando un semplice sistema di chiusura con spago. Questa scelta rappresenta non solo un'estetica innovativa, ma anche un impegno concreto verso la sostenibilità, riducendo l'uso di materiali complessi da smaltire.
Nel contesto italiano, un esempio di approccio sostenibile viene dalla cantina Salcheto, che ha introdotto una bottiglia leggera con una capsula in PET riciclato e riciclabile, in linea con la sua filosofia di riduzione dell'impatto ambientale.
Inoltre, aziende come Sparflex hanno sviluppato una soluzione più piccola e leggera, realizzata con materiali come il polietilene derivato dalla canna da zucchero o materiali riciclati, per ridurre ulteriormente il consumo di risorse.
Enoplastic, uno dei leader nel settore delle soluzioni di chiusura per il vino, ha lanciato diverse capsule eco-sostenibili, tra cui "Absolute Green Line", un polietilene a base biologica con inchiostri a base d'acqua, e "PET+", un'alternativa sostenibile al PVC. Queste innovazioni rappresentano un passo importante verso la riduzione dell’impatto ambientale del settore.
Andare "Naked": vantaggi e trade-off
In questo contesto, la domanda che sorge spontanea è: si può davvero rinunciare alla capsula? Come reagiscono i consumatori? La risposta non è semplice e dipende da una serie di fattori, tra cui la percezione dei consumatori, il posizionamento del brand e gli obiettivi di sostenibilità dell'azienda.
La capsula rappresenta un elemento del packaging che è stato riconsiderato alla luce della crescente attenzione all’ambiente. L'idea dell’eliminazione ha vantaggi concreti: riduzione dei costi, minore impatto ambientale e posizionamento sostenibile del brand. Sebbene le capsule abbiano una valenza storica, la loro assenza può trasmettere un messaggio di autenticità e trasparenza: alcuni appassionati di vino apprezzano la possibilità di osservare direttamente il tappo, valutandone l'aspetto e le condizioni. Inoltre, la sua rimozione può semplificare il processo di apertura della bottiglia, offrendo un'esperienza più diretta e genuina
Mentre una parte del mercato apprezza la riduzione dei rifiuti, altri potrebbero percepire l'assenza della capsula come una perdita di valore e status. Secondo alcuni studi, il packaging influenza significativamente la decisione d'acquisto: una bottiglia “naked” potrebbe apparire meno curata o di minor valore con un impatto sulla percezione complessiva del prodotto. Questo è particolarmente vero per i vini premium, dove ogni dettaglio è studiato per comunicare esclusività e raffinatezza. Senza la capsula, una bottiglia potrebbe apparire "nuda" o incompleta, soprattutto per quei consumatori abituati alla ritualità dell'apertura, che inizia proprio con la rimozione della capsula.
Possiamo fare a meno della capsula?
La risposta non è univoca. L’equilibrio tra sostenibilità, branding e percezione del consumatore è la vera sfida. Sarà il mercato a decretare il successo di queste innovazioni: la domanda da porsi non è solo se la bottiglia “naked” sia possibile, ma se i consumatori siano pronti ad accoglierla.
Al momento il movimento di pensiero a favore di una bottiglia “naked” è principalmente guidato da piccoli produttori, con le associazioni di categoria, come abbiamo visto per lo Champagne, posizionarsi fermamente con una opinione contraria. Nulla esclude però che una grande azienda del vino, magari spinta principalmente dalle economie estraibili che da motivazioni “green”, aderisca opportunisticamente.
Ciò che è certo è che il dibattito sull’uso della capsula non è solo una questione di estetica o tradizione, ma riguarda anche l'identità del vino, la sua qualità percepita e la sostenibilità del processo produttivo. Il cambiamento verso una bottiglia più "naked" potrebbe rappresentare una nuova era per il packaging del vino, ma richiede una riflessione profonda sulle implicazioni a livello di branding, di esperienza del consumatore e di salvaguardia dell’ambiente.
Quanto costa produrre una bottiglia di vino?
Wein-Plus
Un articolo sui costi di produzione in Germania
Un articolo sui costi di produzione in Germania
Wine Newsletter 01/2025 - Marzo
La rivista Wein-Plus ha provato a calcolare il costo, dalla produzione allo scaffale, di una bottiglia di vino, prendendo in esame la realtà tedesca. Un interessante punto di partenza di un argomento gestionale chiave che, nel Corso in Wine Business Management, viene approfondito nella parte sul Controllo di Gestione.
→ Leggi l'articolo
Donne e Lavoro 2025: Essere Imprenditrici nel Mondo del Vino
Eventi
Wine Newsletter 01/2025 - Marzo
Si avvcina l'ottava edizione della serie "Donne e Lavoro", un evento a cura di MIB Trieste School of Management, Univeersità degli Studi di Trieste e AIDDA-Associazione Italia Donne Imprenditrici e Dirigenti d'Azienda.
Quest'anno il focus è dedicato a un settore fortemente correlato al nostro territorio, quello del Vino.
“Essere Imprenditrici nel mondo del Vino", questo il titolo dell'evento, accoglie numerosi punti di vista con imprenditrici d'eccezione e la moderazione della Tavola Rotonda a cura di Giulio Somma, Direttore del Corriere Vinicolo.
Ascolteremo le voci di Marina Cvetič Masciarelli, Donatella Cinelli Colombini, Elena Parovel, Elena Roppa, Anna Brisotto, Alice e Giorgia De Montis.
→ Programma e Registrazione all'evento
Ripensare il modo di fare marketing del vino verso le giovani generazioni
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2024 - Ottobre
Un linguaggio visivo più dinamico ed esperienze immersive
Le giovani generazioni presentano gusti e aspettative diverse rispetto alle generazioni precedenti, e il mondo del vino deve adattarsi per rimanere rilevante. Il marketing tradizionale del vino, spesso legato a un'immagine classica e formale, fatica a connettere con un pubblico abituato a un linguaggio visivo più dinamico e a esperienze più immersive. Per attrarre i giovani, è necessario creare un nuovo storytelling che sia autentico, coinvolgente e in linea con i loro valori. Questo significa uscire dagli schemi, utilizzare un linguaggio più semplice e diretto, valorizzare la sostenibilità e creare esperienze uniche che vadano oltre la semplice degustazione.
Come ha scritto il Master of Wine Tim Hanni in un post su Linkedin, che di seguito riprendiamo, l'industria del vino deve smettere di pensare ai Millennial, alla Generazione Z o a qualsiasi altro segmento demografico come segmenti uniformi con valori e aspirazioni condivisi. “Sono tutt'altro che masse amorfe ed esistono opportunità significative da capitalizzare suddividendo questi gruppi in categorie più specifiche in base a una serie di fattori, tra cui preferenze, atteggiamenti, comportamenti, aspirazioni, geografia, istruzione, stile di vita e finanze”. Sebbene sia facile generalizzare queste generazioni come portatrici di valori o modelli di consumo simili, nella realtà sono incredibilmente diverse nel loro approccio al vino. Non tutti, ad esempio, sono interessati o aspirano alle stesse esperienze. “Alcuni possono cercare di saperne di più sul vino, aspirare a una qualità definita da esperti o seguire corsi di educazione al vino, ma molti altri non condividono queste aspirazioni”. Inoltre, esistono modelli di consumo molto differenti tra i giovani italiani, statunitensi o cinesi!
Lavorando sui segmenti demografici
Alcuni segmenti all'interno di questi segmenti demografici possono abbracciare la scoperta del vino, l'educazione e le esperienze come l'abbinamento vino-cibo, o cercare stili di vino specifici come i vini minerali o biologici. Altri cercano opzioni piacevoli e convenienti che si adattino al loro stile di vita senza bisogno di un apprendimento più approfondito (magari in lattina o a bassa gradazione alcolica). Questa varietà di motivazioni sottolinea la necessità per il settore del vino di evitare di trattare queste generazioni come un'unica entità con preferenze uniformi e di abbracciare invece una segmentazione di marketing che tenga conto dell'intero spettro dei comportamenti, dai bevitori occasionali agli intenditori di vino.
Tendenze come la moda, il desiderio di apparire conoscitori o di godersi il vino con gli amici influenzeranno sempre il comportamento dei consumatori, ma la diversità delle preferenze (che tiene conto delle differenze fisiologiche e psicologiche degli individui) rimarrà costante. “L'industria del vino deve imparare ad abbracciare, comprendere e comunicare con tutti i consumatori, riconoscendo che alcuni vorranno esperienze guidate da esperti mentre altri no”.
Come adeguare le strategie di marketing
Le strategie di marketing del vino dovrebbero quindi essere modellate da dati e comportamenti accurati, concentrandosi su modelli osservabili di come gli individui di queste generazioni scoprono e interagiscono con il vino. Questo cambiamento richiede che il settore sia flessibile, capace di innovare e di riconoscere che, “mentre alcuni consumatori potrebbero essere attratti dall'educazione più tecnica al vino, una parte significativa dei consumatori più giovani sarà invece guidata più dal piacere e dalla convenienza che dal desiderio di seguire i tradizionali percorsi di apprezzamento del vino”. Comprendere e soddisfare questa diversità di preferenze aiuterà i marchi a connettersi in modo più significativo con i consumatori e a rimanere rilevanti tra le generazioni.
Il vino si racconta: come conquistare i giovani con un nuovo storytelling
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2024 - Ottobre
Il mondo del vino sta vivendo un momento di profondo cambiamento. Le nuove generazioni, sempre più attente a gusti e tendenze in continua evoluzione, sembrano prediligere birre artigianali, cocktail ricercati e bevande low o no-alcohol. Come può il vino, con la sua tradizione secolare, competere in un mercato così dinamico? La risposta sta nell'innovazione dello storytelling.
Perché il vino deve cambiare il modo di comunicare?
- Gusti in evoluzione: I giovani consumatori sono alla ricerca di esperienze uniche, di prodotti che raccontino una storia e che si allineino ai loro valori.
- Concorrenza agguerrita: Birre artigianali e cocktail offrono un'immagine più fresca e moderna, spesso associata a momenti di convivialità e divertimento.
- Canali di comunicazione digitali: I social media e i nuovi media hanno cambiato radicalmente il modo in cui comunichiamo. Il vino deve sapersi adattare a questi nuovi canali.
Come innovare lo storytelling del vino
- Uscire dagli schemi: Il vino non è solo un prodotto da degustare, ma un'esperienza da vivere. Invece del prodotto in quanto tale, bisogna raccontare storie di persone, di territori, di passioni.
- Linguaggio inclusivo: è necessario evitare un linguaggio troppo tecnico o elitario. Si deve, invece, utilizzare un tono di voce semplice e diretto, che possa essere compreso da tutti.
- Valorizzare la sostenibilità: I giovani sono sempre più attenti all'impatto ambientale. Ecco perché è importante sottolineare le pratiche sostenibili adottate in vigna e in cantina (se si praticano!).
- Creare esperienze uniche: le cantine devono organizzare eventi, degustazioni guidate, visite in cantina, coinvolgendo i consumatori in modo attivo.
- Utilizzare i social media: ogni cantina deve sfruttare al massimo le potenzialità dei social media per creare contenuti visivamente accattivanti e interattivi.
- Collaborare con influencer: selezionando con cura quelli “veri” da quelli che non hanno un reale seguito, è possibile coinvolgere influencer del mondo del food e del beverage per ampliare l’audience. Il microblogging o i microinfluencer, ad esempio, che si rivolgono a un pubblico più limitato ma realmente interessato al vino, possono fornire i migliori risultati.
- Raccontare storie di persone: Mettere al centro le persone che lavorano in vigna e in cantina è un’ottima tattica. Le loro storie sono un modo autentico per avvicinare i consumatori al mondo del vino.
Ecco un paio di esempi concreti di come un'azienda vinicola potrebbe innovare il proprio storytelling per attrarre le giovani generazioni:
Esempio 1: Un'esperienza immersiva attraverso la realtà virtuale
Idea: Creare un'esperienza di realtà virtuale che trasporti l'utente direttamente nella vigna.
Come funziona: Tramite un visore VR, l'utente può "passeggiare" tra i filari, ascoltare il suono del vento tra le foglie, sentire il profumo dell'uva matura e osservare da vicino le fasi della vendemmia.
Perché funziona: Un'esperienza così coinvolgente e sensoriale permette ai giovani di creare un legame emotivo con il prodotto e di apprezzare la complessità che si nasconde dietro una semplice bottiglia di vino.
Canali di diffusione: Questa esperienza potrebbe essere promossa sui social media, nei wine bar e nelle enoteche, e potrebbe essere offerta come un'attività aggiuntiva durante le visite in cantina.
Esempio 2: Una collaborazione con un'artista di strada
Idea: Invitare un artista di strada a dipingere un murale personalizzato sulla facciata della cantina.
Come funziona: L'artista crea un'opera d'arte che racconta la storia del vino e del territorio, utilizzando un linguaggio visivo contemporaneo e accattivante.
Perché funziona: Il murale diventa un punto di riferimento per la comunità locale e un'attrazione per i turisti. Inoltre, l'arte di strada è un linguaggio che i giovani apprezzano e condividono sui social media.
Canali di diffusione: Organizzare un evento di inaugurazione del murale, invitando influencer e giornalisti. Creare una campagna social media dedicata all'opera d'arte.
Altri esempi di storytelling innovativo:
Podcast: Creare un podcast in cui si intervistano viticoltori, sommelier e appassionati di vino.
Webinar: Organizzare webinar tematici su argomenti come l'abbinamento cibo-vino, la sostenibilità in viticoltura o la storia del vino.
Contenuti video: Realizzare video brevi e coinvolgenti per i social media, come tutorial sulla degustazione, ricette con il vino o interviste ai produttori.
Conclusioni
Il vino ha un enorme potenziale per conquistare le nuove generazioni. Basta saper raccontare una storia autentica, coinvolgente e in linea con i valori dei giovani consumatori. L'innovazione dello storytelling è la chiave per aprire le porte a un nuovo pubblico e per garantire un futuro al mondo del vino.
L'obiettivo è creare un racconto autentico e coinvolgente che risuoni con le nuove generazioni. Il vino è un prodotto ricco di storia e tradizioni, ma per conquistare i giovani è necessario saper innovare e adattarsi ai nuovi tempi.
Ricerca: l'influenza della dimensione del bicchiere sul consumo di birra e vino
Wine News
Un articolo che riprende uno studio inglese, pubblicato su Plos Medicine
Un articolo che riprende uno studio inglese, pubblicato su Plos Medicine
Wine Newsletter 03/2024 - Ottobre
Riducendo la “taglia” dei bicchieri cala il consumo di birra, ma aumenta quello di vino.
I risultati di uno studio inglese pubblicato su “Plos Medicine”: eliminando la pinta imperiale il volume giornaliero di prodotto venduto cala del 9,7.
→ Leggi l'articolo
La trasversalità delle competenze
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2024 - Agosto
La trasversalità delle competenze tecniche, manageriali e gestionali per il successo delle aziende vinicole
Nel dinamico mondo del vino, il ruolo dell'enologo ha subito una trasformazione significativa. Non basta più eccellere nella produzione di vini di alta qualità; oggi, gli enologi devono possedere competenze manageriali e gestionali per navigare con successo nella complessità del business vinicolo contemporaneo. Questa evoluzione è guidata da cambiamenti nel comportamento dei consumatori, dalle dinamiche di mercato, e dalle nuove esigenze di sostenibilità e innovazione.
Comprendere il nuovo consumatore
Il consumatore moderno è molto più informato e selettivo rispetto al passato. La decisione di acquisto non si basa più solo sul gusto, ma su una serie di fattori che includono la salute, la sostenibilità e l'estetica del packaging. I consumatori cercano vini che rispettino il loro desiderio di moderazione, scegliendo spesso opzioni a basso contenuto alcolico o biologiche. Inoltre, la crescente attenzione verso pratiche sostenibili e responsabili richiede che le aziende vinicole adottino approcci trasparenti e eco-friendly.
Il Ruolo dell’enologo come manager
Gli enologi di oggi devono padroneggiare una varietà di competenze gestionali. Questo include la capacità di analizzare il mercato e anticipare le tendenze dei consumatori, oltre a sviluppare strategie di marketing efficaci. La comprensione del branding e del packaging è cruciale, poiché un design accattivante e sostenibile può influenzare significativamente le decisioni di acquisto. Gli enologi devono collaborare strettamente con i team di vendita per assicurare che i prodotti raggiungano il mercato in modo efficace e soddisfino le esigenze dei clienti.
Gestione finanziaria e controllo di gestione
Oltre alle competenze di marketing e vendita, gli enologi devono acquisire conoscenze in gestione finanziaria e controllo di gestione. La capacità di gestire i costi, ottimizzare le risorse e garantire la redditività è essenziale per il successo a lungo termine di qualsiasi azienda vinicola. Gli enologi devono essere in grado di interpretare i dati finanziari e utilizzare queste informazioni per prendere decisioni strategiche informate.
Sostenibilità e innovazione
La sostenibilità è diventata una priorità non negoziabile nel settore vinicolo. Gli enologi devono essere in grado di implementare pratiche sostenibili in tutte le fasi della produzione, dal vigneto alla bottiglia. Questo include la gestione responsabile delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni di carbonio e l'adozione di tecnologie innovative per migliorare l'efficienza e ridurre l'impatto ambientale.
Collaborazione interdisciplinare
Il successo nel moderno business del vino richiede una stretta collaborazione tra diverse funzioni aziendali. Gli enologi devono lavorare fianco a fianco con i professionisti del marketing, delle vendite, della logistica e della finanza per creare sinergie che portino a un miglioramento complessivo dell’azienda. Questa collaborazione interdisciplinare è fondamentale per sviluppare prodotti che non solo soddisfano le aspettative dei consumatori, ma che sono anche economicamente sostenibili e ecologicamente responsabili.
In conclusione, l'enologo moderno deve essere un professionista versatile, capace di andare oltre la produzione del vino e di affrontare le sfide manageriali e di mercato con competenza e visione strategica. La capacità di comprendere i nuovi comportamenti dei consumatori, di gestire efficacemente le risorse e di promuovere la sostenibilità è cruciale per guidare le aziende vinicole verso il successo in un mercato sempre più competitivo e complesso. Investire nella formazione e nello sviluppo delle competenze manageriali degli enologi è essenziale per costruire un futuro prospero e sostenibile per l’industria del vino.
L'evoluzione del marketing del vino: 30 anni di trasformazioni e innovazioni
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2024 - Agosto
Negli ultimi trent'anni, il marketing del vino ha subito una metamorfosi straordinaria, passando da pratiche tradizionali a strategie altamente sofisticate, guidate dalla globalizzazione, dalla digitalizzazione e da un cambiamento nelle preferenze dei consumatori. Questo settore, un tempo dominato dall'artigianalità e dal radicamento territoriale, si è progressivamente aperto a un mercato globale, abbracciando innovazioni tecnologiche e nuovi paradigmi di consumo. Esploriamo le tappe più significative di questa evoluzione.
L'espansione globale e la diversificazione del mercato
All'inizio degli anni '90, il mercato del vino era fortemente radicato nelle tradizioni locali e regionali. La commercializzazione era spesso limitata ai confini nazionali, con un forte focus sulle peculiarità regionali e sulle denominazioni d'origine storiche. Tuttavia, l'incremento del commercio internazionale e la globalizzazione hanno spinto le aziende vinicole a esplorare nuovi mercati, spesso culturalmente e logisticamente distanti. Questo passaggio ha richiesto un'evoluzione delle strategie di marketing, con un focus crescente sulla comprensione delle diverse culture del consumo di vino e sull'adattamento dei prodotti alle preferenze locali.
Branding e la valorizzazione della qualità
Se in passato il vino veniva scelto principalmente in base alla regione di provenienza o, soprattutto nei mercati emergenti, alla varietà d'uva, oggi il branding gioca un ruolo cruciale. La costruzione di marchi forti è diventata fondamentale per distinguersi in un mercato sempre più affollato. Le aziende vinicole hanno investito nella creazione di identità di marca uniche, che trasmettono non solo la qualità del prodotto ma anche valori, storia e tradizione. Parallelamente, pur con molte difficoltà, le denominazioni di origine sono emerse come strumenti di marketing potentissimi, utilizzati per comunicare l'eccellenza e l'unicità dei vini in un contesto competitivo.
La digitalizzazione: un cambiamento epocale
L'arrivo di Internet ha rappresentato un punto di svolta per il marketing del vino. Le cantine e i produttori si sono trovati di fronte a un nuovo scenario, in cui la comunicazione con i consumatori è passata attraverso siti web, e-commerce e social media. Questa transizione ha aperto le porte a un pubblico globale, consentendo alle aziende vinicole di raggiungere nuovi segmenti di mercato con strategie digitali mirate. Le degustazioni virtuali, le campagne di influencer marketing su piattaforme come Instagram, e la narrazione attraverso i social media sono diventate strumenti indispensabili per coinvolgere i consumatori e costruire una relazione duratura con il brand, disintermediando la loro comunicazione verso il pubblico finale.
Dati e analisi: il marketing del vino diventa scientifico
Negli ultimi anni, il marketing del vino ha abbracciato l'approccio data-driven. L'analisi dei dati è diventata fondamentale, almeno per le aziende più strutturate e multicanale, per comprendere i comportamenti dei consumatori, monitorare le tendenze del mercato e personalizzare le strategie di vendita. Diverse aziende vinicole moderne utilizzano strumenti avanzati di business intelligence per segmentare il mercato con precisione, ottimizzare le campagne promozionali e migliorare l'efficienza operativa. Questo approccio permette di prendere decisioni basate su evidenze concrete, riducendo il margine d'errore e massimizzando il ritorno sugli investimenti.
Sostenibilità: una nuova frontiera del marketing del vino
Negli ultimi decenni, la crescente attenzione dei consumatori verso la sostenibilità ha spinto il settore vinicolo ad adattarsi. Le aziende vinicole stanno adottando pratiche agricole sostenibili, come la viticoltura biologica e biodinamica, e stanno integrando questi valori nelle loro strategie di marketing. La sostenibilità è diventata un elemento distintivo, in grado di attrarre una clientela sempre più consapevole e attenta all'impatto ambientale dei propri acquisti.
Intelligenza artificiale e realtà virtuale: le nuove frontiere del marketing del vino
Con l'avvento dell'intelligenza artificiale (IA) e della realtà virtuale (VR), il marketing del vino sta entrando in una nuova era di innovazione. L'IA sta rivoluzionando il settore grazie alla sua capacità di analizzare grandi quantità di dati in tempo reale, prevedendo le tendenze del mercato e personalizzando l'esperienza del consumatore. Attraverso algoritmi di machine learning, le aziende vinicole possono creare campagne pubblicitarie altamente mirate, ottimizzare la gestione delle scorte e migliorare la customer experience con consigli su misura basati sulle preferenze individuali.
La realtà virtuale, d'altro canto, offre nuove opportunità per coinvolgere i consumatori in modo immersivo: dai tour virtuali nelle cantine, che permettono di esplorare vigneti e processi produttivi comodamente da casa, alle degustazioni virtuali interattive, che portano l'esperienza sensoriale a un livello completamente nuovo. Queste tecnologie non solo arricchiscono l'interazione con il marchio, ma creano anche nuove modalità di narrazione e connessione emotiva, aprendo orizzonti inediti per il marketing del vino.
Conclusioni: il futuro del marketing del vino passa attraverso la formazione manageriale
L'evoluzione del marketing del vino negli ultimi trent'anni riflette la capacità del settore di adattarsi a cambiamenti profondi e di anticipare le tendenze emergenti. Da un mercato locale e tradizionale, il mondo del vino è diventato globale, digitale e altamente competitivo. Guardando avanti, le aziende vinicole che sapranno continuare a innovare, sfruttando le nuove tecnologie e mantenendo un forte legame con i valori autentici del territorio, saranno quelle che riusciranno a prosperare in un contesto sempre più dinamico e complesso. L'innovazione, l'analisi dei dati e la sostenibilità continueranno a essere i pilastri su cui costruire il futuro del marketing del vino.
In questo contesto di rapida evoluzione tecnologica e di mercato, la formazione manageriale assume un ruolo cruciale per le aziende vinicole che desiderano rimanere competitive e innovative. La complessità crescente del settore richiede competenze avanzate non solo nella gestione tradizionale, ma anche nelle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale e la realtà virtuale. La formazione continua dei manager diventa quindi essenziale per comprendere e sfruttare appieno queste nuove opportunità. I programmi di formazione manageriale orientati al settore vinicolo stanno integrando moduli specifici su digital marketing, analisi dei dati, sostenibilità e gestione delle tecnologie emergenti.
Questa preparazione avanzata permette ai leader aziendali di sviluppare strategie più efficaci, migliorare l'efficienza operativa e guidare le loro organizzazioni attraverso le sfide di un mercato sempre più complesso e globale. In definitiva, investire nella formazione manageriale è fondamentale per le aziende vinicole che vogliono non solo sopravvivere, ma prosperare in un ambiente in continua trasformazione.
Moderazione e downtrading, oggi caratteri forti del mercato degli alcolici
Da Unione Italiana Vini
Wine Newsletter 02/2024 - Agosto
In attesa di una modesta ripresa attesa per il 2025, secondo IWSR, il mercato globale delle bevande alcoliche continuerà nella seconda parte dell’anno in corso ad essere caratterizzato dalla moderazione e dal downtraiding.
→ Leggi la News
Wine Business: rinnovata la convenzione con Unione Italiana Vini e AGIVI
Da Unione Italiana Vini
Wine Newsletter 02/2024 - Agosto
Dal 14 Novembre, al via la 12ma edizione del programma Wine Business Management a Trieste, con una formula weekend ibrida, in presenza oppure online: per i soci Unione Italiana Vini e AGIVI è garantito uno sconto del 20%.
→ Leggi la News
→ Leggi la News
Stefano Ricagno, diplomato MIB, nuovo Presidente del Consorzio Asti Docg
Da Wine Meridian
Wine Newsletter 02/2024 - Agosto
Con un mandato triennale, mira a rafforzare la promozione dell’Asti Spumante e del Moscato d’Asti a livello globale.
→ Leggi la News
→ Leggi la News
La moderazione dei consumi di vino e alcolici cambierà il business del vino e l’innovazione di prodotto nei prossimi anni?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2024 - Giugno
Durante l’ultimo Vinitaly a Verona, il Convitato di pietra, nemmeno troppo nell’ombra, è stato il vino a basso o senza alcol. Diversi convegni e approfondimenti l’hanno visto protagonista, al punto da portare via, almeno nella comunicazione giornalistica, una parte importante dello spazio dedicato alla fiera, tra annunci di ministri e commenti vari (spesso più ideologici che tecnici).
Nel panorama contemporaneo, la consapevolezza dei consumatori riguardo alla salute e al benessere sta crescendo rapidamente. Questo trend ha portato a un cambiamento significativo nel modo in cui le persone si relazionano con il vino e gli alcolici. La moderazione dei consumi non è più vista come una rinuncia, ma come una scelta consapevole e sofisticata. Le aziende del settore vitivinicolo e degli alcolici stanno rispondendo a questa evoluzione con innovazioni di prodotto che soddisfano le nuove esigenze del mercato.
Un nuovo approccio al consumo
Il desiderio di uno stile di vita più equilibrato ha spinto i consumatori a cercare opzioni che permettano loro di godere del piacere di un buon vino o di un cocktail senza eccessi. Questa tendenza ha aperto la strada a una gamma di prodotti a basso contenuto alcolico o addirittura analcolici, che conservano (o dovrebbero conservare) tutto il gusto e l’eleganza delle bevande tradizionali, pur essendo bevande “diverse”.
Le aziende del settore stanno adottando un ruolo proattivo nella promozione della moderazione. Campagne di marketing educate e responsabili stanno da anni sensibilizzando il pubblico sull'importanza di un consumo consapevole. Inoltre, molte aziende stanno collaborando con esperti di salute per sviluppare linee guida che aiutino i consumatori a fare scelte informate.
Innovazione di prodotto: i vini a basso grado alcolico e la mixologia
Una delle principali innovazioni è rappresentata dai vini a basso grado alcolico. Questi vini, ottenuti attraverso tecniche di vinificazione avanzate, offrono un'esperienza sensoriale completa, ma con un contenuto alcolico ridotto. Sempre più produttori, pur con le attuali limitazioni legislative che impediscono ancora il processo di dealcolazione all’interno delle cantine italiane, stanno investendo in ricerca e sviluppo per creare vini che non compromettano la qualità e il gusto, garantendo al contempo una minore assunzione di alcol.
Parallelamente, il mondo della mixologia sta vivendo una rivoluzione con l’introduzione dei cocktail analcolici, noti anche come “mocktail”. Questi drink sono preparati con la stessa attenzione e creatività dei cocktail tradizionali, utilizzando ingredienti di alta qualità per offrire esperienze di gusto uniche e sofisticate. I mocktail permettono ai consumatori di partecipare alle occasioni sociali senza sentirsi esclusi, promuovendo un consumo responsabile e piacevole.
Le bevande analcoliche entrano negli abbinamenti
Sebbene il vino costituisca ancora la spina dorsale della maggior parte dei percorsi di abbinamento dei ristoranti, esiste una nuova generazione di esperti che cerca di spingere il pairing oltre la tradizione e, oggi, è il mondo delle bevande analcoliche a diventare protagonista nell’associazione virtuosa con l’alta cucina. Questa tendenza non solo risponde alla crescente domanda di opzioni non alcoliche nei ristoranti di lusso, ma riflette anche uno spostamento più ampio verso uno stile di vita salutare e consapevole.
Tradizionalmente, l’abbinamento del cibo con il vino è stato il fulcro dell’esperienza gastronomica, ma sempre più chef e sommelier stanno esplorando nuove vie, introducendo una vasta gamma di bevande senza alcool per accompagnare i loro piatti. Come il vino, queste bevande sono selezionate con cura per migliorare i sapori del cibo e offrire un’esperienza sensoriale completa. Molte delle bevande non alcoliche offrono profili aromatici e gustativi altrettanto complessi e sofisticati del vino: dalle tisane aromatiche ai kombucha fermentati, dalle bevande a base di erbe alle limonate artigianali, le opzioni sono in continua espansione.
Un’aspettativa sempre più diffusa è quella di bevande non alcoliche che offrono nuove sfumature e contrasti con il cibo. Ad esempio, una bevanda leggermente frizzante a base di mela verde può bilanciare perfettamente la ricchezza di un piatto di foie gras, mentre un infuso di tè alla menta può intensificare i sapori di un dessert al cioccolato fondente.
Il cambiamento nasce dai nuovi bisogni dei consumatori
Questo cambiamento riflette anche un crescente interesse da parte dei consumatori per uno stile di vita più sano e sostenibile. Molti intenditori di cibo stanno cercando di moderare il loro consumo di alcol, sia per motivi di salute che per il desiderio di mantenere una maggiore lucidità durante i pasti. Inoltre, c’è una crescente consapevolezza dell’impatto ambientale e sociale legato alla produzione e al consumo di alcol, spingendo molti a esplorare alternative più sostenibili.
Questa crescente disponibilità di bevande non alcoliche di alta qualità nei ristoranti di fine dining dimostra che l’innovazione culinaria non si limita al cibo, ma si estende anche al mondo delle bevande. Questo apre nuove porte per l’espressione creativa e l’esperienza gastronomica, offrendo ai clienti la possibilità di vivere un’esperienza sensoriale completa senza compromettere la qualità o il gusto.
La moderazione dei consumi di vino e alcolici rappresenta, quindi, non solo una risposta ai cambiamenti nelle preferenze dei consumatori, ma anche un’opportunità di innovazione per le aziende del settore. Investire in prodotti a basso contenuto alcolico e analcolici, oltre a promuovere un consumo consapevole, permette di soddisfare una domanda crescente e di contribuire al benessere della società. Il futuro del business del vino e degli alcolici è nella capacità di evolversi, offrendo esperienze di gusto raffinate che rispettano le esigenze di una clientela sempre più attenta e responsabile.
Il sogno di diventare un produttore (di successo): percorsi virtuosi ed errori da evitare
Da Civiltà del Bere
Alberto Buratto, esperto di gestione aziendale, marketing e comunicazione enologica, diplomato alla II edizione del MBA in Wine Business, MIB trieste School of Management
Alberto Buratto, esperto di gestione aziendale, marketing e comunicazione enologica, diplomato alla II edizione del MBA in Wine Business, MIB trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2024 - Giugno
Tutto quello che c’è da sapere prima di intraprendere quest’affascinante ma tutt’altro che semplice professione. I consigli di Alberto Buratto, esperto di gestione aziendale, marketing e comunicazione enologica, tra i docenti del programma Wine Business Management del MIB di Trieste.
→ Leggi l'articolo di Civiltà del Bere
Fondi di investimento e cantine vitivinicole
Luca La Paglia, diplomato alla 9na edizione del programma Wine Business Management, MIB trieste School of Management
Luca ricopre la carica di Marketing Advisor per un fondo di investimento italiano, con una specializzazione nel settore della Wine Industry. Ha maturato una significativa esperienza professionale lavorando a progetti di marketing in Italia, Inghilterra e USA prima di frequentare il Corso in WBM al MIB.
Luca ricopre la carica di Marketing Advisor per un fondo di investimento italiano, con una specializzazione nel settore della Wine Industry. Ha maturato una significativa esperienza professionale lavorando a progetti di marketing in Italia, Inghilterra e USA prima di frequentare il Corso in WBM al MIB.
Wine Newsletter 01/2024 - Giugno
Negli ultimi anni, l'interesse dei fondi di investimento per le cantine vitivinicole è cresciuto notevolmente, segnando una tendenza significativa nel settore enologico. Questo fenomeno rappresenta un connubio interessante tra finanza e agricoltura, con implicazioni profonde per il business del vino a 360°.
In Italia questa “comunione di obiettivi” negli ultimi 5 anni, si è diverse volte manifestata, tramite diverse operazioni di M&A andate a buon fine. Una delle più conosciute, è quella finalizzata dal fondo Clessidra Private Equity, che nel 2021 è entrata nel settore vino acquisendo una quota di maggioranza della Casa Vinicola Botter S.p.A., azienda veneziana tra i maggiori esportatori di vino italiano nel mondo detenuta dalla famiglia Botter e dal fondo IDeA Taste of Italy gestito da DeA Capital Alternative Funds SGR (fondo di proprietà del gruppo De Agostini).
Un’altra operazione simbolo, conclusa nel 2022 tra una piccola cantina e un fondo strutturato, è quella portata a termine da Red Circle Investments, fondo di investimento di proprietà di Renzo Rosso (patron del marchio di moda Diesel nonché della holding Only the Brave), ha rilevato il 40% della storica cantina siciliana Benanti Viticoltori, produttore di riferimento di vini della Doc dell’Etna, per un controvalore di 7,5 milioni di euro e con un equity value di 18,8 milioni.
Nel mondo del vino, dove tradizione e innovazione si intrecciano, l’ingresso di fondi nella compagine societaria delle piccole o medie cantine vinicole rappresenta un’opportunità di crescita e sviluppo senza precedenti. Questa forma di partnership, se ben strutturata, può portare benefici significativi, migliorando la competitività e sostenibilità delle cantine. I fondi di Private Equity o Venture Capital, attratti dal potenziale di ritorno economico e dal prestigio associato al possesso di cantine rinomate, apportano risorse finanziarie cruciali per l’espansione commerciale, l'innovazione tecnologica e il miglioramento delle pratiche vitivinicole. Questo afflusso di capitale permette alle cantine di modernizzare le attrezzature, migliorare la qualità dei prodotti e aumentare la capacità produttiva, elementi fondamentali per competere in un mercato globale sempre più esigente.
Di seguito, un’analisi più approfondita di alcuni pro e contro di una joint venture tra fondi di investimento e cantine vinicole. Ovviamente le dinamiche che entrano in campo sono molto più numerose, ma si cercherà di individuare le possibilità/criticità più comuni.
I vantaggi
- Capitale per la crescita: L’accesso a nuovi capitali è uno dei principali vantaggi dell’ingresso di un fondo di investimento. Questo capitale può essere utilizzato per ampliare le infrastrutture, aggiornare le attrezzature di vinificazione, aumentare la capacità produttiva, investire sulle attività di marketing.
- Accesso a nuovi mercati: I fondi di investimento spesso hanno una vasta rete di contatti internazionali che possono aiutare le cantine a penetrare nuovi mercati. Con il supporto di un fondo, una piccola cantina può espandere la propria presenza globale, raggiungendo mercati ad alta crescita come quello asiatico o nordamericano.
- Supporto strategico e manageriale: Oltre al supporto finanziario, i fondi di investimento portano con sé competenze manageriali e strategiche. Possono fornire consulenza su come ottimizzare la produzione, migliorare le strategie di marketing e sviluppare nuovi prodotti.
- Innovazione e sostenibilità: I fondi di investimento sono spesso orientati verso l'innovazione e la sostenibilità. Investire in pratiche di viticoltura sostenibile e in tecnologie all'avanguardia può rendere una cantina più competitiva e rispettata.
Gli svantaggi
- Perdita di controllo: Una delle principali preoccupazioni per i proprietari delle cantine è la possibile perdita di controllo. Quando un fondo di investimento entra nel capitale, potrebbe richiedere una partecipazione nella governance aziendale, influenzando le decisioni strategiche. Questo può portare a conflitti, specialmente se le visioni a lungo termine non sono allineate.
- Pressione per i profitti: I fondi di investimento sono spesso orientati al rendimento finanziario e potrebbero esercitare pressione sulla cantina per ottenere profitti a breve termine. Questo potrebbe entrare in conflitto con la natura tradizionalmente paziente del business del vino, dove la qualità e la reputazione si costruiscono nel tempo.
- Rischio di cambiamento di visione: L’ingresso di investitori esterni può portare a un cambiamento nella visione aziendale, spingendo la cantina a prendere decisioni che potrebbero allontanarsi dai suoi valori tradizionali. È essenziale che i fondi di investimento condividano e rispettino la visione e i valori della cantina per evitare tensioni. Per armonizzare questi due mondi, è cruciale un approccio equilibrato che valorizzi le peculiarità del settore vinicolo e al contempo sfrutti le potenzialità dei capitali e delle competenze manageriali dei fondi. Le cantine devono mantenere una visione chiara del loro patrimonio culturale e della qualità del prodotto, integrando le risorse finanziarie e le strategie di mercato in modo da rafforzare la loro posizione senza snaturare la loro essenza. D'altra parte, i fondi di investimento devono adottare una prospettiva a lungo termine, comprendendo che il valore di una cantina non si misura solo in termini di ritorno economico (più o meno immediato), ma anche in termini di brand, reputazione e capacità di innovazione sostenibile.
In sintesi, l’ingresso di un fondo di investimento in una piccola o media cantina vinicola può offrire opportunità significative per la crescita e lo sviluppo. Sebbene esistano rischi associati a queste partnership, con una gestione attenta e un allineamento strategico, i benefici possono superare di gran lunga gli svantaggi, portando a un futuro prospero e sostenibile per la cantina.
Business del Vino: l'Enologo diventa Manager
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2024 - Giugno
La 12ma edizione del programma Wine Business Management svela i suoi segreti in alcune città del Nordest, durante gli incontri condotti dal Direttore del Programma, Pierpaolo Penco, con la partecipazione di docenti e consulenti del settore.
MIB Trieste School of Management è lieta di organizzare il primo di questi eventi in collaborazione con Assoenologi Veneto Occidentale, il 25 giugno a SOAVE (VR), presso l'azienda Rocca Sveva, dal titolo "Business del Vino: l'Enologo diventa Manager".
Interverranno 4 relatori, l'entrata è gratuita previa cortese registrazione.
→ Vai all'evento
La XII edizione del Corso executive in Wine Business Management avrà inizio il 14 novembre 2024 con il primo dei 10 weekend d’aula (giovedì-sabato), con cadenza mensile. Anche quest’anno l’accordo con alcuni partner (ad oggi Unione Italiana Vini, Associazione Donne del Vino, AGIVI, Assoenologi Veneto) prevende uno sconto del 20% a partecipanti provenienti da aziende associate, con conferme entro il 31 ottobre.
Un vino sempre più "polarizzato"
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2023 - Agosto
La grande maggioranza delle persone, quando deve acquistare un vino, sceglie sulla base di pochi fattori, dipendenti in gran parte dall'occasione d'uso e dal coinvolgimento con il prodotto. Sempre più spesso la scelta è condizionata da marchi forti conosciuti nazionalmente (che si tratti di Antinori, Ruffino, Ferrari, Mionetto, Villa Sandi, Frescobaldi, Donnafugata o altri), al caso affiancati da etichette “sicure” regionali e locali o di macro aree (vedi Prosecco), soprattutto dal lato dei volumi (che sia asporto o ristorazione). Oppure dall'appartenenza a una categoria, se non ad una nicchia specifica, con carte dei vini di una fetta crescente della ristorazione di “fine dining” ed enoteche che si focalizzano su produttori molto schierati verso una produzione artigianale o “naturale”.
Questa polarizzazione è asimmetrica, con un polo evidentemente molto più grande dell'altro. Nel primo caso emerge una potenza commerciale crescente che può sostenere grandi investimenti promozionali, in Italia e all’estero. Al contrario, il polo più piccolo (ma occupato da tante piccole cantine) ha la capacità in questo momento di assecondare una ricerca spinta della differenza di alcuni segmenti dei consumatori e degli operatori, con una copertura mediatica spesso più ampia delle vendite stesse.
Il motivo? I consumatori e la gestione del rischio
Una ricerca presentata a Vinitaly nel 2018 sui consumatori nazionali sottolineava come solo il 25% degli italiani sa riconoscere le principali zone di produzione vinicole e collegarle alle regioni geografiche. Questa percentuale è molto minore all’estero, soprattutto in quei paesi dove il vino non è una bevanda abituale e parte di una cultura alimentare sedimentata. Pochi wine drinker sanno riconoscere più di tre zone vinicole in Australia, ad esempio.
Non basta, come si può leggere in una ricerca compiuta un paio di anni fa dal prof. Charles Spence dell’Oxford University, gli acquirenti di fronte a centinaia di bottiglie sullo scaffale di un supermercato possono essere così intimoriti da optare per quello con il nome più facile da pronunciare o dalle etichette con un bel disegno, magari di un pittoresco animale.
Ciò significa che i consumatori, quando vogliono acquistare una bottiglia, ma anche un calice di vino, se non trovano qualcosa di conosciuto e che a loro piace, vogliono evitare di trovarsi in una situazione di disagio. Il segmento dei consumatori che ricercano spesso novità, infatti, è importante ma, comunque, molto minoritario rispetto agli altri. Spesso, questa continua ricerca porta con se’ un consumo poco focalizzato (basta che sia “nuovo”) e, di conseguenza, una scarsa fedeltà alla marca e ai territori (da qui una riconoscibilità in calo).
A differenza di una lattina di birra o un vasetto di yogurt il vino spesso non viene bevuto dal solo acquirente ma spesso la bottiglia viene condivisa con altre persone, in una situazione famigliare o sociale. Quindi, può succedere di trovarsi in imbarazzo nello scegliere qualcosa che gli altri possono non apprezzare. Si parla, infatti, di avversione al rischio, anche se il costo da sostenere è relativamente basso. Un brand conosciuto, infatti, abbassa la percezione del rischio, così come l’appartenenza a una nicchia dove il consumatore si riconosce, alle volte quasi ideologicamente (es. “non bevo vini convenzionali”).
Tenendo questo a mente, le cantine non devono dare per scontato che i consumatori conoscano tutto della loro storia, dei vitigni, delle DOC, le tecniche di produzione o gli abbinamenti con il cibo. Ma questo spesso ancora non avviene!
Uscire dall’anonimato
Se vogliamo parlare ai consumatori che amano il vino ma non sono depositari di particolari conoscenze o frequentatori di iper-nicchie, dobbiamo in qualche modo avere una proposta unica di vendita che faccia leva su un linguaggio semplice, comprensibile e accattivante, coerente con la nostra identità, da declinare nei diversi strumenti di comunicazione fino all’accoglienza in cantina.
Viceversa, le persone sceglieranno sulla base di alcuni fattori molto ben specifici che semplificano il loro processo di acquisto: il prezzo (e le promozioni), il brand famoso o reputato, l’occasione d’uso oppure semplicemente la categoria, dove questa può essere il Prosecco (o lo Spritz), il rosé o lo stesso vino “naturale”.
E tutti gli altri?
20 anni nel mondo (e nell'aula) del Vino
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2023 - Agosto
A fine novembre MIB Trieste festeggerà i 20 anni dall’avvio della prima edizione di un corso di alta formazione dedicato al settore vitivinicolo. Era la fine del 2003, infatti, quando prese il via quello che per tre edizioni (fino al 2008) si chiamava MBA in Wine Business, il pioniere dei percorsi formativi di una business school in Italia per operatori provenienti dal mondo del vino. Dopo un paio di anni dedicati a un programma di seminari e corsi brevi all’interno di un progetto formativo regionale e ad un mini-master per partecipanti di aziende vinicole del Friuli-Venezia Giulia, l’offerta formativa del MIB ha trovato una formula che negli anni si è via via affinata: il Corso executive in Wine Business Management, di cui a novembre 2023 partirà la XI edizione.
In questi 20 anni sono più di 200 le persone che hanno ottenuto un diploma o un attestato di frequenza. Alcuni di essi sono ora coinvolti come docenti o testimonial, potendo condividere con i loro “colleghi” sia le competenze sviluppate sul campo che gli effetti e i risultati che l’esperienza didattica ha avuto sulla loro attività professionale seguente. Molti hanno avuto un’accelerazione della loro carriera lavorativa, sia all’interno delle aziende di famiglia che come manager o consulenti di altre aziende.
L’industria vinicola italiana richiede oggi risorse umane altamente formate e qualificate per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. In risposta a questa esigenza, MIB Trieste e Wine Meridian (testata giornalistica online che racconta quotidianamente l’evoluzione dei mercati, le esperienze aziendali più significative e quelle dei professionisti più importanti), hanno unito le loro forze per contribuire alla crescita continua delle aziende e dei professionisti del settore. I partecipanti alla XI edizione e alle edizioni precedenti del Corso in Wine Business Management, infatti, potranno beneficiare dei servizi di WinePeople, società spin-off di Wine Meridian che si occupa di HR e formazione, tra cui l'esame del CV e l'inserimento nel database dei profili. Questo nuovo servizio permetterà a chi frequenta i nostri programmi di formazione di aumentare le possibilità di placement nel settore o di poter valutare una pianificazione più strutturata della propria carriera lavorativa.
Nel frattempo, il vino sfuso
Wine Newsletter 01/2023 - Agosto
Nel frattempo, il vino “sfuso” continua a crescere e ora vale circa un terzo degli scambi internazionali.
L'Unione Italiana Vini ha pubblicato un articolo che evidenzia come alla contrazione di volume sia corrisposto tuttavia un incremento del mercato in termini di valore.
→ Vai all'articolo
Una start-up iniziata... nel 1968
Wine Newsletter 01/2023 - Agosto
La testata Start-up Italia dedica un articolo alla più giovane diplomata del Corso in Wine Business Management, Elettra Gugole, che sta dando una nuova forma all’azienda vinicola di famiglia in Valpolicella:
→ Vai all'articolo
Dopo l’estate, ci aspetta anche un autunno “caldo”?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2022 - Settembre
Nello scorso mese di luglio abbiamo organizzato la III edizione della Summer School di MIB Trieste School of Management sul marketing del vino, sempre presso la sede di Fondazione Campus a Portogruaro. Il Corso compatto è stato incentrato sugli aspetti del marketing e della comunicazione vinicola legati alle giovani generazioni (Millennial e Generazione Z). Come abbiamo precedentemente scritto, parlare e conquistare i giovani è una delle sfide più impellenti del settore. Ma non l’unica, come potrete leggere nell’articolo di Wine Meridian cui sotto riportiamo il link, incentrato su alcune analisi di IWSR (International Wine & Spirit Research).
La ripartenza dopo la Pandemia sta vedendo il mondo agire a più velocità: da un lato i mercati internazionali stanno muovendosi in modo spesso diverso da prima (pensiamo alla Cina ancora in parziale lockdown in alcune zone o ai problemi politici di Hong Kong), dall’altro il turismo sta vivendo un’estate da tutto esaurito in gran parte dei territori vinicoli, con l’enoturismo nuovamente un driver chiave per molte aziende, soprattutto medio-piccole, che possono garantirsi flussi di cassa utili anche a finanziare le ormai prossime vendemmie (malgrado gli ormai costanti problemi nel recruiting della manodopera). Senza tenere conto delle variabili economiche, a partire dall’inflazione e dai suoi effetti sul potere d’acquisto dei consumatori nelle diverse parti del mondo.
Il Corso in Wine Business Management, giunto alla sua X edizione, in partenza a novembre, si è caratterizzato dall’inizio per aver aperto una finestra che porta i partecipanti a guardare oltre il puro settore vinicolo e le sole problematiche delle cantine. Sempre più il vino, infatti, è interconnesso con tutto il settore delle bevande, non solo alcoliche, di cui può assorbire tendenze e stili.
Il futuro delle aziende produttrici di vino, superalcolici e birra passa per il valore?
Wine Newsletter 02/2022 - Settembre
Sempre secondo IWSR, i consumi globali di bevande alcoliche non crescono più, con un trend trasversale a quasi tutti i mercati e ad ogni fascia di età. Ne consegue che la crescita futura delle aziende di vino, birra, spirits e RTD (ready-to-drink) debba passare necessariamente dalla crescita del prezzo medio, la c.d. “premiumizzazione”. Negli ultimi anni questa corsa alla valorizzazione ha premiato in particolare i superalcolici che continueranno a guadagnare, a valore, ovunque: la loro quota sul totale dei consumi di alcol è destinata a passare dal 35% del 2021 al 42% del 2026, superando così sia la birra che il vino.
Se guardiamo invece alla crescita a volume, è la birra a fornire i segnali più positivi, mentre il vino è destinato a perdere lo 0,2% annuo di consumi, contraendo le proprie quote sul mercato dei consumi degli alcolici dello 0,9% (a fronte, tuttavia, di una crescita del segmento delle bollicine). A differenza della categoria degli spirits, dove whisky, gin e tequila garantiscono anche produzioni di altissimo livello qualitativo, il segmento della birra vede una forbice dei prezzi molto più ristretta, con una crescita a volume legata essenzialmente ai Paesi in via di sviluppo di Africa, Sud America e Sud-est asiatico (dove i prezzi medi sono più bassi), mentre in Europa e in Nord America (dove i prezzi sono più alti), i consumi sono in lento peggioramento.
Venendo al vino e alle sue quote di mercato a valore, i consumi stanno calando in ogni parte del mondo, ad eccezione del Sud America e dei Paesi dell’ex URSS. La premiumizzazione deve fare i conti con il declino dei consumi dei suoi maggiori mercati, ossia Italia, Francia e USA. Qui, il passaggio generazionale ha avuto come effetto una forte riduzione del consumo quotidiano, soprattutto dei vini a basso prezzo, tipico dei consumatori più anziani. I consumatori più giovani, come detto (appartenenti agli ormai famosi segmenti demografici dei Millennials e della Generazione Z), raramente bevono ogni giorno, spendendo qualcosa in più quando decidono di acquistare una bella bottiglia (o un packaging alternativo). Il trend comune a tutti i giovani consumatori è appunto quello di bere meno, spendendo di più. Purtroppo, al momento, questo calo a volume a livello globale non è ancora del tutto compensato dalla premiumizzazione.
In questo momento di grande incertezza economica, le aziende del settore degli alcolici stanno affrontando diversi problemi: dalla crescita dell’inflazione all’aumento dei costi, fino alle pressioni su tutta la supply chain (pensiamo alle difficoltà di approvvigionamento del vetro!), che portano a ritardi nelle spedizioni e all’aumento dei prezzi delle materie prime e degli imballaggi. Nonostante ciò, IWSR prevede che dare priorità al valore, e quindi al prezzo medio, rimarrà un trend dominante per il settore nei prossimi anni e, per crescere in particolare nei mercati maturi, anche per il vino sarà sempre più importante concentrarsi sulla fascia premium del mercato.
Se guardiamo invece alla crescita a volume, è la birra a fornire i segnali più positivi, mentre il vino è destinato a perdere lo 0,2% annuo di consumi, contraendo le proprie quote sul mercato dei consumi degli alcolici dello 0,9% (a fronte, tuttavia, di una crescita del segmento delle bollicine). A differenza della categoria degli spirits, dove whisky, gin e tequila garantiscono anche produzioni di altissimo livello qualitativo, il segmento della birra vede una forbice dei prezzi molto più ristretta, con una crescita a volume legata essenzialmente ai Paesi in via di sviluppo di Africa, Sud America e Sud-est asiatico (dove i prezzi medi sono più bassi), mentre in Europa e in Nord America (dove i prezzi sono più alti), i consumi sono in lento peggioramento.
Venendo al vino e alle sue quote di mercato a valore, i consumi stanno calando in ogni parte del mondo, ad eccezione del Sud America e dei Paesi dell’ex URSS. La premiumizzazione deve fare i conti con il declino dei consumi dei suoi maggiori mercati, ossia Italia, Francia e USA. Qui, il passaggio generazionale ha avuto come effetto una forte riduzione del consumo quotidiano, soprattutto dei vini a basso prezzo, tipico dei consumatori più anziani. I consumatori più giovani, come detto (appartenenti agli ormai famosi segmenti demografici dei Millennials e della Generazione Z), raramente bevono ogni giorno, spendendo qualcosa in più quando decidono di acquistare una bella bottiglia (o un packaging alternativo). Il trend comune a tutti i giovani consumatori è appunto quello di bere meno, spendendo di più. Purtroppo, al momento, questo calo a volume a livello globale non è ancora del tutto compensato dalla premiumizzazione.
In questo momento di grande incertezza economica, le aziende del settore degli alcolici stanno affrontando diversi problemi: dalla crescita dell’inflazione all’aumento dei costi, fino alle pressioni su tutta la supply chain (pensiamo alle difficoltà di approvvigionamento del vetro!), che portano a ritardi nelle spedizioni e all’aumento dei prezzi delle materie prime e degli imballaggi. Nonostante ciò, IWSR prevede che dare priorità al valore, e quindi al prezzo medio, rimarrà un trend dominante per il settore nei prossimi anni e, per crescere in particolare nei mercati maturi, anche per il vino sarà sempre più importante concentrarsi sulla fascia premium del mercato.
Un’epoca di crisi e incertezze: le aziende del vino come possono gestirla?
articolo pubblicato su Wine Meridian
Il 2022 per il mondo del vino si sta rivelando foriero di una serie di sfide maggiori anche rispetto al periodo pandemico. Quali saranno le soluzioni per reggere l’urto?
leggi l'articolo >>
Wine Newsletter 02/2022 - Settembre
Il 2022 per il mondo del vino si sta rivelando foriero di una serie di sfide maggiori anche rispetto al periodo pandemico. Quali saranno le soluzioni per reggere l’urto?
leggi l'articolo >>
I giovani consumatori ed il vino: problema e (possibili) soluzioni
Lorenzo Biscontin
Visiting Faculty, Wine Business Management
Lo scorso 14 luglio nell’ambito della Summer School dedicata al Marketing e Innovazione dei vini del Nord-Est, organizzata a Portogruaro dal MIB di Trieste, si è tenuta un’interessante tavola rotonda su come recuperare l’interesse dei giovani consumatori nei confronti del vino. Io ho partecipato trattando il tema del Pinot Grigio e portando la testimonianza di cosa sta succedendo dentro al metaverso Vinophila. Gli spunti sono stati molti e molto interessanti e quindi è stato necessario lasciarli decantare qualche giorno prima di poter cercare di trovare una sintesi e, soprattutto, ipotizzare delle soluzioni.
Calo dell’interesse dei giovani rispetto al vino: un vecchio problema.
Le ricerche degli ultimi 2-3 anni indicano in modo sostanzialmente univoco che in tutti i principali mercati di consumo sta diminuendo la quota di consumatori di vino nelle fasce più giovani (Millennials e Gen Z più “vecchi”). Non si tratta quindi solamente di un consumo pro-capite minore (sporadico, occasionale), ma di un numero inferiore di persone che bevono vino in assoluto.
Inferiore soprattutto al numero di persone che altri tipi di bevande alcoliche classiche, come birra e liquori e distillati, ed innovative, come Ready to Drink e Hard Seltzer. È un elemento cruciale da tenere in considerazione perché indica che oggi la priorità del settore vinicolo rispetto ai giovani consumatori non è offrire motivazioni per aumentarne il consumo pro-capite, ma è recuperarne l’interesse per allargare la platea di chi beve vino, anche sporadicamente.
Puntare infatti sul naturale spostamento delle preferenze verso il vino al crescere dell’età è uno scenario molto rischioso partendo da una platea che si riduce di anno in anno, soprattutto nella situazione di generale diminuzione di consumo di alcolici che si sta sempre più consolidando.
Interessante notare come quello del rapporto tra il vino e le fasce di consumatori più giovani sia un problema che è stato già evidenziato ed affrontato già da metà degli anni ’90. In quel caso i giovani erano la Generazione X e, se consideriamo gli USA, solo l’8% al tempo consumava vino settimanalmente. Oggi quegli stessi consumatori hanno tra 40 e 50 anni e la quota di consumatori regolari di vino è raddoppiata al 16%. Non è dato di sapere quanto questo incremento sia stato “naturale” oppure supportato dalle attività di marketing messe in atto dall’industria del settore.
Fatto sta che queste iniziative si sono interrotte una decina di anni dopo, anche in base ai risultati di una ricerca del 2015 che attribuiva ai Millennials il 42% del consumo di vino negli U.S.A.. Dato eclatante e sorprendente perché … era sbagliato, come ha dichiarato e corretto l’Istituto di Ricerca alcuni mesi dopo la pubblicazione (https://wineindustryadvisor.com/2016/03/24/wine-market-council-stands-by-research)
Una nuova comunicazione: uscire dal modello unico dell’Esperto.
Il principale imputato dello scarso interesse dei giovani riguardo al vino è il modo in cui viene comunicato, sai come contenuti che come stile. La macchietta del sommelier di Antonio Albanese è di 15 anni fa, ne ridevamo tutti, eppure la comunicazione del vino continua ad essere in grandissima parte quella: scostante, sussiegosa e professorale.
Nel suo interessante intervento Giulio Somma, Direttore del Corriere Vinicolo, si chiedeva se il mondo del vino i giovani dovesse convincerli o seguirli. In realtà né l’uno né l’altro, ma ascoltarli per coinvolgerli. Considerando che le ricerche sul mercato USA indicano che i criteri di scelta dei giovani consumatori sono la sostenibilità e l’esperienza del momento di consumo, Somma si chiedeva anche se comunicare tutti quegli elementi di qualità intrinseca (terroir, vitigno, tecniche enologiche, annata, ecc…)
La risposta è sì, ma in modo diverso e l’esempio l’ha fornito Lorenzo Foffani con il vino “Liar” (“bugiardo” in italiano) prodotto dall’azienda di famiglia da uve merlot vinificate in bianco. Un progetto di marketing a tutto tondo dove il concetto della marca nasce dalle caratteristiche oggettive del vino e del processo, ma si declina in una proposta che va oltre la semplice descrizione tecnica di territorio, vitigno ecc…
In una parola una proposta che non si basa sulle caratteristiche del prodotto, ma sui benefit che offre a chi lo sceglie https://www.adsoftheworld.com/campaigns/a-ripe-time-for-liars
Storytelling è da anni una parola abusatissima anche nel mondo del vino, che però nella stragrande maggioranza dei casi crede di raccontare storie mentre in realtà elenca fatti.
Disintermedizione, autenticità, divertimento.
Sono i tre pilastri della società digitale, che valgono, soprattutto per i digital native, anche nel vino.
Disintermediazione significa l’abitudine ad informarsi e scegliere da soli. Significa l’entrata in crisi della figura dell’esperto in tutti gli ambiti, dalla politica al critico enologico, rispetto alle proprie cerchie di conoscenze, che possono includere anche la celebrità a cui si parlare direttamente sui social.
Autenticità significa trasparenza, correttezza e coerenza rispetto a chi si è, ai valori che ci contraddistinguono ed alle posizioni che prendiamo di conseguenza. Attenzione perché parlando di consumatori “giovani” il rischio di prendere posizioni “giovanilistiche” cercando goffamente di appropriarsi di linguaggi e tendenze è sempre dietro l’angolo nelle agenzie di comunicazione e nelle aziende. Rischio pericolosissimo perché porta a realizzare strategie palesemente finte.
Divertimento che può essere puro e semplice oppure declinarsi nelle forme più diverse: edutainment, gamification, ecc… Non è un caso se i consumatori sotto in trent’anni evitano Facebook ed usano invece Tik Tok.
Prosecco e Pinot Grigio.
Durante la tavola rotonda si è parlato anche di due tipologie di vino: il Prosecco, grazie all’intervento di Luca Giavi – Direttore del Consorzio del Prosecco DOC, e del Pinot Grigio. Negli USA il Prosecco è l’unico vino che tiene nei consumi dei consumatori giovani negli USA e per il Pinot Grigio il 24,6% degli acquisti viene fatto da consumatori tra i 21 e 29 anni (fonte Statista, anno 2018).
Prosecco e Pinot Grigio hanno diverse cose in comune, oltre alla comune zona di provenienza (di diritto per il Prosecco, di fatto per il Pinot Grigio). Una è quella di essere vini poco considerati dalla critica enologica tradizionale. E se questo fosse uno dei motivi della loro popolarità? Slegati dai soliti codici di comunicazione hanno mantenuto una leggerezza, vicinanza al consumatore, autenticità, stile, che partono dal profilo del vino ed arrivano fino alla comunicazione (o viceversa, se preferite).
Attenzione questo non significa che tutti i vini, o tutto il vino, dovrebbe posizionarsi e comunicar come Prosecco e Pinot Grigio. L’adozione di un modello unico è inefficace, sia che si tratti di quello dell’Enosnob come del Socialite.
Ogni vino/cantina/territorio deve trovare e portare avanti la sua proposta originale. Molti non saranno vini adatti ad interessare i giovani consumatori e va benissimo così. L’importante è che nella varietà i giovani consumatori trovino proposte con cui potersi avvicinare al mondo del vino.
Vinophila: il metaverso.
La tavola rotonda è stata l’occasione per condividere i dati demografici dei 38.000 visitatori unici che nel solo mese di giugno hanno visitato il nostro sito (donne 51,8% – uomini 48,2%) :
Visiting Faculty, Wine Business Management
Wine Newsletter 02/2022 - Settembre
Lo scorso 14 luglio nell’ambito della Summer School dedicata al Marketing e Innovazione dei vini del Nord-Est, organizzata a Portogruaro dal MIB di Trieste, si è tenuta un’interessante tavola rotonda su come recuperare l’interesse dei giovani consumatori nei confronti del vino. Io ho partecipato trattando il tema del Pinot Grigio e portando la testimonianza di cosa sta succedendo dentro al metaverso Vinophila. Gli spunti sono stati molti e molto interessanti e quindi è stato necessario lasciarli decantare qualche giorno prima di poter cercare di trovare una sintesi e, soprattutto, ipotizzare delle soluzioni.
Calo dell’interesse dei giovani rispetto al vino: un vecchio problema.
Le ricerche degli ultimi 2-3 anni indicano in modo sostanzialmente univoco che in tutti i principali mercati di consumo sta diminuendo la quota di consumatori di vino nelle fasce più giovani (Millennials e Gen Z più “vecchi”). Non si tratta quindi solamente di un consumo pro-capite minore (sporadico, occasionale), ma di un numero inferiore di persone che bevono vino in assoluto.
Inferiore soprattutto al numero di persone che altri tipi di bevande alcoliche classiche, come birra e liquori e distillati, ed innovative, come Ready to Drink e Hard Seltzer. È un elemento cruciale da tenere in considerazione perché indica che oggi la priorità del settore vinicolo rispetto ai giovani consumatori non è offrire motivazioni per aumentarne il consumo pro-capite, ma è recuperarne l’interesse per allargare la platea di chi beve vino, anche sporadicamente.
Puntare infatti sul naturale spostamento delle preferenze verso il vino al crescere dell’età è uno scenario molto rischioso partendo da una platea che si riduce di anno in anno, soprattutto nella situazione di generale diminuzione di consumo di alcolici che si sta sempre più consolidando.
Interessante notare come quello del rapporto tra il vino e le fasce di consumatori più giovani sia un problema che è stato già evidenziato ed affrontato già da metà degli anni ’90. In quel caso i giovani erano la Generazione X e, se consideriamo gli USA, solo l’8% al tempo consumava vino settimanalmente. Oggi quegli stessi consumatori hanno tra 40 e 50 anni e la quota di consumatori regolari di vino è raddoppiata al 16%. Non è dato di sapere quanto questo incremento sia stato “naturale” oppure supportato dalle attività di marketing messe in atto dall’industria del settore.
Fatto sta che queste iniziative si sono interrotte una decina di anni dopo, anche in base ai risultati di una ricerca del 2015 che attribuiva ai Millennials il 42% del consumo di vino negli U.S.A.. Dato eclatante e sorprendente perché … era sbagliato, come ha dichiarato e corretto l’Istituto di Ricerca alcuni mesi dopo la pubblicazione (https://wineindustryadvisor.com/2016/03/24/wine-market-council-stands-by-research)
Una nuova comunicazione: uscire dal modello unico dell’Esperto.
Il principale imputato dello scarso interesse dei giovani riguardo al vino è il modo in cui viene comunicato, sai come contenuti che come stile. La macchietta del sommelier di Antonio Albanese è di 15 anni fa, ne ridevamo tutti, eppure la comunicazione del vino continua ad essere in grandissima parte quella: scostante, sussiegosa e professorale.
Nel suo interessante intervento Giulio Somma, Direttore del Corriere Vinicolo, si chiedeva se il mondo del vino i giovani dovesse convincerli o seguirli. In realtà né l’uno né l’altro, ma ascoltarli per coinvolgerli. Considerando che le ricerche sul mercato USA indicano che i criteri di scelta dei giovani consumatori sono la sostenibilità e l’esperienza del momento di consumo, Somma si chiedeva anche se comunicare tutti quegli elementi di qualità intrinseca (terroir, vitigno, tecniche enologiche, annata, ecc…)
La risposta è sì, ma in modo diverso e l’esempio l’ha fornito Lorenzo Foffani con il vino “Liar” (“bugiardo” in italiano) prodotto dall’azienda di famiglia da uve merlot vinificate in bianco. Un progetto di marketing a tutto tondo dove il concetto della marca nasce dalle caratteristiche oggettive del vino e del processo, ma si declina in una proposta che va oltre la semplice descrizione tecnica di territorio, vitigno ecc…
In una parola una proposta che non si basa sulle caratteristiche del prodotto, ma sui benefit che offre a chi lo sceglie https://www.adsoftheworld.com/campaigns/a-ripe-time-for-liars
Storytelling è da anni una parola abusatissima anche nel mondo del vino, che però nella stragrande maggioranza dei casi crede di raccontare storie mentre in realtà elenca fatti.
Disintermedizione, autenticità, divertimento.
Sono i tre pilastri della società digitale, che valgono, soprattutto per i digital native, anche nel vino.
Disintermediazione significa l’abitudine ad informarsi e scegliere da soli. Significa l’entrata in crisi della figura dell’esperto in tutti gli ambiti, dalla politica al critico enologico, rispetto alle proprie cerchie di conoscenze, che possono includere anche la celebrità a cui si parlare direttamente sui social.
Autenticità significa trasparenza, correttezza e coerenza rispetto a chi si è, ai valori che ci contraddistinguono ed alle posizioni che prendiamo di conseguenza. Attenzione perché parlando di consumatori “giovani” il rischio di prendere posizioni “giovanilistiche” cercando goffamente di appropriarsi di linguaggi e tendenze è sempre dietro l’angolo nelle agenzie di comunicazione e nelle aziende. Rischio pericolosissimo perché porta a realizzare strategie palesemente finte.
Divertimento che può essere puro e semplice oppure declinarsi nelle forme più diverse: edutainment, gamification, ecc… Non è un caso se i consumatori sotto in trent’anni evitano Facebook ed usano invece Tik Tok.
Prosecco e Pinot Grigio.
Durante la tavola rotonda si è parlato anche di due tipologie di vino: il Prosecco, grazie all’intervento di Luca Giavi – Direttore del Consorzio del Prosecco DOC, e del Pinot Grigio. Negli USA il Prosecco è l’unico vino che tiene nei consumi dei consumatori giovani negli USA e per il Pinot Grigio il 24,6% degli acquisti viene fatto da consumatori tra i 21 e 29 anni (fonte Statista, anno 2018).
Prosecco e Pinot Grigio hanno diverse cose in comune, oltre alla comune zona di provenienza (di diritto per il Prosecco, di fatto per il Pinot Grigio). Una è quella di essere vini poco considerati dalla critica enologica tradizionale. E se questo fosse uno dei motivi della loro popolarità? Slegati dai soliti codici di comunicazione hanno mantenuto una leggerezza, vicinanza al consumatore, autenticità, stile, che partono dal profilo del vino ed arrivano fino alla comunicazione (o viceversa, se preferite).
Attenzione questo non significa che tutti i vini, o tutto il vino, dovrebbe posizionarsi e comunicar come Prosecco e Pinot Grigio. L’adozione di un modello unico è inefficace, sia che si tratti di quello dell’Enosnob come del Socialite.
Ogni vino/cantina/territorio deve trovare e portare avanti la sua proposta originale. Molti non saranno vini adatti ad interessare i giovani consumatori e va benissimo così. L’importante è che nella varietà i giovani consumatori trovino proposte con cui potersi avvicinare al mondo del vino.
Vinophila: il metaverso.
La tavola rotonda è stata l’occasione per condividere i dati demografici dei 38.000 visitatori unici che nel solo mese di giugno hanno visitato il nostro sito (donne 51,8% – uomini 48,2%) :
- 18 – 24 anni: 13%
- 25 – 34 anni: 25%
- 35 – 44 anni: 24%
- 45 – 54 anni: 19%
- 55 – 64 anni: 13%
- oltre 65 anni: 6%
Quali saranno i futuri consumatori del vino?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2022 - Maggio
Riuscire ad attrarre con successo consumatori più giovani nella categoria è la più grande sfida per il settore vinicolo. Oggi, la maggiore preoccupazione per chi si occupa di marketing del vino, sta diventando il lento e tardivo interesse da parte delle generazioni più giovani. Ma è il sistema stesso che fatica ad adattare le proprie strategie di marketing e di comunicazione nei confronti dei nuovi consumatori. Anche a causa della pandemia, inoltre, i giovani di alcuni tra i principali mercati internazionali (es. USA, UK, Canada e Australia) stanno rivoluzionando i consumi: se gli over 55 abbandonano la categoria dei vini spumanti, Millennials e Generazione Z invece scelgono di consumare bollicine anche a pranzo e dopo il lavoro.
Nel rapporto con il vino, i consumatori più giovani, appartenenti alla Generazione Z e Millennials, hanno un approccio differente dalle generazioni che li hanno preceduti, sia nei fattori di scelta e di consumo che nella comunicazione, con una rilevanza molto maggiore dei social media e degli influencer. Ma, allo stesso tempo, sono proprio i giovani ad adottare e a guidare alcuni trend globali quali quelli della ricerca di prodotti sostenibili e “green”, della moderazione nel consumo di alcolici e dell’adozione di packaging alternativi.
In particolare, il vino confezionato in lattina d’alluminio è oggi una realtà che sta prendendo sempre più piede a livello mondiale, con volumi di affari in continua crescita che raggiungeranno il miliardo di dollari in pochi anni (dati IWSR). Anche in Italia la percezione del vino in lattina sembra essere migliorata, come già avvenuto sul mercato britannico, francese, australiano e americano, i primi a utilizzare le lattine per vini di qualità. In questa categoria il contributo dei giovani consumatori, più curiosi e liberi dalle sovrastrutture che hanno condizionato le precedenti generazioni, è fondamentale, sia per fattori di scelta legati alla praticità e all’occasione di consumo, sia per l’affermarsi sul mercato di nuovi modelli di bere responsabile, che pongono l’accento sui temi della sostenibilità ambientale.
Il vino italiano, quindi, a iniziare dal sistema vitivinicolo del Nord-Est, deve guardare oltre il proprio successo. Se il Pinot Grigio, infatti, è il vino dei “Baby Boomer” (oggi sessantenni) e il Prosecco quello simbolo della Generazione X e dei Millennial più anziani (35-55 anni), quali opportunità potranno nascere dalle generazioni di consumatori più giovani, come tipologie, stili o packaging?
Sarà incentrata proprio sul marketing verso le giovani generazioni di consumatori la prossima Summer School di MIB Trieste School of Management che avrà inizio lunedì 11 luglio per concludersi venerdì 15 luglio 2022. Il Programma svilupperà contenuti focalizzati sulle imprese vinicole del Nord-Est, con particolare attenzione agli aspetti legati alle giovani generazioni (Millennial e Generazione Z), declinata dal marketing alla comunicazione.
Il vino biologico e sostenibile cresce. I consumatori sono pronti a pagare di più?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2022 - Maggio
(articolo pubblicato sul Corriere Vinicolo, aprile 2022)
Il vino biologico cresce di numero e di qualità. Ma sappiamo come comunicarlo ai bevitori di vino? E i consumatori sono davvero interessati ai vini biologici e sostenibili?
Spostate a metà gennaio, al posto del tradizionale appuntamento di inizio dicembre, le degustazioni per il concorso Mundus Vini Biofach, a cui ho partecipato in qualità di giudice, hanno confermato come il vino biologico si stia consolidando nei numeri e nella qualità dell'offerta. Il Gran Premio Internazionale del Vino Biologico Mundus Vini Biofach è un concorso internazionale organizzato in Germania da Meininger Verlag per i vini biologici provenienti da tutte le zone di produzione del mondo. E mai come quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di degustare alla cieca vini biologici, biodinamici e sostenibili provenienti da molti paesi produttori, con una presenza crescente anche dall'Europa dell'Est fino alla Georgia e al Nuovo Mondo, con diverse centinaia di assaggi presentati. I risultati del concorso saranno presentati a luglio alla Fiera BioFach di Norimberga.
Partecipando da alcuni anni a queste degustazioni ho potuto testimoniare in prima persona sia il miglioramento qualitativo medio dei vini presentati al Concorso (i difetti legati in passato alla viticoltura biologica sono ormai un'eccezione) sia la maggiore credibilità che questi vini raccolgono all’interno della critica e degli operatori (la giuria del concorso è composta da un mix di giornalisti, degustatori, professionisti, distributori e rivenditori). A conferma di quanto analizzato da due distinti studi che, negli ultimi anni, hanno analizzato i punteggi di 200.000 vini forniti da critici indipendenti sia in California che in Francia, dimostrando che i vini prodotti da uve prodotte biologicamente o biodinamicamente hanno un sapore migliore.
Ciò che gli studi hanno inoltre rilevato è che c'è anche un marcato aumento della qualità dei vini prodotti con uve biologiche o da agricoltura biodinamica, come rilevato sulla base della valutazione dei critici enologici, che sebbene riconosciuta tra i produttori di vino, non è stata necessariamente comunicato efficacemente ai consumatori.
Ma chi beve vino biologico?
A gennaio, in occasione della fiera Millésime Bio di Montpellier (il più grande evento b2b dedicato alla produzione da agricoltura biologica), è stata presentata una ricerca dell'Osservatorio Europeo del Consumo di Vino Biologico, realizzata a fine 2021 da Ipsos intervistando 3.000 persone dai 18 anni in su (1.000 per la Germania, 1.000 per la Francia e 1.000 per il Regno Unito).
L'Europa occidentale consuma sempre meno vino. Se l'82% dei tedeschi, britannici e francesi intervistati aveva dichiarato nel 2015 di aver consumato vino negli ultimi sei mesi, tale percentuale è scesa al 73% nel 2021. Allo stesso tempo, il segmento dei vini più rispettosi dell'ambiente è in controtendenza. Più di un terzo dei consumatori francesi (36%), ad esempio, ha dichiarato di bere regolarmente o occasionalmente bottiglie di vino biologico. Il consumo di queste bevande è addirittura aumentato poiché solo il 17% dei francesi aveva acquistato vini biologici durante il primo studio di questo tipo sei anni fa. Un salto quantitativo che si può osservare in Europa, anche se i francesi sono molto più avanti dei vicini: il 23% dei tedeschi e il 27% degli inglesi hanno aggiunto questi vini al carrello della spesa.
Questo crescente interesse per il vino biologico, biodinamico e sostenibile ha diverse spiegazioni. Il primo è legato alla preoccupazione di preservare l'ambiente. Il 54% degli intervistati ritiene che la produzione di vino biologico sia più ecologica di quella del vino convenzionale. La seconda leva di acquisto sta nella curiosità suscitata dal vino “verde”, che il 40% degli intervistati vuole degustare. Infine, il 35% del campione è pronto ad acquistare vino biologico perché favorirebbe un settore produttivo ritenuto più equo, soprattutto in termini di creazione di posti di lavoro.
Oggi siamo passati dal consumo per curiosità al consumo permanente e i produttori di vino biologico hanno molte ragioni per essere ottimisti sul futuro. Dall'indagine emerge che il wine lover biologico è piuttosto giovane (meno di 35 anni) e urbano, con un potere d'acquisto superiore alla media. Conseguenza: accetta di mettere in mano il portafogli per pagare in media 14 euro a bottiglia (contro gli 11,70 euro di un vino tradizionale). Questo dimostra che è pronto a pagare di più quando il prodotto rispetta l'ambiente, ne rassicura la tracciabilità e garantisce una migliore remunerazione ai produttori.
Ci sono molti modi per consolidare questa svolta nel vino biologico. A cominciare dall'educazione dei consumatori, dal momento che il 38% degli intervistati ritiene di non disporre di informazioni sufficienti sui prodotti. Pertanto, in tutti i materiali di comunicazione, dalle etichette al web, sui canali digitali e social, durante le visite alle cantine e le fiere, fornire informazioni chiare, coerenti con l'identità aziendale e gli obiettivi che hanno portato a scegliere la produzione biologica. Questo fa parte della strategia e non è solo un elemento tattico.
Il biologico e la sostenibilità sono importanti per i consumatori di vino?
Il concetto di sostenibilità – in tutte le sue forme e definizioni – è diventato negli ultimi anni un potente motore del sentiment dei consumatori. Queste tendenze hanno messo radici nell'industria globale dell'alcol, e per una buona ragione. Secondo i dati raccolti per l'IWSR Covid Tracker 2021, quasi la metà dei bevitori adulti americani di bevande alcoliche (48%) e il 70% dei bevitori di alcolici cinesi hanno affermato di essere stati "influenzati positivamente" ad acquistare marchi con credenziali ambientali o di sostenibilità dimostrabili.
La storia della sostenibilità e del vino risale più a lungo della maggior parte delle industrie. I vini biologici sono stati una caratteristica delle liste dei vini dei ristoranti di lusso e dei negozi indipendenti dall'inizio degli anni '80. Grazie alla forte difesa del suo monopolio statale al dettaglio, Systembolaget, il vino biologico in Svezia rappresenta quasi 1 bottiglia di vino su 4 venduta in quel mercato.
Più recentemente, la categoria dei vini ha assistito a ulteriori sviluppi della sostenibilità. Questi includono vini biodinamici e naturali (o a basso intervento), che portano il concetto di sostenibilità a un livello abbastanza elementare consentendo lo svolgimento di processi fermentativi naturali privi di input chimici o lieviti selezionati. Anche numerosi paesi e regioni produttori di vino hanno stabilito i propri standard di sostenibilità e hanno utilizzato la loro forza di marketing per incentivare i produttori a conformarsi.
Come ci si potrebbe aspettare, i consumatori di vino sono almeno altrettanto appassionati di sostenibilità in generale. Nell'ultimo rapporto strategico, "Opportunità per i vini alternativi", la ricerca di Wine Intelligence ha rilevato che tra il 56% e il 67% dei consumatori di vino nei principali mercati del vino (Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Svezia e Australia) aveva un forte legame con la sostenibilità in generale, a giudicare dalle loro risposte a una serie di affermazioni sull'argomento.
Tuttavia. sembra emergere una discrepanza tra il loro atteggiamento più generale nei confronti della sostenibilità e la volontà di tradurre questo desiderio nel loro comportamento di acquisto di vino. Tra tutti i bevitori abituali di vino, la disponibilità a pagare vini più sostenibili, o ad optare per vini sostenibili, data la possibilità di scelta, è scesa a circa un terzo dei consumatori negli stessi mercati.
Questa discrepanza tra ciò che i consumatori affermano di voler fare in relazione all'ambiente e ai prodotti sostenibili, e ciò che effettivamente fanno, può dipendere da una varietà di fattori, tra cui l'influenza sociale (le persone copiano le abitudini degli altri), l'effetto domino (alle persone piace essere coerenti) e lanciare messaggi che risuonino sia a livello razionale che emotivo.
Convincere le persone ad acquistare in modo sostenibile rimane una sfida importante per il settore del vino, poiché ci sono molte ragioni per tornare a scegliere alternative meno sostenibili: il prezzo (tipicamente) più alto è uno dei principali fattori di dissuasione. Il lato positivo per la categoria del vino, come documentato nei dati di monitoraggio di Wine Intelligence, è che il trend di utilizzo sembra muoversi in una direzione positiva. Il Wine Intelligence Alternative Wine Opportunity Index, una misura composta del coinvolgimento dei consumatori in categorie di vino (tra cui sostenibile, biologico, naturale, biodinamico e del commercio equo e solidale) sta mostrando una crescita su tutta la linea.
All'interno di questo gruppo, l'elemento di spicco negli ultimi due anni è stato il vino naturale. Questa tipologia ha beneficiato negli ultimi anni di un ampio supporto all'interno della comunicazione e della distribuzione del vino, in particolare dell'influente comunità dei sommelier, e ora può essere trovato sulle carte dei vini in molti bar e ristoranti attenti alla moda nelle principali città del mondo sviluppato.
Ciò che sembra distinguere il vino naturale da molti altri prodotti vitivinicoli “sostenibili” è che la sua attrazione fondamentale è più focalizzata sull'intrinseco (il processo in cui viene prodotto il vino rende il suo profilo gustativo molto caratteristico). Ciò contrasta con il vino biologico più consolidato, che continua anche a creare un pubblico, ma a un tasso di crescita meno spettacolare. I vini biologici possono pretendere di offrire una migliore esperienza di gusto per il consumatore, ma è più probabile che il punto di forza del biologico sia estrinseco (la percezione della categoria come una scelta etica o sostenibile).
Detto questo, la strategia deliberata di Systembolaget in Svezia di mettere a listino un numero crescente di vini biologici nei suoi negozi al dettaglio ha portato la Svezia a diventare uno dei mercati di vino biologico più grandi e di maggior successo al mondo, fornendo un buon esempio di effetto da “influenza sociale”. Anche il vino naturale sembra beneficiare dello stesso effetto, in un segmento più coinvolto della popolazione che beve vino nelle città più grandi come Londra e New York. Il mercato del vino sostenibile può semplicemente richiedere più di queste spinte di influenza sociale per diventare accettabile e desiderato nel mainstream?
Cosa ha insegnato l’emergenza Covid al settore del vino?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2021 - Settembre
Quali insegnamenti restano, da questo periodo complesso, a chi si occupa di marketing e comunicazione nelle aziende vinicole o nell’accoglienza enoturistica, ora che si respira voglia di una nuova normalità? Ecco alcuni spunti che riteniamo importanti a che affronteremo anche con i partecipanti della IX edizione del nostro Corso in Wine Business Management in partenza il 18 novembre 2021.
Credo tutti, in questi mesi, abbiamo utilizzato i iniziato a conoscere piattaforme quali Netflix e Prime, che stanno abituando gli utenti a scegliere cosa vedere e quando. Come estenione dell’on-demand, la consegna veloce a casa, ossia il delivery inizialmente focalizzato sul cibo, sta progressivamente interessando anche il vino, sia attraverso applicazioni specializzate quali Winelivery che grazie all’intraprendenza di enoteche e rivenditori specializzati. Bottiglie che verranno consegnate in poche decine di minuti, non dopo giorni come avviene per i prodotti acquistati via e-commerce (ad es. su Tannico o Vino.com). Una modalità che cambierà, almeno in parte, il modo di fruire l’intera enogastronomia tra le mura domestiche.
A proposito di e-commerce, è il grande vincitore della pandemia anche nel settore vinicolo. Da un lato, molte aziende hanno sviluppato un portale o si sono create una vetrina; dall’altro, tante piccole realtà si sono affacciate con successo alla vendita on-line, aprendo nuovi mercati che prima erano preclusi.
Lavorare da casa o, comunque, passarci più tempo significa frequentare maggiormente i negozi, le enoteche e i ristoranti di vicinato, forse anche ricostruirsi una socialità di quartiere. Ciò offre opportunità per raggiungere questi consumatori in modo più diretto, ad es. attraverso una segmentazione geografica, la presenza su specifici punti vendita, l’organizzazione di micro-eventi o offerte dedicate ma anche i servizi di geolocalizzazione offerti da Google. Preparatevi ad inserire nel vostro piano di marketing una serie di azioni tattiche per raggiungere questi nuovi mercati di prossimità.
Il tutto in un’ottica di multicanalità, che ha visto il canale on-line affiancarsi a quello tradizionale. Che si tratti del punto vendita interno o esterno alla cantina (es. negozio o ristorante), la multicanalità c’è sempre stata, sia come necessità che opportunità. Un’azienda vinicola oggi deve vendere nello shop visite e degustazioni ai turisti, bottiglie per asporto, consegnare direttamente a casa, avere una presenza commerciale online (diretta o indiretta), saper trattare con la Distribuzione Organizzata (anche locale) se ne ha i numeri e le potenzialità oppure partecipare a fiere mercato per la vendita diretta. La multicanalità è regina nella comunicazione e la potenzia.
Per gestire i canali e in particolare quelli della vendita e della comunicazione diretta con i propri clienti (o per attrarne di nuovi), si deve imparare a padroneggiare il direct marketing. Da un lato raccogliendo dati sulla clientela (non servono sofisticati sistemi di CRM, basta veramente un foglio Excel aggiornato costantemente), dall’altro sviluppando il rapporto. E i social in questo sono molto utili, se integrati con le newsletter, il blog, il sito, l’e-commerce…
Già da anni ripetiamo ai nostri studenti che le visite aziendali non devono essere gestite in modo standardizzato. Che si tratti delle degustazioni o di gestire un’attività di ristorazione, il ruolo del servizio e di chi racconta e personalizza la comunicazione è fondamentale per togliere quella patina del “carino ma freddo, potrebbe stare ovunque”. A seguito della pandemia, si è formato nei consumatori un bisogno di vivere esperienze reali, autentiche e personalizzate. Ecco il boom delle vacanze rurali, della scoperta di borghi e città d’arte, della frequentazione di aziende agricole, vigneti e artigiani del cibo.
Indipendentemente dalle norme previste dai vari DPCM, lo stesso distanziamento rimarrà un fattore rilevante per i nostri consumatori e enoturisti. Siamo certi che, in alcuni ambienti e circostanze, le persone non avranno piacere a stare tutte appiccicate. E non si tratta solo di autobus e metropolitane. Parliamo di sale degustazioni, visite guidate, ristoranti aziendali. I clienti non apprezzeranno (almeno per un po’) i tavoli troppo vicini e gli spazi stretti.
Infine la sostenibilità: è un macro-trend che coinvolge molti aspetti, dall’affermazione del biologico al “senza questo ingrediente” o “libero da”. Nel caso del vino ha risvolti anche molto pratici, che possono premiare e posizionare meglio chi ad es. fa uso di packaging biodegradabili nella sala degustazione o riciclabili per il trasporto e la consegna.
Nel prossimo futuro questi cambiamenti culturali, attitudinali e sociali continueranno a svilupparsi,modificando sia la percezione che il comportamento di acquisto dei consumatori e degli enoturisti, fino a modificare, per molte aziende, il proprio modello di business. Attivamente, gestendoli, o passivamente, subendoli. Il nostro suggerimento è quello di conoscere per agire, attraverso una formazione permanente che fornisca strumenti e chiavi di lettura adeguate.
Trend globali nel vino da conoscere: i vini rosati e le opportunità per il vino rosa italiano
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Quello del vino rosato è uno dei più impressionanti fenomeni commerciali in diversi mercati internazionali. Sui social media sembra che tutti stiano bevendo qualcosa di color rosa, che si tratti di un bicchiere di vino rosato dal color pallido o di un “pink” gin. È indubbio che l'appeal visivo e l'aumento della qualità del vino rosato attirano i consumatori di tutte le età e di tutti i generi.
La categoria dei vini rosati ha continuato a crescere anche durante la pandemia, spinta dall’attrattività per tutti i gruppi di consumatori e sostenuta dalla crescente premiumizzazione all'interno di questa sottocategoria. Il rosé beneficia anche dell'essere associato ad essere una bevanda che è percepita come "un regalo in cui indulgere" e che diversi analisti ritengono potrebbe aumentare i tassi di vendita a medio o lungo termine.
Secondo i dati che emergono dai sondaggi che Wine Intelligence (di cui sono confermati i seminari anche nella prossima edizione del Corso in Wine Business Management) ha svolto negli ultimi anni a livello internazionale, la percentuale di consumatori vino rosato è aumentata in modo significativo dal 2007 su molti mercati, spostandosi da un rosato di prezzo inferiore a un rosato più premium, con la Provenza che guida il mercato dei rosati di qualità. I rosati stanno seguendo la tendenza dei consumatori verso vini bianchi più aromatici, freschi, con un contenuto alcolico inferiore e per vini rossi dai tannini più leggeri. I vini rosati, così appunto i vini più freschi e a basso tannino, sembrano avanzare su tutti i fronti. Può essere un’opportunità anche per il vino italiano?
A inizio giugno sono stato invitato inAbruzzo a partecipare come degustatore all’evento “Food&Rosé Selection 2021” con l'assaggio alla “cieca” di 110 vini rosati, tutti premiati a marzo con le Grandi medaglie d'oro e le Medaglie d'oro, nella prima edizione della Selezione Rosé del Concours mondial de Bruxelles. In tale occasione ho tenuto una relazione per tutti i membri delle commissioni di assaggio (giornalisti, enologi, importatori e rivenditori di vino di oltre 20 paesi) sulle tendenze globali del vino e le opportunità del rosé, dove ho illustrato la nuova geografia dell'internazionalizzazione di un prodotto dalle enormi potenzialità ancora inespresse.
Il vino rosato in alcuni mercati è di nicchia, mentre in altri è un vino già affermato, basti considerare che in Francia si beve più il rosa che il bianco o il rosso, e il consumo è superiore alla produzione. La Francia, già capitale mondiale del rosé, così come il Nord Europa, il Giappone e la Corea del Sud possono risultare mercati da conquistare per i vini rosati italiani. Il fenomeno che si sta registrando, infatti, è il consumo crescente di piatti a base di vegetali e carni leggere, con cui il rosato si abbina alla perfezione, e aumenta anche il consumo di fascia alta, come vino pregiato e anche invecchiato. Punto di forza dei rosati italiani è la varietà che possiamo offrire, dal Cirò calabrese al Cerasuolo abruzzese, passando per il Chiaretto del Garda, ciascuno con la sua storia, la sua identità e peculiarità, mentre in altri Paesi il prodotto è più standardizzato verso la copia dei vini provenzali.
La prossima sfida è quindi pianificare una strategia comune per affermare i vini rosati italiani prima a livello nazionale e poi a livello regionale (Regione di Origine e Denominazioni), creando un’offerta congiunta che sappia coniugare le diversità all’interno di una proposta volta a costruire l’immagine e il marchio del “vino rosa italiano”. Potrà essere il Prosecco Rosé, che a nostro avviso sarà la prossima “disruption” nel mondo vinicolo internazionale con le sue oltre 40 milioni di bottiglie già immesse in commercio, il treno giusto da prendere?
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2021 - Settembre
Quello del vino rosato è uno dei più impressionanti fenomeni commerciali in diversi mercati internazionali. Sui social media sembra che tutti stiano bevendo qualcosa di color rosa, che si tratti di un bicchiere di vino rosato dal color pallido o di un “pink” gin. È indubbio che l'appeal visivo e l'aumento della qualità del vino rosato attirano i consumatori di tutte le età e di tutti i generi.
La categoria dei vini rosati ha continuato a crescere anche durante la pandemia, spinta dall’attrattività per tutti i gruppi di consumatori e sostenuta dalla crescente premiumizzazione all'interno di questa sottocategoria. Il rosé beneficia anche dell'essere associato ad essere una bevanda che è percepita come "un regalo in cui indulgere" e che diversi analisti ritengono potrebbe aumentare i tassi di vendita a medio o lungo termine.
Secondo i dati che emergono dai sondaggi che Wine Intelligence (di cui sono confermati i seminari anche nella prossima edizione del Corso in Wine Business Management) ha svolto negli ultimi anni a livello internazionale, la percentuale di consumatori vino rosato è aumentata in modo significativo dal 2007 su molti mercati, spostandosi da un rosato di prezzo inferiore a un rosato più premium, con la Provenza che guida il mercato dei rosati di qualità. I rosati stanno seguendo la tendenza dei consumatori verso vini bianchi più aromatici, freschi, con un contenuto alcolico inferiore e per vini rossi dai tannini più leggeri. I vini rosati, così appunto i vini più freschi e a basso tannino, sembrano avanzare su tutti i fronti. Può essere un’opportunità anche per il vino italiano?
A inizio giugno sono stato invitato inAbruzzo a partecipare come degustatore all’evento “Food&Rosé Selection 2021” con l'assaggio alla “cieca” di 110 vini rosati, tutti premiati a marzo con le Grandi medaglie d'oro e le Medaglie d'oro, nella prima edizione della Selezione Rosé del Concours mondial de Bruxelles. In tale occasione ho tenuto una relazione per tutti i membri delle commissioni di assaggio (giornalisti, enologi, importatori e rivenditori di vino di oltre 20 paesi) sulle tendenze globali del vino e le opportunità del rosé, dove ho illustrato la nuova geografia dell'internazionalizzazione di un prodotto dalle enormi potenzialità ancora inespresse.
Il vino rosato in alcuni mercati è di nicchia, mentre in altri è un vino già affermato, basti considerare che in Francia si beve più il rosa che il bianco o il rosso, e il consumo è superiore alla produzione. La Francia, già capitale mondiale del rosé, così come il Nord Europa, il Giappone e la Corea del Sud possono risultare mercati da conquistare per i vini rosati italiani. Il fenomeno che si sta registrando, infatti, è il consumo crescente di piatti a base di vegetali e carni leggere, con cui il rosato si abbina alla perfezione, e aumenta anche il consumo di fascia alta, come vino pregiato e anche invecchiato. Punto di forza dei rosati italiani è la varietà che possiamo offrire, dal Cirò calabrese al Cerasuolo abruzzese, passando per il Chiaretto del Garda, ciascuno con la sua storia, la sua identità e peculiarità, mentre in altri Paesi il prodotto è più standardizzato verso la copia dei vini provenzali.
La prossima sfida è quindi pianificare una strategia comune per affermare i vini rosati italiani prima a livello nazionale e poi a livello regionale (Regione di Origine e Denominazioni), creando un’offerta congiunta che sappia coniugare le diversità all’interno di una proposta volta a costruire l’immagine e il marchio del “vino rosa italiano”. Potrà essere il Prosecco Rosé, che a nostro avviso sarà la prossima “disruption” nel mondo vinicolo internazionale con le sue oltre 40 milioni di bottiglie già immesse in commercio, il treno giusto da prendere?
Favorire il network, creare nuovi progetti e sviluppare il pensiero creativo
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Il Corso in Wine Business Management è un programma costruito con un preciso approccio pedagogico, che fonde aspetti teorici tipici di una Business School internazionale con sessioni pratiche e applicative.
Fino ad oggi, nelle varie attività formative per il settore vitivinicolo abbiamo scelto di trasferire tutti i contenuti durante le sessioni d’aula, lasciando al mondo della comunicazione digitale in generale alcuni momenti quali tutoraggi individuali o di gruppo.
I programmi didattici sono disegnati attorno alle persone e lo sviluppo dei contenuti in presenza ne aumenta molto l’efficacia attraverso attività interattive e di confronto, rispetto ad esperienze on-line.
Poi è arrivato il Covid-19 e, anche nel nostro caso, abbiamo forzatamente rivisto programmi e docenze, utilizzando per una parte, fortunatamente minoritaria, della VIII edizione del Corso lo strumento dei webinar.
Anche alla luce della recente esperienza, abbiamo accelerato un processo che già vedeva la Scuola impegnata nello sviluppo di didattica a distanza principalmente per il settore assicurativo e finanziario.
Così, dalla prossima edizione del Corso in WBM, che avrà inizio il 26 novembre e di cui stiamo procedendo all’iter di selezione, la didattica on-line si affiancherà a quella tradizionale d’aula, grazie a 6 seminari a distanza, attraverso piattaforma webinar.
I primi 5 saranno realizzati in collaborazione con l’agenzia Wine Intelligence di Londra sui temi del Marketing Internazionale e dei consumatori vinicoli, al fine di fornire agli studenti puntuali approfondimenti sull’impatto della pandemia da Coronavirus nel marketing e nella distribuzione del vino.
L’ultimo seminario sarà un approfondimento della giornata in presenza sulla gestione delle Risorse Umane, argomento che abbiamo inserito nel programma poiché riteniamo che saranno sempre più le persone a fare la differenza nelle aziende. Dal punto di vista aziendale, infatti, gli imprenditori vinicoli dovranno saper motivare i dipendenti e collaboratori ad assumersi nuove responsabilità in chiave manageriale e ottimizzare il lavoro dei team in azienda. Ma la crescita dell’impresa potrà giungere anche dal rafforzamento delle competenze personali, con lo sviluppo di capacità di pensiero creativo, il rinnovamento degli strumenti gestionali e l’acquisizione di nuovi contatti e opportunità in Italia e all’estero.
Un primo esempio di didattica “mista” è stata la nostra Summer School, tenuta tra luglio e agosto, incentrata su quali concetti di innovazione applicare per i vini del Nord-Est italiano, che ha visto i partecipanti confrontarsi con spunti e riflessioni molto aderenti alla situazione contingente dei mercati, dei consumatori e delle aziende. La Summer School si è conclusa con un esercizio, da svolgersi a distanza, su un esempio di innovazione che potrebbe essere adottato. Vogliamo qui premiare, pubblicandolo, il lavoro di Alessandra, Giorgia e Giulia che hanno analizzato come uno strumento come il QR-Code dovrebbe essere utilizzato per promuovere il vino e il territorio.
Ma la didattica in presenza, o una sua erogazione quanto più partecipativa, come detto sopra, manterrà un ruolo chiave non solo per fornire contenuti ma anche per cementificare le relazioni che si creano tra i partecipanti, persone che portano un background sviluppato nelle aziende e nelle loro attività professionali. In oltre 15 anni, infatti, nelle aule del MIB si sono formate proficue opportunità di confronto che hanno portato anche a sviluppare forme di collaborazione tra gli ex partecipanti, che spesso hanno iniziato percorsi professionali assieme.
Il primo esempio, Sinefinis, il metodo classico transfrontaliero italo-sloveno, tra le cantine Gradis’ciutta del Collio e Ferdinand della Brda, i cui titolari si sono conosciuti sui banchi del MIB, è ormai una realtà consolidata da diverse vendemmie. Su Sinefinis è stato recentemente scritto anche un significativo articolo.
L’ultimo esempio in ordine di tempo è Vitinera, una start-up creata da 5 studenti dell’Executive MBA, due dei quali hanno frequentato anche il Corso in Wine Business Management. Vitinera è una piattaforma che si prefigge di mettere l’appassionato del vino al centro di un’ampia scelta di “esperienze” da vivere direttamente in cantina o lungo i filari, con proposte spaziano tra degustazioni, cultura, storia, gastronomia, natura e anche sport. Su Vitinera è stato da poco pubblicato un ampio articolo dal Corriere Vinicolo, il più importante settimanale b2b per il settore vinicolo italiano.
Le piattaforme tecnologiche stanno modificando il modo in cui si insegna e studia, si acquista e si promuove il vino, si gestisce il business internamente alle aziende, come ci spiega Simone Fabbri, responsabile Wine Market Innovation del gruppo Marchesi Frescobaldi e docente di Supply Chain Management del Corso.
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2020 - Ottobre
Il Corso in Wine Business Management è un programma costruito con un preciso approccio pedagogico, che fonde aspetti teorici tipici di una Business School internazionale con sessioni pratiche e applicative.
Fino ad oggi, nelle varie attività formative per il settore vitivinicolo abbiamo scelto di trasferire tutti i contenuti durante le sessioni d’aula, lasciando al mondo della comunicazione digitale in generale alcuni momenti quali tutoraggi individuali o di gruppo.
I programmi didattici sono disegnati attorno alle persone e lo sviluppo dei contenuti in presenza ne aumenta molto l’efficacia attraverso attività interattive e di confronto, rispetto ad esperienze on-line.
Poi è arrivato il Covid-19 e, anche nel nostro caso, abbiamo forzatamente rivisto programmi e docenze, utilizzando per una parte, fortunatamente minoritaria, della VIII edizione del Corso lo strumento dei webinar.
Anche alla luce della recente esperienza, abbiamo accelerato un processo che già vedeva la Scuola impegnata nello sviluppo di didattica a distanza principalmente per il settore assicurativo e finanziario.
Così, dalla prossima edizione del Corso in WBM, che avrà inizio il 26 novembre e di cui stiamo procedendo all’iter di selezione, la didattica on-line si affiancherà a quella tradizionale d’aula, grazie a 6 seminari a distanza, attraverso piattaforma webinar.
I primi 5 saranno realizzati in collaborazione con l’agenzia Wine Intelligence di Londra sui temi del Marketing Internazionale e dei consumatori vinicoli, al fine di fornire agli studenti puntuali approfondimenti sull’impatto della pandemia da Coronavirus nel marketing e nella distribuzione del vino.
L’ultimo seminario sarà un approfondimento della giornata in presenza sulla gestione delle Risorse Umane, argomento che abbiamo inserito nel programma poiché riteniamo che saranno sempre più le persone a fare la differenza nelle aziende. Dal punto di vista aziendale, infatti, gli imprenditori vinicoli dovranno saper motivare i dipendenti e collaboratori ad assumersi nuove responsabilità in chiave manageriale e ottimizzare il lavoro dei team in azienda. Ma la crescita dell’impresa potrà giungere anche dal rafforzamento delle competenze personali, con lo sviluppo di capacità di pensiero creativo, il rinnovamento degli strumenti gestionali e l’acquisizione di nuovi contatti e opportunità in Italia e all’estero.
Un primo esempio di didattica “mista” è stata la nostra Summer School, tenuta tra luglio e agosto, incentrata su quali concetti di innovazione applicare per i vini del Nord-Est italiano, che ha visto i partecipanti confrontarsi con spunti e riflessioni molto aderenti alla situazione contingente dei mercati, dei consumatori e delle aziende. La Summer School si è conclusa con un esercizio, da svolgersi a distanza, su un esempio di innovazione che potrebbe essere adottato. Vogliamo qui premiare, pubblicandolo, il lavoro di Alessandra, Giorgia e Giulia che hanno analizzato come uno strumento come il QR-Code dovrebbe essere utilizzato per promuovere il vino e il territorio.
Ma la didattica in presenza, o una sua erogazione quanto più partecipativa, come detto sopra, manterrà un ruolo chiave non solo per fornire contenuti ma anche per cementificare le relazioni che si creano tra i partecipanti, persone che portano un background sviluppato nelle aziende e nelle loro attività professionali. In oltre 15 anni, infatti, nelle aule del MIB si sono formate proficue opportunità di confronto che hanno portato anche a sviluppare forme di collaborazione tra gli ex partecipanti, che spesso hanno iniziato percorsi professionali assieme.
Il primo esempio, Sinefinis, il metodo classico transfrontaliero italo-sloveno, tra le cantine Gradis’ciutta del Collio e Ferdinand della Brda, i cui titolari si sono conosciuti sui banchi del MIB, è ormai una realtà consolidata da diverse vendemmie. Su Sinefinis è stato recentemente scritto anche un significativo articolo.
L’ultimo esempio in ordine di tempo è Vitinera, una start-up creata da 5 studenti dell’Executive MBA, due dei quali hanno frequentato anche il Corso in Wine Business Management. Vitinera è una piattaforma che si prefigge di mettere l’appassionato del vino al centro di un’ampia scelta di “esperienze” da vivere direttamente in cantina o lungo i filari, con proposte spaziano tra degustazioni, cultura, storia, gastronomia, natura e anche sport. Su Vitinera è stato da poco pubblicato un ampio articolo dal Corriere Vinicolo, il più importante settimanale b2b per il settore vinicolo italiano.
Le piattaforme tecnologiche stanno modificando il modo in cui si insegna e studia, si acquista e si promuove il vino, si gestisce il business internamente alle aziende, come ci spiega Simone Fabbri, responsabile Wine Market Innovation del gruppo Marchesi Frescobaldi e docente di Supply Chain Management del Corso.
QR Code: il portale del territorio
Alessandra Fadda, Giorgia Lazzaroni e Giulia Filippi
Partecipanti alla 2a Summer School sul Marketing dei vini del Nord-Est
L'avvento del Covid-19 ha segnato un’improvvisa battuta d'arresto ad una parte del comparto vitivinicolo italiano e mondiale, quella più legata alla vendita diretta al consumatore e al settore ho.re.ca. Dopo un momento iniziale di comprensibile smarrimento, come tutti i settori anche quello del vino si è rimesso in marcia nonostante la situazione economico-sociale anomala, carica di incertezze. Attraverso approcci più o meno professionali, i protagonisti di settore – le aziende, i consorzi e gli enti - hanno iniziato un consistente lavoro di riflessione e di ripensamento della propria realtà.
Come rilevano le ricerche di Wine Intelligence, i fattori che avranno maggiore incidenza sul valore del vino nel prossimo futuro sono da rintracciarsi nel maggiore utilizzo del digitale, nella consapevolezza da parte del consumatore della sua esperienza d'acquisto, nel crescente approccio critico alla sostenibilità etica e ambientale del prodotto e del lavoro e nello spostamento del potere d’acquisto.
I mesi di lockdown, comuni a tutte le persone, sono stati quindi il momento ideale per le aziende per ripensare dalle fondamenta le proprie strategie e interrogarsi sull’ identità del brand, sulle qualità che ne determinano l'autenticità, sui modelli di business e sulle strategie di marketing e comunicazione finora adottate.
L'azienda ripensa anche il prodotto e l'organizzazione delle risorse umane.
Il lavoro di riflessione è dunque il passaggio preliminare e necessario per traghettare l'azienda dalla passività all'azione ovvero per stimolarla ad intraprendere le misure di cambiamento necessarie per adattarsi alla situazione attuale e dare risposta alle istanze provenienti dall'ambiente economico nel quale è inserita. Alcune tendenze già presenti sul mercato del vino ma considerate di secondaria importanza, nel periodo di lockdown hanno vissuto una nuova vita grazie al cambiamento delle tendenze di consumo. È il caso della crescita esponenziale delle vendite di bag in box e di vino da e-commerce: il vino acquistato crea un precedente positivo che continuerà anche dopo il lockdown.
Ne deduciamo quindi che l'investimento nel cambiamento è una tappa obbligata per l'evoluzione e, soprattutto, la sopravvivenza dell'azienda nel mercato. La contingenza del momento, però, richiede di stressare un aspetto insito nel cambiamento stesso ma da sempre di difficile messa in pratica, cioè quello dell'innovazione.
L’innovazione
Dare una definizione univoca al termine “innovazione” non è facile, tuttavia, come delineato da Reka Haros, durante la sua lezione alla Summer School 2020 del MIB, l’innovazione presenta dei caratteri distintivi:

Il processo di innovazione non è scontato e riguarda vari campi interni alle singole realtà aziendali: dall’innovazione dei processi produttivi all’innovazione tecnologica e sviluppo dell’e-commerce ma anche fattori esterni come innovazione nei rapporti tra i vari soggetti ed enti e innovazione dei mercati. Nel mondo attuale, caratterizzato da nuovi trend e da cambiamenti nelle preferenze di consumo, si osserva come tutto converga verso la sostenibilità comportando inevitabilmente la revisione delle strategie aziendali e, nel piano operativo, richiedendo flessibilità e velocità nel cambiamento delle tattiche.
Sempre più frequentemente si parla di marketing 3.0, che unisce l’aspetto digitale del web all’emozionalità delle esperienze vissute in prima persona e che mirano, nel medio termine, a fidelizzare il cliente attraverso l’identità e l’immagine del prodotto e del brand. In questo tempo di recessione e di diminuzione dei consumi, l’innovazione si concretizza nel rendere efficaci le politiche di marketing in particolare strutturando delle strategie efficaci e mirate ad aumentare la quota di voce.
La vera innovazione è pertanto tornare ai principi fondamentali racchiusi nel marketing mix composto dalle quattro leve principali: Product, Place, Price e Promotion.
Analizziamo il modo in cui il QR CODE può rappresentare uno strumento innovativo di marketing di prodotto sfruttabile commercialmente con una adeguati investimenti e campagne, consentendo di fidelizzare il cliente grazie al racconto e all'esaltazione della territorialità.
Il QR CODE è un'ottima leva che può essere sfruttata per promuovere le singole realtà aziendali , le denominazioni ma anche il territorio; attraverso la creazione di sinergie con le altri componenti del contesto territoriale si generano esternalità positive materiali, differenziazione del prodotto e del territorio nei mercati globali, e di rete attraverso le quali i produttori realizzano effetti positivi sui costi. L’obiettivo finale potrebbe essere quello di utilizzare il QR CODE non solo per attrarre nuovi clienti ma anche nuovi turisti ai quali fornire un’offerta turistica completa.
Il QR Code
Il QR code in Europa e in Italia si diffonde alla fine degli anni 2000 arrivando gradualmente anche sui prodotti alimentari e il vino. Solitamente collegati al sito aziendale o a video pubblicitari, i QR code del mondo del vino diventano elementi descrittivi statici senza sfruttare il loro pieno potenziale.
Riteniamo che, grazie alla sua posizione strategica sul packaging, il codice possa diventare un driver di scelta nell'acquisto di un determinato prodotto perchè permette al consumatore di entrare in possesso non solo di un vino ma anche di una serie di informazioni che amplificano e rendono più suggestiva l'esperienza e stimolano così ad un nuovo acquisto futuro. Sfruttarlo al massimo del suo potenziale diventa quindi essenziale per il mondo del vino.
Collegando il codice ad un fuori sito, dal carattere meno istituzionale rispetto al sito aziendale, si ha a disposizione un bacino che può essere aggiornato con alta frequenza con informazioni ad uso del consumatore, a partire dalle schede tecniche ai video delle degustazioni. La comunicazione del vino diventa più immediata e il consumatore diventa in questo modo un consumatore consapevole del prodotto che sta bevendo, vive un’esperienza da specialista e i aumentano anche le possibilità di fidelizzazione al prodotto.
L’azienda o il consorzio che decidono di investire su questo metodo di comunicazione, hanno la possibilità di veicolare l’identità e l’autenticità del proprio brand con un riscontro diretto e immediato da parte del consumatore sul prodotto. Riteniamo che una specializzazione in questa direzione agganci quindi le fasce più giovani e quelle più digitalizzate, aumentando la propria quota voce su un canale inusuale, fuori dalla competizione dei social network, con immensi benefici a lungo termine alla propria comunicazione.
Le informazioni che l’azienda può trarre dall’uso da parte della clientela di questo strumento vanno dalla geolocalizzazione alle preferenze di acquisto. Su questa base si può decidere di fornire diverse informazioni all’interno della bottiglia.
Alcuni esempi di uso "intelligente" del QR code sono quelli della cantina Donnafugata che, anche se in modo statico, racconta e mette in primo piano la sostenibilità aziendale.
Biondi Santi, invece, ha investito fortemente su questo strumento vestendo i propri prodotti con l’etichetta smart dell’azienda pisana Modulgraf, che permette di stampare un QR code differente ad ogni bottiglia direttamente in linea di etichettamento, estraendo così molti dati interessanti dall’attivazione del codice e facendo uno storytelling customizzato a seconda della fascia di prodotto acquistato.
Tra le realtà del Nord-est pensiamo che la DOCG Conegliano Valdobbiadene sia quella che possa trarre un maggiore vantaggio dall'uso ponderato di questo strumento. La comunicazione di questa DOCG è già ad un livello molto maturo ma soffre di tutti i problemi interni alla denominazione PROSECCO.
Per valorizzare pienamente il prodotto è necessario far vivere l’esperienza del territorio e far comprendere il lavoro dietro ad ogni bottiglia. Sarebbe infatti possibile far vivere il territorio delle colline del Prosecco ai consumatori in ogni parte del globo, spiegando differenze e pregi di ogni zona di produzione, come per esempio nel lavoro fatto da Alessandro Masneghetti in Barolo MAG 360° (www.barolomga360.it) che porta a un nuovo livello la comunicazione del territorio.
Nel mondo del vino sembra che sia già stato fatto tutto ma spesso è possibile r-innovare e sfruttare al massimo una risorsa il cui potenziale è appena accennato.
Considerazioni finali
In conclusione, il QR Code
- esigenza di differenziazione tra aziende anche di una stessa DOC -> rinforzo del brand
- modalità per avvicinare le giovani generazioni parlando il loro linguaggio digitale
- esigenza di informazione del consumatore
- stimolo per l'azienda all'investimento nel digitale e nel marketing/comunicazione
- aumento della quota di voce in un canale di comunicazione dove c'è ancora spazio
- internazionalizzazione del prodotto, facendo una comunicazione customizata a seconda del Paese di esportazione/ dell'interlocutore.
Partecipanti alla 2a Summer School sul Marketing dei vini del Nord-Est
Wine Newsletter 03/2020 - Ottobre
L'avvento del Covid-19 ha segnato un’improvvisa battuta d'arresto ad una parte del comparto vitivinicolo italiano e mondiale, quella più legata alla vendita diretta al consumatore e al settore ho.re.ca. Dopo un momento iniziale di comprensibile smarrimento, come tutti i settori anche quello del vino si è rimesso in marcia nonostante la situazione economico-sociale anomala, carica di incertezze. Attraverso approcci più o meno professionali, i protagonisti di settore – le aziende, i consorzi e gli enti - hanno iniziato un consistente lavoro di riflessione e di ripensamento della propria realtà.
Come rilevano le ricerche di Wine Intelligence, i fattori che avranno maggiore incidenza sul valore del vino nel prossimo futuro sono da rintracciarsi nel maggiore utilizzo del digitale, nella consapevolezza da parte del consumatore della sua esperienza d'acquisto, nel crescente approccio critico alla sostenibilità etica e ambientale del prodotto e del lavoro e nello spostamento del potere d’acquisto.
I mesi di lockdown, comuni a tutte le persone, sono stati quindi il momento ideale per le aziende per ripensare dalle fondamenta le proprie strategie e interrogarsi sull’ identità del brand, sulle qualità che ne determinano l'autenticità, sui modelli di business e sulle strategie di marketing e comunicazione finora adottate.
L'azienda ripensa anche il prodotto e l'organizzazione delle risorse umane.
Il lavoro di riflessione è dunque il passaggio preliminare e necessario per traghettare l'azienda dalla passività all'azione ovvero per stimolarla ad intraprendere le misure di cambiamento necessarie per adattarsi alla situazione attuale e dare risposta alle istanze provenienti dall'ambiente economico nel quale è inserita. Alcune tendenze già presenti sul mercato del vino ma considerate di secondaria importanza, nel periodo di lockdown hanno vissuto una nuova vita grazie al cambiamento delle tendenze di consumo. È il caso della crescita esponenziale delle vendite di bag in box e di vino da e-commerce: il vino acquistato crea un precedente positivo che continuerà anche dopo il lockdown.
Ne deduciamo quindi che l'investimento nel cambiamento è una tappa obbligata per l'evoluzione e, soprattutto, la sopravvivenza dell'azienda nel mercato. La contingenza del momento, però, richiede di stressare un aspetto insito nel cambiamento stesso ma da sempre di difficile messa in pratica, cioè quello dell'innovazione.
L’innovazione
Dare una definizione univoca al termine “innovazione” non è facile, tuttavia, come delineato da Reka Haros, durante la sua lezione alla Summer School 2020 del MIB, l’innovazione presenta dei caratteri distintivi:
Il processo di innovazione non è scontato e riguarda vari campi interni alle singole realtà aziendali: dall’innovazione dei processi produttivi all’innovazione tecnologica e sviluppo dell’e-commerce ma anche fattori esterni come innovazione nei rapporti tra i vari soggetti ed enti e innovazione dei mercati. Nel mondo attuale, caratterizzato da nuovi trend e da cambiamenti nelle preferenze di consumo, si osserva come tutto converga verso la sostenibilità comportando inevitabilmente la revisione delle strategie aziendali e, nel piano operativo, richiedendo flessibilità e velocità nel cambiamento delle tattiche.
Sempre più frequentemente si parla di marketing 3.0, che unisce l’aspetto digitale del web all’emozionalità delle esperienze vissute in prima persona e che mirano, nel medio termine, a fidelizzare il cliente attraverso l’identità e l’immagine del prodotto e del brand. In questo tempo di recessione e di diminuzione dei consumi, l’innovazione si concretizza nel rendere efficaci le politiche di marketing in particolare strutturando delle strategie efficaci e mirate ad aumentare la quota di voce.
La vera innovazione è pertanto tornare ai principi fondamentali racchiusi nel marketing mix composto dalle quattro leve principali: Product, Place, Price e Promotion.
Analizziamo il modo in cui il QR CODE può rappresentare uno strumento innovativo di marketing di prodotto sfruttabile commercialmente con una adeguati investimenti e campagne, consentendo di fidelizzare il cliente grazie al racconto e all'esaltazione della territorialità.
Il QR CODE è un'ottima leva che può essere sfruttata per promuovere le singole realtà aziendali , le denominazioni ma anche il territorio; attraverso la creazione di sinergie con le altri componenti del contesto territoriale si generano esternalità positive materiali, differenziazione del prodotto e del territorio nei mercati globali, e di rete attraverso le quali i produttori realizzano effetti positivi sui costi. L’obiettivo finale potrebbe essere quello di utilizzare il QR CODE non solo per attrarre nuovi clienti ma anche nuovi turisti ai quali fornire un’offerta turistica completa.
Il QR Code
Il QR code in Europa e in Italia si diffonde alla fine degli anni 2000 arrivando gradualmente anche sui prodotti alimentari e il vino. Solitamente collegati al sito aziendale o a video pubblicitari, i QR code del mondo del vino diventano elementi descrittivi statici senza sfruttare il loro pieno potenziale.
Riteniamo che, grazie alla sua posizione strategica sul packaging, il codice possa diventare un driver di scelta nell'acquisto di un determinato prodotto perchè permette al consumatore di entrare in possesso non solo di un vino ma anche di una serie di informazioni che amplificano e rendono più suggestiva l'esperienza e stimolano così ad un nuovo acquisto futuro. Sfruttarlo al massimo del suo potenziale diventa quindi essenziale per il mondo del vino.
Collegando il codice ad un fuori sito, dal carattere meno istituzionale rispetto al sito aziendale, si ha a disposizione un bacino che può essere aggiornato con alta frequenza con informazioni ad uso del consumatore, a partire dalle schede tecniche ai video delle degustazioni. La comunicazione del vino diventa più immediata e il consumatore diventa in questo modo un consumatore consapevole del prodotto che sta bevendo, vive un’esperienza da specialista e i aumentano anche le possibilità di fidelizzazione al prodotto.
L’azienda o il consorzio che decidono di investire su questo metodo di comunicazione, hanno la possibilità di veicolare l’identità e l’autenticità del proprio brand con un riscontro diretto e immediato da parte del consumatore sul prodotto. Riteniamo che una specializzazione in questa direzione agganci quindi le fasce più giovani e quelle più digitalizzate, aumentando la propria quota voce su un canale inusuale, fuori dalla competizione dei social network, con immensi benefici a lungo termine alla propria comunicazione.
Le informazioni che l’azienda può trarre dall’uso da parte della clientela di questo strumento vanno dalla geolocalizzazione alle preferenze di acquisto. Su questa base si può decidere di fornire diverse informazioni all’interno della bottiglia.
Alcuni esempi di uso "intelligente" del QR code sono quelli della cantina Donnafugata che, anche se in modo statico, racconta e mette in primo piano la sostenibilità aziendale.
Biondi Santi, invece, ha investito fortemente su questo strumento vestendo i propri prodotti con l’etichetta smart dell’azienda pisana Modulgraf, che permette di stampare un QR code differente ad ogni bottiglia direttamente in linea di etichettamento, estraendo così molti dati interessanti dall’attivazione del codice e facendo uno storytelling customizzato a seconda della fascia di prodotto acquistato.
Tra le realtà del Nord-est pensiamo che la DOCG Conegliano Valdobbiadene sia quella che possa trarre un maggiore vantaggio dall'uso ponderato di questo strumento. La comunicazione di questa DOCG è già ad un livello molto maturo ma soffre di tutti i problemi interni alla denominazione PROSECCO.
Per valorizzare pienamente il prodotto è necessario far vivere l’esperienza del territorio e far comprendere il lavoro dietro ad ogni bottiglia. Sarebbe infatti possibile far vivere il territorio delle colline del Prosecco ai consumatori in ogni parte del globo, spiegando differenze e pregi di ogni zona di produzione, come per esempio nel lavoro fatto da Alessandro Masneghetti in Barolo MAG 360° (www.barolomga360.it) che porta a un nuovo livello la comunicazione del territorio.
Nel mondo del vino sembra che sia già stato fatto tutto ma spesso è possibile r-innovare e sfruttare al massimo una risorsa il cui potenziale è appena accennato.
Considerazioni finali
In conclusione, il QR Code
- Risolve un problema: è uno strumento che da una risposta dinamica, flessibile, veloce, diretta e tempestiva ai continui cambiamenti del mercato.
- Soddisfa esigenze o ne crea di nuove:
- esigenza di differenziazione tra aziende anche di una stessa DOC -> rinforzo del brand
- modalità per avvicinare le giovani generazioni parlando il loro linguaggio digitale
- esigenza di informazione del consumatore
- Ha un impatto socio economico ambientale positivo. Se a breve termine porta ad una riduzione del cartaceo, a lungo termine:
- stimolo per l'azienda all'investimento nel digitale e nel marketing/comunicazione
- aumento della quota di voce in un canale di comunicazione dove c'è ancora spazio
- internazionalizzazione del prodotto, facendo una comunicazione customizata a seconda del Paese di esportazione/ dell'interlocutore.
Affrontare il Covid attraverso l’innovazione e la pianificazione nella supply chain: l’esperienza Marchesi Frescobaldi
Simone Fabbri
Marchesi Frescobaldi
Adjunt faculty Corso in Wine Business Management
Ci siamo stupiti di come in epoca di lock-down la tecnologia ci abbia permesso di lavorare da casa in quella che, per la prima volta, è stata la sperimentazione diffusa del vero smart-working. Generalmente, in un singolo progetto, penso vi sia poca differenza fra lavorare in smart-working o in presenza ad eccezione di quando il progetto deve effettuare degli step qualitativi. In quel caso la discussione in presenza porta, secondo me, a stimoli e risultati superiori. A pochi mesi dalla fine del primo lock-down mondiale della storia, sembra che lavorare in remoto sia, addirittura, esistito da sempre.
Ci aspettavamo che la tecnologia ad un certo momento si prendesse la scena, ma di certo non potevamo immaginare che l’avrebbe divisa con la logistica. Proprio così, dopo 20 anni che noi della supply chain eravamo considerati figli di un dio minore, improvvisamente tutti i consumatori a casa bramavano le consegne dei propri ordini in una totale rivalutazione del “fisico”. Sinceramente, lo scorso gennaio avevamo la stessa percezione dell’importanza della Value Chain ? Proprio no. Sono bastati pochi dirimenti giorni nella storia per far capire tutto a tutti.

Opero nel mondo del vino e inizialmente le esigenze aziendali mi spinsero a rivolvere i problemi di Pianificazione della produzione, perché la più grande difficoltà sembrava avere la merce pronta quando i singoli mercati, ciascuno con etichette e leggi diverse richiedeva, magari dopo anni di trattative, la spedizione immediata. Per me che provenivo da una formazione agronomica fu più facile, e di certo più familiare, risolvere problemi legati a come prevedere le possibilità produttive collimando le potenzialità dei mercati. Quello che fu presto un vero rompicapo era la programmazione della distribuzione allineata ai tempi delle richieste di mercato.
Eravamo prima del tracollo di Lehmann Brothers e parlare di Wine Supply Chain era, nel settore del vino, assai inusuale anche per chi avrebbe dovuto appoggiare le mie idee. Oggi che il progetto è riuscito nella sua completezza posso dire che fu essenziale chi in azienda mi capì e anzi mi fece da sponsor interno. Per le spedizioni all’estero bastava utilizzare quanto già esisteva, come l’uso di transit-point opportuni ai porti di spedizione. La vera sfida fu in Italia. In questo ambito ho vissuto l’esperienza più articolata proponendo una soluzione innovativa, con una filosofia che oggi diremmo da Industria 4.0.
In Inghilterra nel ‘700 con la prima rivoluzione industriale del ferro e del carbone furono create le prime fabbriche. Poi all’inizio del ‘900 la rivoluzione della chimica, nata dalla scoperta del petrolio, fino ad arrivare, alla fine del secolo, alla rivoluzione di Internet.
Adesso si parla di quarta rivoluzione industriale dove non si pensa che accadranno grandi scoperte, bensì si pensa ad un cambio soprattutto di forma mentis. Ogni settore merceologico deve rivolgere lo sguardo a quanto già fatto da altre merceologie importandolo e assemblandolo in maniera intelligente nel proprio mondo.
Da anni ero convinto che la gestione di una Wine Supply Chain innovativa potesse far crescere di competitività l’intera azienda. Il progetto che ideammo si completò nel 2015 allorché fu completato l’HUB del vino con il suo ampliamento definitivo, ma le realizzazioni rivelatesi utili erano iniziate ben prima. Fin dal 1993 eravamo partiti con la ricezione degli ordini web B2B con un portale agenti dedicato. Dopo lunghi test questo fu possibile grazie alla creazione di un pacchetto software che ebbe l’obiettivo di ridurre i tempi di gestione totali agli agenti. Finalmente facemmo “Bingo” con un portale semplice, veloce e gradevole. A dodici mesi dalla pubblicazione, il novantatre (93%) degli ordini arrivava via web!
Inoltre, nella gestione delle spedizioni vi è un elemento che non appare ma che è invece determinante per la “salute” dell’azienda. La gestione del rischio di credito. In certi frangenti assicurare le spedizioni può sbloccare gli ordini e aumentare il fatturato con rischi minimizzati. Se il rischio di credito non è coperto avere una buona logistica diventa inutile. Contemporaneamente ai test sul software B2B concordai col Direttore Vendite una politica di premi sui pagamenti delle fatture che privilegiasse quei clienti che pagavano la merce con ritmi concordati senza generare intoppi. Poco prima della crisi finanziaria del 2008, ciò che mi spinse a muovermi fu la convinzione che il futuro doveva per forza essere legato a clienti leali e moderni. Leali nel senso che quando avevano venduto tutta la merce avrebbero pagato automaticamente, e moderni nel senso che dovevano privilegiare gli strumenti informatici, sgravando l’agente del compito dell’incasso. Sorprendentemente la crisi accelerò il processo. Dal 2010 avevamo un pacchetto di clienti che ordinava con regolarità e crebbe la fiducia produttore-logistica-rivenditore.
Il terzo elemento fondamentale per arrivare all’obiettivo di una Wine Supply Chain di aiuto al business era riuscire a trovare un partner logistico per consegne espresse. Dopo due anni di test nelle consegne chiudemmo l’accordo cosicché gli ordini senza problemi di credito, raggiungevano direttamente dal portale agenti l’operatore logistico che operando anche di notte spediva regolarmente in 48 ore e con costi quasi invariati nelle 3 regioni strategiche. La nascita del primo HUB del vino in Italia a quel punto era un necessario completamento. L’affare riuscì perché si misero insieme due professioni di settori sinergici come il vino e la logistica.
Se si va a vedere delle quattro realizzazioni messe insieme, invio ordini web, nuova politica del credito, HUB veloce e relativa formazione agenti, nessuno di questi era innovativo in assoluto, ma fu una combinazione di fattori e professionisti che nel settore vino in Italia non si era mai visto. Usammo il pensiero laterale che ritengo uno dei quattro valori personali indispensabili per affrontare l’attuale economia della complessità.
Marchesi Frescobaldi
Adjunt faculty Corso in Wine Business Management
Wine Newsletter 03/2020 - Ottobre
Ci siamo stupiti di come in epoca di lock-down la tecnologia ci abbia permesso di lavorare da casa in quella che, per la prima volta, è stata la sperimentazione diffusa del vero smart-working. Generalmente, in un singolo progetto, penso vi sia poca differenza fra lavorare in smart-working o in presenza ad eccezione di quando il progetto deve effettuare degli step qualitativi. In quel caso la discussione in presenza porta, secondo me, a stimoli e risultati superiori. A pochi mesi dalla fine del primo lock-down mondiale della storia, sembra che lavorare in remoto sia, addirittura, esistito da sempre.
Ci aspettavamo che la tecnologia ad un certo momento si prendesse la scena, ma di certo non potevamo immaginare che l’avrebbe divisa con la logistica. Proprio così, dopo 20 anni che noi della supply chain eravamo considerati figli di un dio minore, improvvisamente tutti i consumatori a casa bramavano le consegne dei propri ordini in una totale rivalutazione del “fisico”. Sinceramente, lo scorso gennaio avevamo la stessa percezione dell’importanza della Value Chain ? Proprio no. Sono bastati pochi dirimenti giorni nella storia per far capire tutto a tutti.
Opero nel mondo del vino e inizialmente le esigenze aziendali mi spinsero a rivolvere i problemi di Pianificazione della produzione, perché la più grande difficoltà sembrava avere la merce pronta quando i singoli mercati, ciascuno con etichette e leggi diverse richiedeva, magari dopo anni di trattative, la spedizione immediata. Per me che provenivo da una formazione agronomica fu più facile, e di certo più familiare, risolvere problemi legati a come prevedere le possibilità produttive collimando le potenzialità dei mercati. Quello che fu presto un vero rompicapo era la programmazione della distribuzione allineata ai tempi delle richieste di mercato.
Eravamo prima del tracollo di Lehmann Brothers e parlare di Wine Supply Chain era, nel settore del vino, assai inusuale anche per chi avrebbe dovuto appoggiare le mie idee. Oggi che il progetto è riuscito nella sua completezza posso dire che fu essenziale chi in azienda mi capì e anzi mi fece da sponsor interno. Per le spedizioni all’estero bastava utilizzare quanto già esisteva, come l’uso di transit-point opportuni ai porti di spedizione. La vera sfida fu in Italia. In questo ambito ho vissuto l’esperienza più articolata proponendo una soluzione innovativa, con una filosofia che oggi diremmo da Industria 4.0.
In Inghilterra nel ‘700 con la prima rivoluzione industriale del ferro e del carbone furono create le prime fabbriche. Poi all’inizio del ‘900 la rivoluzione della chimica, nata dalla scoperta del petrolio, fino ad arrivare, alla fine del secolo, alla rivoluzione di Internet.
Adesso si parla di quarta rivoluzione industriale dove non si pensa che accadranno grandi scoperte, bensì si pensa ad un cambio soprattutto di forma mentis. Ogni settore merceologico deve rivolgere lo sguardo a quanto già fatto da altre merceologie importandolo e assemblandolo in maniera intelligente nel proprio mondo.
Da anni ero convinto che la gestione di una Wine Supply Chain innovativa potesse far crescere di competitività l’intera azienda. Il progetto che ideammo si completò nel 2015 allorché fu completato l’HUB del vino con il suo ampliamento definitivo, ma le realizzazioni rivelatesi utili erano iniziate ben prima. Fin dal 1993 eravamo partiti con la ricezione degli ordini web B2B con un portale agenti dedicato. Dopo lunghi test questo fu possibile grazie alla creazione di un pacchetto software che ebbe l’obiettivo di ridurre i tempi di gestione totali agli agenti. Finalmente facemmo “Bingo” con un portale semplice, veloce e gradevole. A dodici mesi dalla pubblicazione, il novantatre (93%) degli ordini arrivava via web!
Inoltre, nella gestione delle spedizioni vi è un elemento che non appare ma che è invece determinante per la “salute” dell’azienda. La gestione del rischio di credito. In certi frangenti assicurare le spedizioni può sbloccare gli ordini e aumentare il fatturato con rischi minimizzati. Se il rischio di credito non è coperto avere una buona logistica diventa inutile. Contemporaneamente ai test sul software B2B concordai col Direttore Vendite una politica di premi sui pagamenti delle fatture che privilegiasse quei clienti che pagavano la merce con ritmi concordati senza generare intoppi. Poco prima della crisi finanziaria del 2008, ciò che mi spinse a muovermi fu la convinzione che il futuro doveva per forza essere legato a clienti leali e moderni. Leali nel senso che quando avevano venduto tutta la merce avrebbero pagato automaticamente, e moderni nel senso che dovevano privilegiare gli strumenti informatici, sgravando l’agente del compito dell’incasso. Sorprendentemente la crisi accelerò il processo. Dal 2010 avevamo un pacchetto di clienti che ordinava con regolarità e crebbe la fiducia produttore-logistica-rivenditore.
Il terzo elemento fondamentale per arrivare all’obiettivo di una Wine Supply Chain di aiuto al business era riuscire a trovare un partner logistico per consegne espresse. Dopo due anni di test nelle consegne chiudemmo l’accordo cosicché gli ordini senza problemi di credito, raggiungevano direttamente dal portale agenti l’operatore logistico che operando anche di notte spediva regolarmente in 48 ore e con costi quasi invariati nelle 3 regioni strategiche. La nascita del primo HUB del vino in Italia a quel punto era un necessario completamento. L’affare riuscì perché si misero insieme due professioni di settori sinergici come il vino e la logistica.
Se si va a vedere delle quattro realizzazioni messe insieme, invio ordini web, nuova politica del credito, HUB veloce e relativa formazione agenti, nessuno di questi era innovativo in assoluto, ma fu una combinazione di fattori e professionisti che nel settore vino in Italia non si era mai visto. Usammo il pensiero laterale che ritengo uno dei quattro valori personali indispensabili per affrontare l’attuale economia della complessità.
Indicazioni dai cambiamenti nella classifica delle top 15 cantine italiane 2012-2019
Lorenzo Biscontin
Adjunt Faculty Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Consulente, BiscoMarketing Consulting
Si individuano prevalentemente due modelli di business, uno che potremmo chiamare “convenienza” nel senso più ampio del significato equivalente al termine inglese convenience, e l’altro basato insieme sul valore. Entrambi i modelli hanno permesso alle cantine che li adottano di crescere significativamente negli anni ed in alcuni casi di ottenere dei buoni risultati di redditività percentuale.
Significativo come entrambi i modelli mostrino una limitata importanza della marca, intesa come insieme di valori rappresentativo di uno stile in grado di veicolare un ambito più ampio rispetto a famiglia qualità e tradizione. Nessuna marca di vino italiano infatti appare nella classifica delle prime 10 a livello mondiale pubblicata lo scorso marzo da Wine Intelligence.
Vediamo più in dettaglio le caratteristiche dei due modelli.

Sarebbe però sbagliato pensare al prezzo come unico fattore competitivo, sottostimando l’importanza del servizio offerto ai clienti in termini di ampiezza assortimentale per rappresentare le principali zone vinicole italiane, flessibilità nel fornire diverse soluzioni di packaging (etichette, bottiglie, chiusure) ed affidabilità delle forniture in termini di qualità del vino e puntualità delle consegne. Sono questi i fattori che permettono alle cantine private di competere con successo con le cooperative, che presentano un vantaggio dal lato dell’approvvigionamento delle uve.
In realtà le cantine cooperative mostrano una crescita delle bottiglie vendute inferiore a quello delle bottiglie private, dovuto probabilmente anche ai limiti legislativi e “culturali” per approvvigionarsi di materia prima al di là dei conferimenti dei soci. Nel leggere i dati va comunque ricordato che il fatturato di molte cantine sociali deriva da una quota significativa di vendite di vino sfuso e quindi il dato del prezzo medio a bottiglia può risultare distorto.
Viceversa, le cantine private che adottano questo modello devono la loro crescita nel periodo tendenzialmente più all’aumento delle bottiglie vendute che a quello del prezzo medio. Altra cosa da osservare è come queste cantine concentrino fortemente le proprie vendite sui mercati esteri, principalmente verso i clienti della Grande Distribuzione Organizzata.
Da notare come la crescita dei consumi di prosecco sia stata fondamentale per la crescita dei fatturati delle cantine, sia cooperative (La Marca entra in classifica al 13° posto) che per le aziende private (Botter ed Enoitalia).

Nel caso di Santa Margherita, poi, vanno considerate le acquisizioni fatte in Sardegna e Lugana e l’apertura della propria filiale americana per la vendita nel mercato USA, che ha spostato la valorizzazione di questa importante quota di vendite dal prezzo ex-works a quello wholesale.
Chi adotta il modello “valore” mostra vendite più equilibrate tra Italia ed estero (che rimane comunque lo sbocco prevalente) ed un peso maggiore del canale horeca, rispetto alla situazione vista prima per e cantine private che applicano il modello “convenienza”.

Adjunt Faculty Area Wine Business, MIB Trieste School of Management
Consulente, BiscoMarketing Consulting
Wine Newsletter 02/2020 - Agosto
Sette anni possono essere pochi visti dal punto del vigneto, però durante gli ultimi sette anni i cambiamenti avvenuti nella classifica delle prime 15 cantine italiane secondo l’analisi del settore realizzata annualmente da Mediobanca possono fornire spunti interessanti sull’evoluzione del settore durante questo periodo.Si individuano prevalentemente due modelli di business, uno che potremmo chiamare “convenienza” nel senso più ampio del significato equivalente al termine inglese convenience, e l’altro basato insieme sul valore. Entrambi i modelli hanno permesso alle cantine che li adottano di crescere significativamente negli anni ed in alcuni casi di ottenere dei buoni risultati di redditività percentuale.
Significativo come entrambi i modelli mostrino una limitata importanza della marca, intesa come insieme di valori rappresentativo di uno stile in grado di veicolare un ambito più ampio rispetto a famiglia qualità e tradizione. Nessuna marca di vino italiano infatti appare nella classifica delle prime 10 a livello mondiale pubblicata lo scorso marzo da Wine Intelligence.
Vediamo più in dettaglio le caratteristiche dei due modelli.
Convenienza
È il modello più diffuso tra le grandi cantine italiane, al quale si possono ricondurre 10 delle prime 15. Prevale tra le cantine cooperative, praticamente tutte ad esclusione di GIV, ma è adottato anche da 4 cantine di capitale privato: F.lli Martini, Botter, Enoitalia ed Italian Wine Brands. Il tratto essenziale di questo modello sono i prezzi bassi ed i grandi volumi di vendita in modo da ottenere una buona redditività assoluta.Sarebbe però sbagliato pensare al prezzo come unico fattore competitivo, sottostimando l’importanza del servizio offerto ai clienti in termini di ampiezza assortimentale per rappresentare le principali zone vinicole italiane, flessibilità nel fornire diverse soluzioni di packaging (etichette, bottiglie, chiusure) ed affidabilità delle forniture in termini di qualità del vino e puntualità delle consegne. Sono questi i fattori che permettono alle cantine private di competere con successo con le cooperative, che presentano un vantaggio dal lato dell’approvvigionamento delle uve.
In realtà le cantine cooperative mostrano una crescita delle bottiglie vendute inferiore a quello delle bottiglie private, dovuto probabilmente anche ai limiti legislativi e “culturali” per approvvigionarsi di materia prima al di là dei conferimenti dei soci. Nel leggere i dati va comunque ricordato che il fatturato di molte cantine sociali deriva da una quota significativa di vendite di vino sfuso e quindi il dato del prezzo medio a bottiglia può risultare distorto.
Viceversa, le cantine private che adottano questo modello devono la loro crescita nel periodo tendenzialmente più all’aumento delle bottiglie vendute che a quello del prezzo medio. Altra cosa da osservare è come queste cantine concentrino fortemente le proprie vendite sui mercati esteri, principalmente verso i clienti della Grande Distribuzione Organizzata.
Da notare come la crescita dei consumi di prosecco sia stata fondamentale per la crescita dei fatturati delle cantine, sia cooperative (La Marca entra in classifica al 13° posto) che per le aziende private (Botter ed Enoitalia).
Valore
In questo modello si persegue più l’ottenimento di un prezzo medio-alto rispetto allo sviluppo dei volumi di vendita. L’emblema è sicuramente Antinori, seguito da Santa Margherita, GIV (unica cooperativa) e Zonin. Anche in questi casi però le vendite derivano più da una galassia di cantine e marche rappresentative dei diversi territori più che da una marca forte in grado di rappresentare i diversi vini (una parziale eccezione è rappresentata dai marchi Santa Margherita e Ruffino, che è diciottesima in classifica, sul mercato nord-americano).Nel caso di Santa Margherita, poi, vanno considerate le acquisizioni fatte in Sardegna e Lugana e l’apertura della propria filiale americana per la vendita nel mercato USA, che ha spostato la valorizzazione di questa importante quota di vendite dal prezzo ex-works a quello wholesale.
Chi adotta il modello “valore” mostra vendite più equilibrate tra Italia ed estero (che rimane comunque lo sbocco prevalente) ed un peso maggiore del canale horeca, rispetto alla situazione vista prima per e cantine private che applicano il modello “convenienza”.
Il 2020 si presenta come un anno pieno di incertezze per vignaioli, imprenditori e grandi gruppi
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Se il 2019 si è chiuso con la certezza, dopo oltre 3 anni di discussioni interne sulla Brexit, che la Gran Bretagna avvierà un processo di distacco dall’Unione Europea (divenendo, quindi, un Paese terzo, probabilmente anche ai fini dei fondi per la promozione dell’OCM Vino), il 2020 si apre con una spada di Damocle che sembra incombere sul settore vinicolo italiano: la proposta dell’amministrazione Trump di applicare dazi del 100% sui vini provenienti dall’Europa. Dazi che si sommerebbero a quelli del 25% già in vigore da ottobre sui vini francesi e spagnoli e che stanno portando ad un crollo drammatico nelle importazioni dalla Francia (AAWE, 2020).

Il tutto in una guerra commerciale più ampia, sorta con il ricorso contro i sussidi al Consorzio Airbus e che, sulle sponde del Pacifico, vede invece USA e Cina stringere nuovi accordi.
Contro questi dazi si sta muovendo sia la diplomazia che una buona parte del settore produttivo, a iniziare da organismi di rappresentanza quali Unione Italiana Vini e Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, poiché potrebbero portare ad un tracollo delle nostre esportazioni verso quello che è oggi il primo mercato del vino a volume e a valore. Mercato che, come certificato dalle ultime analisi di Wine Intelligence, di cui abbiamo pochi giorni fa ospitato in aula il COO, Richard Halstead, soffre già di un rallentamento dopo un ventennio di favolosa crescita, a causa di un minor consumo dei segmenti più giovani di consumatori. Rallentamento che si sta verificando anche in Cina, malgrado alcuni (che evidentemente non utilizzano fonti attendibili) ritengano possa assorbire il vino che non dovesse più salpare per l’America.
Ma le turbolenze della Brexit, i dazi USA e la stessa frenata nei consumi che interessa sia gli USA che la Cina, potrebbero sortire effetti differenti sulle diverse tipologie di produttori vinicoli, che siano industriali, commercianti, imprenditori, vignaioli, contadini o artigiani. Chi produce vino viene infatti generalmente inserito in una di queste categorie, che a loro volta hanno dato vita a sindacati, associazioni di categoria e altri organismi di rappresentanza, nonché a manifestazioni specifiche. Ogni tanto si utilizza anche la traduzione francese vigneron in senso rafforzativo del legame con la terra che le altre categorie, apparentemente, non avrebbero più.
Il vino nasce come prodotto agricolo. Quindi, chi lavora in vigna è, a tutti gli effetti, un vignaiolo che produce una materia prima, l’uva, che poi deve essere trasformata in un succo fermentato. Tuttavia esistono molte sfumature sul ruolo del vignaiolo, dovute al prodotto che si vuole ottenere, al modo e agli strumenti che si utilizzano per ottenerlo, al consumatore cui si rivolge.
Nelle lezioni sul marketing del vino nei corsi in Wine Business Management, porto sempre gli studenti a riflettere sulla contemporanea esistenza di almeno due categorie di “vino”: quello commerciale (c.d. “commodity wines”) e quello legato all’origine (“terroir wines”). Sono due tipologie che esistono da decenni e, più recentemente, hanno visto un’evoluzione sulla spinta delle diverse filosofie produttive del Vecchio e Nuovo Mondo. Due modelli di business tutt’altro che impermeabili tra loro e che, invece, stanno facendo emergere una terza tipologia di vino, dove gioca un ruolo fondamentale il marchio. Questa categoria, che non deve essere confusa o sovrapposta a quella dei branded wines commerciali per i quali l’input è una materia prima slegata dall’origine, si sta ritagliando uno spazio crescente con un forte impatto sulla struttura produttiva e sulle caratteristiche fondative di molte aziende. Aziende che, almeno nei paesi europei, sono nate e gestite da vignaioli al fine di produrre vini che possono avere nella DOC o DOCG (quindi nell’origine) la fonte del loro brand.
La globalizzazione degli ultimi 20 anni ha aperto mercati prima non raggiungibili o poco interessati al prodotto vino, rendendoli potenziali canali di vendita delle nostre etichette. Qualsiasi prodotto, dal vino commerciale che viaggia in container o flexi-tank a quello in poche centinaia di bottiglie. Se il vino commerciale si era mosso già prima (pensiamo al Lambrusco delle Cantine Riunite che spopolava negli USA tra anni ’70 e ’80 o all’Asti Spumante), la novità per l’Italia (che fino al 2002 esportava più vino sfuso rispetto a quello imbottigliato) è stato il crescente successo commerciale, sebbene non a volume, anche dei vignaioli, dei vitigni autoctoni, delle piccole DOC, che hanno potuto uscire dai confini locali o dai circoli degli enoappassionati.
E questo anche all’interno delle grandi Denominazioni quali Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, Pinot Grigio delle Venezie, Chianti, Montepulciano d’Abruzzo, Sicilia o simili, la cui visibilità ha fatto da traino anche a piccoli produttori, fornendo loro il reddito per sopravvivere, crescere e svilupparsi, a volte consentendo di investire contemporaneamentein produzioni prima trascurate, ma mantenendo la figura canonica di vignaiolo. Penso ad esempio a molte aziende friulane che hanno potuto far conoscere i loro autoctoni grazie alle decine di migliaia di bottiglie di Pinot Grigio esportate.
Sono aziende che fondono il tradizionale approccio legato all’origine e al terroir con quello moderno orientato al brand, che arbitrariamente inserisco nella classe tra 1 e 3 milioni di bottiglie e un fatturato tra 3 e 10 milioni di Euro. Aziende che hanno compreso come l’internazionalizzazione offrisse loro opportunità per raggiungere più mercati, vendendo più bottiglie e, magari, a un prezzo migliore (o almeno con un incasso garantito). Per farlo, quando non hanno potuto ingrandire la proprietà e i vigneti (scoraggiati dai prezzi crescenti in molte zone), hanno affittato terreni, stipulato contratti di acquisto dell’uva con altri piccoli vignaioli, definito accordi con cantine sociali al fine di aumentare la produzione, soddisfare la domanda (ad es. per entrare nel canale distributivo moderno) e non penalizzare i clienti. Il tutto senza perdere il controllo del processo produttivo al fine di garantire ai diversi mercati una costanza qualitativa legata alla reputazione che si è costruita.
Alla luce delle turbolenze sopra esposte, sembra che i rischi maggiori potranno essere corsi proprio da questa categoria di aziende.
Da un lato i grandi gruppi potranno spingere sull’efficienza produttiva e, controllando i costi a monte e a valle (magari aumentando l’acquisto di vino sfuso, il cui mercato è sempre pimpante). Così potranno contenere una parte delle perdite in volume sfruttando il trend verso la c.d. premiumization che sta caratterizzando questi mercati, ove i consumatori sembrano disposti a spendere qualcosa di più per vini che riescano a soddisfare non solo la sete ma soprattutto i loro bisogni di socializzazione e divertimento.
Dall’altro i piccoli vigneron, almeno quelli che hanno già nella vendita diretta (in cantina o nelle fiere specializzate) o nella sartorialità che li ha portati ad acquisire un posizionamento alto, dovrebbero risentire meno dell’effetto di dazi e tariffe. Un vino che un consumatore americano acquistava a 75$ per asporto (ossia venduto circa a 25€ franco cantina) non uscirà di mercato se sarà prezzato 90$. Ovviamente potranno diminuire i volumi, ma sarà ben diverso l’impatto.
Viceversa, per tutte queste aziende di vignaioli-imprenditori, che producono anche vini icona ma spesso concentrano la loro offerta più importante nel segmento tra i 7 e i 15€ (listino export scontato, vado per approssimazione ma non mi sbaglio di molto) al fine di posizionarsi tra 20-40$ al cliente finale, dove ancora ci sono opportunità per coniugare volume e valore, rischiano di saltare al segmento superiore, con forte contrazione delle vendite.
Attendiamo quindi gli sviluppi delle diverse trattative diplomatiche e commerciali ma, contemporaneamente, chiediamoci se non sia il caso, dal punto di vista delle aziende, di prepararsi ad analizzare, conoscere e approcciare nuovi mercati, sfruttando competenze manageriali e le giuste professionalità che anche il MIB, nella sua attività formativa, può offrire.
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2020 - Febbraio
Se il 2019 si è chiuso con la certezza, dopo oltre 3 anni di discussioni interne sulla Brexit, che la Gran Bretagna avvierà un processo di distacco dall’Unione Europea (divenendo, quindi, un Paese terzo, probabilmente anche ai fini dei fondi per la promozione dell’OCM Vino), il 2020 si apre con una spada di Damocle che sembra incombere sul settore vinicolo italiano: la proposta dell’amministrazione Trump di applicare dazi del 100% sui vini provenienti dall’Europa. Dazi che si sommerebbero a quelli del 25% già in vigore da ottobre sui vini francesi e spagnoli e che stanno portando ad un crollo drammatico nelle importazioni dalla Francia (AAWE, 2020).
Il tutto in una guerra commerciale più ampia, sorta con il ricorso contro i sussidi al Consorzio Airbus e che, sulle sponde del Pacifico, vede invece USA e Cina stringere nuovi accordi.
Contro questi dazi si sta muovendo sia la diplomazia che una buona parte del settore produttivo, a iniziare da organismi di rappresentanza quali Unione Italiana Vini e Federazione Italiana Vignaioli Indipendenti, poiché potrebbero portare ad un tracollo delle nostre esportazioni verso quello che è oggi il primo mercato del vino a volume e a valore. Mercato che, come certificato dalle ultime analisi di Wine Intelligence, di cui abbiamo pochi giorni fa ospitato in aula il COO, Richard Halstead, soffre già di un rallentamento dopo un ventennio di favolosa crescita, a causa di un minor consumo dei segmenti più giovani di consumatori. Rallentamento che si sta verificando anche in Cina, malgrado alcuni (che evidentemente non utilizzano fonti attendibili) ritengano possa assorbire il vino che non dovesse più salpare per l’America.
Ma le turbolenze della Brexit, i dazi USA e la stessa frenata nei consumi che interessa sia gli USA che la Cina, potrebbero sortire effetti differenti sulle diverse tipologie di produttori vinicoli, che siano industriali, commercianti, imprenditori, vignaioli, contadini o artigiani. Chi produce vino viene infatti generalmente inserito in una di queste categorie, che a loro volta hanno dato vita a sindacati, associazioni di categoria e altri organismi di rappresentanza, nonché a manifestazioni specifiche. Ogni tanto si utilizza anche la traduzione francese vigneron in senso rafforzativo del legame con la terra che le altre categorie, apparentemente, non avrebbero più.
Il vino nasce come prodotto agricolo. Quindi, chi lavora in vigna è, a tutti gli effetti, un vignaiolo che produce una materia prima, l’uva, che poi deve essere trasformata in un succo fermentato. Tuttavia esistono molte sfumature sul ruolo del vignaiolo, dovute al prodotto che si vuole ottenere, al modo e agli strumenti che si utilizzano per ottenerlo, al consumatore cui si rivolge.
Nelle lezioni sul marketing del vino nei corsi in Wine Business Management, porto sempre gli studenti a riflettere sulla contemporanea esistenza di almeno due categorie di “vino”: quello commerciale (c.d. “commodity wines”) e quello legato all’origine (“terroir wines”). Sono due tipologie che esistono da decenni e, più recentemente, hanno visto un’evoluzione sulla spinta delle diverse filosofie produttive del Vecchio e Nuovo Mondo. Due modelli di business tutt’altro che impermeabili tra loro e che, invece, stanno facendo emergere una terza tipologia di vino, dove gioca un ruolo fondamentale il marchio. Questa categoria, che non deve essere confusa o sovrapposta a quella dei branded wines commerciali per i quali l’input è una materia prima slegata dall’origine, si sta ritagliando uno spazio crescente con un forte impatto sulla struttura produttiva e sulle caratteristiche fondative di molte aziende. Aziende che, almeno nei paesi europei, sono nate e gestite da vignaioli al fine di produrre vini che possono avere nella DOC o DOCG (quindi nell’origine) la fonte del loro brand.
La globalizzazione degli ultimi 20 anni ha aperto mercati prima non raggiungibili o poco interessati al prodotto vino, rendendoli potenziali canali di vendita delle nostre etichette. Qualsiasi prodotto, dal vino commerciale che viaggia in container o flexi-tank a quello in poche centinaia di bottiglie. Se il vino commerciale si era mosso già prima (pensiamo al Lambrusco delle Cantine Riunite che spopolava negli USA tra anni ’70 e ’80 o all’Asti Spumante), la novità per l’Italia (che fino al 2002 esportava più vino sfuso rispetto a quello imbottigliato) è stato il crescente successo commerciale, sebbene non a volume, anche dei vignaioli, dei vitigni autoctoni, delle piccole DOC, che hanno potuto uscire dai confini locali o dai circoli degli enoappassionati.
E questo anche all’interno delle grandi Denominazioni quali Prosecco, Conegliano Valdobbiadene, Pinot Grigio delle Venezie, Chianti, Montepulciano d’Abruzzo, Sicilia o simili, la cui visibilità ha fatto da traino anche a piccoli produttori, fornendo loro il reddito per sopravvivere, crescere e svilupparsi, a volte consentendo di investire contemporaneamentein produzioni prima trascurate, ma mantenendo la figura canonica di vignaiolo. Penso ad esempio a molte aziende friulane che hanno potuto far conoscere i loro autoctoni grazie alle decine di migliaia di bottiglie di Pinot Grigio esportate.
Sono aziende che fondono il tradizionale approccio legato all’origine e al terroir con quello moderno orientato al brand, che arbitrariamente inserisco nella classe tra 1 e 3 milioni di bottiglie e un fatturato tra 3 e 10 milioni di Euro. Aziende che hanno compreso come l’internazionalizzazione offrisse loro opportunità per raggiungere più mercati, vendendo più bottiglie e, magari, a un prezzo migliore (o almeno con un incasso garantito). Per farlo, quando non hanno potuto ingrandire la proprietà e i vigneti (scoraggiati dai prezzi crescenti in molte zone), hanno affittato terreni, stipulato contratti di acquisto dell’uva con altri piccoli vignaioli, definito accordi con cantine sociali al fine di aumentare la produzione, soddisfare la domanda (ad es. per entrare nel canale distributivo moderno) e non penalizzare i clienti. Il tutto senza perdere il controllo del processo produttivo al fine di garantire ai diversi mercati una costanza qualitativa legata alla reputazione che si è costruita.
Alla luce delle turbolenze sopra esposte, sembra che i rischi maggiori potranno essere corsi proprio da questa categoria di aziende.
Da un lato i grandi gruppi potranno spingere sull’efficienza produttiva e, controllando i costi a monte e a valle (magari aumentando l’acquisto di vino sfuso, il cui mercato è sempre pimpante). Così potranno contenere una parte delle perdite in volume sfruttando il trend verso la c.d. premiumization che sta caratterizzando questi mercati, ove i consumatori sembrano disposti a spendere qualcosa di più per vini che riescano a soddisfare non solo la sete ma soprattutto i loro bisogni di socializzazione e divertimento.
Dall’altro i piccoli vigneron, almeno quelli che hanno già nella vendita diretta (in cantina o nelle fiere specializzate) o nella sartorialità che li ha portati ad acquisire un posizionamento alto, dovrebbero risentire meno dell’effetto di dazi e tariffe. Un vino che un consumatore americano acquistava a 75$ per asporto (ossia venduto circa a 25€ franco cantina) non uscirà di mercato se sarà prezzato 90$. Ovviamente potranno diminuire i volumi, ma sarà ben diverso l’impatto.
Viceversa, per tutte queste aziende di vignaioli-imprenditori, che producono anche vini icona ma spesso concentrano la loro offerta più importante nel segmento tra i 7 e i 15€ (listino export scontato, vado per approssimazione ma non mi sbaglio di molto) al fine di posizionarsi tra 20-40$ al cliente finale, dove ancora ci sono opportunità per coniugare volume e valore, rischiano di saltare al segmento superiore, con forte contrazione delle vendite.
Attendiamo quindi gli sviluppi delle diverse trattative diplomatiche e commerciali ma, contemporaneamente, chiediamoci se non sia il caso, dal punto di vista delle aziende, di prepararsi ad analizzare, conoscere e approcciare nuovi mercati, sfruttando competenze manageriali e le giuste professionalità che anche il MIB, nella sua attività formativa, può offrire.
Chi influenza i risultati della ricerca online nel settore del vino?
Patrizia De Luca
Docente di Marketing
Wine Business Management
Se Nella logica dell’inbound marketing (Halligan e Shah 2014), il principale obiettivo della comunicazione aziendale dovrebbe essere quello di conquistare l'interesse dei potenziali clienti per attirarli verso il sito aziendale. Tuttavia, competere sul web per apparire in cima ai risultati di ricerca può rivelarsi piuttosto difficile, anche considerando che, a seconda del settore e del paese, diversi attori e tipologie di siti web possono diversamente influenzare l'ambiente competitivo online (Peterson & Merino 2003; Huang, Lurie & Mitra 2009; Lemon & Verhoef 2016). Attraverso una specifica ricerca sul web alcuni autori[1] si sono posti l’obiettivo, attraverso i risultati della ricerca organica, di mappare e descrivere la presenza di differenti attori nel mercato del vino: quali sono le categorie di attori che definiscono l'arena competitiva online per diversi vini in diversi paesi? Il lavoro è caratterizzato da una duplice prospettiva: da un lato il search engine marketing e dall’altro la cross-country analysis. Per quanto riguarda il metodo, è stato fatto ricorso alla ricerca internet-based e all’abductive approach, che per la sua impostazione pragmatica, risulta adatto per l’analisi dei big data e per comprendere, in una logica grounded theory, i nuovi fenomeni di mercato. I motivi di questo interesse possono essere sintetizzati nei seguenti punti: i motori di ricerca (ad esempio Google e Yahoo) sono diventati il principale strumento utilizzato per cercare informazioni su internet (Berman&Katona,2013; Luhetal.,2016; Bahandari&Bansal,2018); gli utenti rendono esplicita la ricerca attraverso l’uso di parole chiave; la maggior parte degli utenti cliccano sui siti elencati nella prima pagina del motore di ricerca e la quota di coloro che vanno oltre la terza pagina di risultati decresce rapidamente (Lorigo,etal.,2006;Chuklin,Serdyukov,&DeRijke,2013); raggiungere un elevato livello nei risultati di ricerca con l’uso di parole chiave è fondamentale per attrarre traffico su un sito ed è il principale obiettivo del search engine marketing (SEM), attraverso la search engine optimization (SEO) (Gandour&Regolini, 2011; Moreno&Martinez, 2013; Berman&Katona, 2013; Luh et al., 2016).
Per la ricerca sono state selezionate sei tipologie di vino, caratterizzate dal fatto di essere sia vino, sia terroir, e di essere particolarmente significative per i paesi europei. Si è quindi focalizzata l’attenzione su Champagne e Bordeaux (Francia), Prosecco e Chianti (Italia), Cava e Rioja (Spagna). Ai fini della ricerca organica, è stato considerato solo il "tipo di vino" come parola chiave di ricerca, in diversi mercati di consumo, particolarmente rilevanti a livello mondiale (OIV 2018): Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia. Con l’ausilio di un particolare software (Ubersuggest), sono stati analizzati i risultati della SERP di Google in ogni paese. Infine, sono state create categorie significative di siti web per mappare il ruolo dei diversi attori online nei risultati della SERP.
I risultati preliminari evidenziano interessanti differenze nel ruolo dei diversi attori web per i diversi vini nei vari paesi: in US prevalgono siti diversi dall’e-commerce, in particolare quelli informativi (magazines e blogs) e specializzati; in Italia e Francia si ha una rilevante presenza di siti e-commerce e una limitata presenza di siti informativi; per Chianti e Bordeaux si hanno prevalentemente siti diversi dall’e-commerce, di natura turistica soprattutto per il Chianti e informativa per il Bordeaux; per Champagne e Prosecco emerge il rilevante ruolo dei siti e-commerce e informativi, con una buona posizione in termini di presenza nei diversi paesi. In termini di implicazioni gestionali, il rilevante ruolo dei siti informativi, soprattutto sul mercato statunitense, inducono a rivedere la comunicazione e i contenuti sui siti online per molti vini europei. La limitata presenza di magazine e blog specializzati in Italia e Francia porta a pensare che ci sia spazio per operatori disposti a investire professionalmente nell’area del content marketing.
[1] de Luca P., Ampò A., Orciuolo P., Venier F. (2019). “Who is shaping search engine results in the wine industry? A cross-country analysis”, Abstract in Management International Conference-MIC 2019 Managing Geostrategic Issue. ISSN 1854-4312.
Docente di Marketing
Wine Business Management
Wine Newsletter 01/2020 - Febbraio
Se Nella logica dell’inbound marketing (Halligan e Shah 2014), il principale obiettivo della comunicazione aziendale dovrebbe essere quello di conquistare l'interesse dei potenziali clienti per attirarli verso il sito aziendale. Tuttavia, competere sul web per apparire in cima ai risultati di ricerca può rivelarsi piuttosto difficile, anche considerando che, a seconda del settore e del paese, diversi attori e tipologie di siti web possono diversamente influenzare l'ambiente competitivo online (Peterson & Merino 2003; Huang, Lurie & Mitra 2009; Lemon & Verhoef 2016). Attraverso una specifica ricerca sul web alcuni autori[1] si sono posti l’obiettivo, attraverso i risultati della ricerca organica, di mappare e descrivere la presenza di differenti attori nel mercato del vino: quali sono le categorie di attori che definiscono l'arena competitiva online per diversi vini in diversi paesi? Il lavoro è caratterizzato da una duplice prospettiva: da un lato il search engine marketing e dall’altro la cross-country analysis. Per quanto riguarda il metodo, è stato fatto ricorso alla ricerca internet-based e all’abductive approach, che per la sua impostazione pragmatica, risulta adatto per l’analisi dei big data e per comprendere, in una logica grounded theory, i nuovi fenomeni di mercato. I motivi di questo interesse possono essere sintetizzati nei seguenti punti: i motori di ricerca (ad esempio Google e Yahoo) sono diventati il principale strumento utilizzato per cercare informazioni su internet (Berman&Katona,2013; Luhetal.,2016; Bahandari&Bansal,2018); gli utenti rendono esplicita la ricerca attraverso l’uso di parole chiave; la maggior parte degli utenti cliccano sui siti elencati nella prima pagina del motore di ricerca e la quota di coloro che vanno oltre la terza pagina di risultati decresce rapidamente (Lorigo,etal.,2006;Chuklin,Serdyukov,&DeRijke,2013); raggiungere un elevato livello nei risultati di ricerca con l’uso di parole chiave è fondamentale per attrarre traffico su un sito ed è il principale obiettivo del search engine marketing (SEM), attraverso la search engine optimization (SEO) (Gandour&Regolini, 2011; Moreno&Martinez, 2013; Berman&Katona, 2013; Luh et al., 2016).
Per la ricerca sono state selezionate sei tipologie di vino, caratterizzate dal fatto di essere sia vino, sia terroir, e di essere particolarmente significative per i paesi europei. Si è quindi focalizzata l’attenzione su Champagne e Bordeaux (Francia), Prosecco e Chianti (Italia), Cava e Rioja (Spagna). Ai fini della ricerca organica, è stato considerato solo il "tipo di vino" come parola chiave di ricerca, in diversi mercati di consumo, particolarmente rilevanti a livello mondiale (OIV 2018): Italia, Spagna, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Australia. Con l’ausilio di un particolare software (Ubersuggest), sono stati analizzati i risultati della SERP di Google in ogni paese. Infine, sono state create categorie significative di siti web per mappare il ruolo dei diversi attori online nei risultati della SERP.
I risultati preliminari evidenziano interessanti differenze nel ruolo dei diversi attori web per i diversi vini nei vari paesi: in US prevalgono siti diversi dall’e-commerce, in particolare quelli informativi (magazines e blogs) e specializzati; in Italia e Francia si ha una rilevante presenza di siti e-commerce e una limitata presenza di siti informativi; per Chianti e Bordeaux si hanno prevalentemente siti diversi dall’e-commerce, di natura turistica soprattutto per il Chianti e informativa per il Bordeaux; per Champagne e Prosecco emerge il rilevante ruolo dei siti e-commerce e informativi, con una buona posizione in termini di presenza nei diversi paesi. In termini di implicazioni gestionali, il rilevante ruolo dei siti informativi, soprattutto sul mercato statunitense, inducono a rivedere la comunicazione e i contenuti sui siti online per molti vini europei. La limitata presenza di magazine e blog specializzati in Italia e Francia porta a pensare che ci sia spazio per operatori disposti a investire professionalmente nell’area del content marketing.
[1] de Luca P., Ampò A., Orciuolo P., Venier F. (2019). “Who is shaping search engine results in the wine industry? A cross-country analysis”, Abstract in Management International Conference-MIC 2019 Managing Geostrategic Issue. ISSN 1854-4312.
Innovazione, digitalizzazione e nuove generazioni: quale sarà il futuro del settore vinicolo?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Cosa vuol dire innovazione nel settore vinicolo?
Sia in aula che in alcuni articoli, ho avuto più volte opportunità di affermare che il trend del vino in lattina non è solo una questione di nicchia negli USA.
Mentre in Italia a molti sembrano ancora esotici i tappi alternativi (a vite), il bag-in-box o le bottiglie da 0.187 (per non parlare di quanta ironia si faccia ancora sul Tavernello), intere fasce di consumatori (a iniziare dai giovani) nei mercati dove il vino italiano vuole essere maggiormente presente sono già andati ben oltre tali “stravaganze”, acquistando ad esempio vini da 10-15$ al litro in contenitori alternativi alla classica bottiglia da 0,75.
Recentemente Union Wine Company, produttore dell’Oregon con il marchio Underwood (che ebbi modo di assaggiare già lo scorso anno durante la fiera ProWein) ha iniziato a sponsorizzare le squadre di calcio di Portland, producendo lattine di vino con i colori sociali, allo scopo di sostituire almeno in parte la birra tra i tifosi. Un altro esempio di prodotto -> target -> occasione di consumo. Allo stesso modo, la scorsa estate in California si è tenuto il primo concorso per vini in lattina, International Canned Wine Competition, cui hanno partecipato 50 aziende con 200 vini (anche dall’Italia).
Se il vino in lattina non sarà un sostituto dei segmenti alti dell’offerta, molti produttori “mee-too” di fascia intermedia dovrebbero chiedersi se questo formato di packaging può essere una soluzione per raggiungere quelle fasce di consumatori oggi non interessate.
Ricordiamoci che il vino in lattina si aggiunge al mercato esistente e non cannibalizza le vendite di vino in bottiglia, grazie ad una serie di driver di mercato ben specifici:
I consumatori infatti non sono immobili, i loro gusti cambiano (ce ne parla Richard Halstead nel suo articolo sui Millennial inglesi), così come sono diversi gli strumenti utilizzati per acquisire informazioni sui vini. Se in passato la parte preponderante era affidata alle riviste cartacee, alle guide, ai tradizionali eventi di settore e ai corsi di degustazione, oggi i consumatori richiedono alle aziende un salto di qualità nella comunicazione e nell’utilizzo degli strumenti per raggiungerli. È quindi interessante conoscere i risultati proposti da chi si occupa di ricerca accademica, ad esempio sulle parole chiave utilizzate per ricercare il vino italiano sui mercati, come nell’articolo scientifico firmato da Patrizia De Luca ed altri colleghi che collaborano anche con MIB.
Per avere un ruolo nel futuro del settore vinicolo, quindi, le aziende devono saper gestire con competenza nuovi processi di innovazione (nel packaging, nella comunicazione, nel branding, nei prodotti stessi), comprendendo come sfruttare le possibilità offerte digitalizzazione al fine di raggiungere con maggior efficacia le nuove generazioni.
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 03/2019 - Novembre
Cosa vuol dire innovazione nel settore vinicolo?
Sia in aula che in alcuni articoli, ho avuto più volte opportunità di affermare che il trend del vino in lattina non è solo una questione di nicchia negli USA.
Mentre in Italia a molti sembrano ancora esotici i tappi alternativi (a vite), il bag-in-box o le bottiglie da 0.187 (per non parlare di quanta ironia si faccia ancora sul Tavernello), intere fasce di consumatori (a iniziare dai giovani) nei mercati dove il vino italiano vuole essere maggiormente presente sono già andati ben oltre tali “stravaganze”, acquistando ad esempio vini da 10-15$ al litro in contenitori alternativi alla classica bottiglia da 0,75.
Recentemente Union Wine Company, produttore dell’Oregon con il marchio Underwood (che ebbi modo di assaggiare già lo scorso anno durante la fiera ProWein) ha iniziato a sponsorizzare le squadre di calcio di Portland, producendo lattine di vino con i colori sociali, allo scopo di sostituire almeno in parte la birra tra i tifosi. Un altro esempio di prodotto -> target -> occasione di consumo. Allo stesso modo, la scorsa estate in California si è tenuto il primo concorso per vini in lattina, International Canned Wine Competition, cui hanno partecipato 50 aziende con 200 vini (anche dall’Italia).
Se il vino in lattina non sarà un sostituto dei segmenti alti dell’offerta, molti produttori “mee-too” di fascia intermedia dovrebbero chiedersi se questo formato di packaging può essere una soluzione per raggiungere quelle fasce di consumatori oggi non interessate.
Ricordiamoci che il vino in lattina si aggiunge al mercato esistente e non cannibalizza le vendite di vino in bottiglia, grazie ad una serie di driver di mercato ben specifici:
- Praticità
- Capacità di estendere le occasioni di consumo (vedi assistere alla partita)
- Sostenibilità / Risparmio sui costi
- Aspetto visivo / Branding (grazie alle possibilità di design e personalizzazione).
I consumatori infatti non sono immobili, i loro gusti cambiano (ce ne parla Richard Halstead nel suo articolo sui Millennial inglesi), così come sono diversi gli strumenti utilizzati per acquisire informazioni sui vini. Se in passato la parte preponderante era affidata alle riviste cartacee, alle guide, ai tradizionali eventi di settore e ai corsi di degustazione, oggi i consumatori richiedono alle aziende un salto di qualità nella comunicazione e nell’utilizzo degli strumenti per raggiungerli. È quindi interessante conoscere i risultati proposti da chi si occupa di ricerca accademica, ad esempio sulle parole chiave utilizzate per ricercare il vino italiano sui mercati, come nell’articolo scientifico firmato da Patrizia De Luca ed altri colleghi che collaborano anche con MIB.
Per avere un ruolo nel futuro del settore vinicolo, quindi, le aziende devono saper gestire con competenza nuovi processi di innovazione (nel packaging, nella comunicazione, nel branding, nei prodotti stessi), comprendendo come sfruttare le possibilità offerte digitalizzazione al fine di raggiungere con maggior efficacia le nuove generazioni.
Uno studio sulle parole chiave di Google per il vino italiano nel mercato USA
Patrizia De Luca
Docente di Marketing
Wine Business Management
Uno studio sull’analisi delle parole chiave di Google per il vino italiano nel mercato statunitense ha focalizzato l’attenzione sulla ricerca del consumatore nel nuovo contesto online [de Luca P., Pegan G., Gonzalo-Penela C. (2019). Insights from a Google Keywords Analysis about Italian Wine in the US Market. Micro&Macro Marketing, N. 1, pp. 95-118.].
La connettività viene considerata la più grande rivoluzione nella storia del marketing (Kotler et al., 2017). Basti pensare che nel 2017 gli utenti di internet rappresentavano oltre il 50% (4,021 miliardi) della popolazione mondiale, con tassi di penetrazione diversi in relazione ai vari media disponibili (internet, mobile e social media) e ai diversi paesi. La Cina è al primo posto (751 milioni di utenti, 19%), seguita dall'Europa (674 milioni di utenti, 17%) e dagli Stati Uniti (287 milioni di utenti, 7%). L'Italia, con i suoi 43 milioni di utenti, rappresenta appena l'1% del totale mondiale (WeAreSocial & Hootsuite, 2018). Questi paesi occupano le stesse posizioni relative anche per quanto riguarda il numero di utenti di social media e mobile device (WeAreSocial & Hootsuite, 2018). Gli sviluppi tecnologici nel campo della connettività hanno portato anche al rapido sviluppo dei canali online per l'acquisto dei prodotti. Tali canali hanno creato una nuova e complessa customer experience in cui il cliente può interagire con un sistema integrato, attraverso una logica omnicanale, per cercare informazioni, trovare soluzioni, conversare, acquistare e commentare (Brynjolfsson et al., 2013; Gao & Su, 2017; UPS, 2016).
In questo quadro, anche nella recente prospettiva dell’inbound marketing (Halligan & Shah, 2009), l'obiettivo aziendale dovrebbe essere principalmente quello di conquistare l'interesse dei potenziali clienti attraverso il sito web, anche con il supporto dei motori di ricerca e i social media, ormai diventati fondamentali per veicolare l'attenzione e l’interesse dei potenziali clienti. Diversi aspetti del comportamento dei consumatori online sono tuttavia ancora poco chiari e richiedono approfondimenti in diversi settori e mercati (Huang et al., 2009; Lemon & Verhoef, 2016; Peterson & Merino, 2003). Tra questi, il settore vitivinicolo italiano presenta potenzialità ancora inespresse a livello internazionale. Nell'industria vitivinicola internazionale, infatti, si può ancora notare la contrapposizione tra la tradizionale presenza dei produttori del vecchio mondo e l’innovativa crescita dei nuovi paesi produttori (Maizza et al., 2017; Orth et al., 2007).
La comprensione dei comportamenti online sta dunque diventando un fattore critico di successo nella competizione internazionale, soprattutto per attori tradizionali come Italia, Francia e Spagna, storicamente legati alla produzione vinicola, ma con un approccio al mercato ancora non pienamente in linea con gli sviluppi delle nuove tecnologie (Cavallo et al., 2016; Dolan et al., 2017; Fernandez et al., 2017; Gebauer & Ginsburg, 2010; Paiano et al., 2013; Scorrano et al., 2015; Szolnoki et al., 2014).
Nonostante il posizionamento internazionale e la significativa crescita delle esportazioni (ISMEA, 2018), molte aziende del settore, così come la maggior parte delle PMI dell'industria agroalimentare italiana, non sono adeguatamente strutturate. Inoltre, nonostante siano state intraprese molte iniziative online in questo settore, alcuni studi hanno dimostrato che le strategie utilizzate da queste aziende sono orientate principalmente alla comunicazione piuttosto che allo shopping online (Carlucci et al., 2014; Fritz et al., 2009). Attualmente il 50% delle aziende italiane vende i propri vini online, direttamente o attraverso siti specializzati, e un altro 17% intende utilizzare questo canale nei prossimi anni. Tuttavia, nel mercato italiano l'acquisto di vino attraverso i canali di e-commerce è limitato, con solo il 2% degli acquisti di vino effettuati online. Il risultato è basso anche in confronto ad altri paesi, come Francia e Regno Unito, dove l’acquisto on line di vino è superiore al 10%, e Cina, con un dato superiore al 20% (Food, 2018). Una recente ricerca (3RDPLACE, 2017) ha evidenziato che il vino italiano è molto competitivo all'estero e sebbene il grado di conoscenza sia medio-basso, la percezione del vino italiano è positiva. Oltre un milione di contenuti digitali in inglese parlano di vino, ma solo 66.875 (7%) parlano di vino made in Italy, seppure con un incoraggiante 68% di contenuti positivi. Anche negli Stati Uniti il vino italiano è ben noto, ma sulle principali piattaforme di e-commerce del paese copre solo l'1% dell'offerta totale.
Di fronte a questi dati si è ritenuto utile studiare più approfonditamente il problema. Oggi, in internet, si cerca soprattutto attraverso i motori di ricerca, che diventano il principale strumento con cui si interroga la rete (Nielsen & Loranger, 2006) e le principali fonti di traffico per i siti web (Jerath et al., 2014; Netmarketshare, 2016). In questo contesto, il "tagging" – l’attribuzione di etichette, cioè parole chiave, per identificare i contenuti - diventa una funzione fondamentale. Il successo di un'azienda dipende infatti in larga misura dalla ricerca online, attraverso specifiche parole chiave, e dai risultati di questa ricerca (Chen et al., 2009). Mentre le aziende nate digitali sono già preparate, le aziende tradizionali, come le piccole imprese vinicole italiane devono imparare come ottenere un vantaggio competitivo da questi big data (McAfee & Brynjolfsson, 2012; Lemon & Verhoef, 2016).
Sulla base di queste considerazioni, il presente lavoro ha cercato di rispondere alle seguenti domande: cosa possono dirci i dati di ricerca online generati dagli utenti sul mercato vinicolo statunitense? Come possiamo interpretare le parole chiave di Google per capire le intenzioni dell'utente nel mercato del vino statunitense? Cosa può dirci Internet sulla visibilità dei vini italiani nel mercato statunitense?
Alla base dello studio c’è la classificazione dell’intento di ricerca da parte dell’utente online (Tabella 1)
Fonte: tradotto e adattato da Rose & Levinsson (2004) and Jansen et al. (2008)
L’attenzione è stata focalizzata sulla ricerca online di vini italiani e di altri vini europei, come i vini francesi e spagnoli, nel mercato statunitense. In particolare, nelle parole chiave di ricerca vinicola estratte nel 2016, i vini più cercati sono risultati essere il Prosecco e il Moscato, tra i vini italiani, lo Champagne tra quelli francesi, e il Cava tra i vini spagnoli. Successivamente l’analisi, condotta in tre fasi, ha permesso di evidenziare la diversità del nuovo viaggio del cliente nel contesto online per ogni variante di vino considerata, e i diversi ruoli degli elementi di differenziazione nel settore vitivinicolo.
Codificando e categorizzando le parole chiave, si è rilevato, ad esempio, che nel caso del Prosecco, le parole chiave relative al "marchio" sono più frequentemente ricercate rispetto a quelle connesse al "paese di origine", e che il "prezzo" è un termine di ricerca particolarmente rilevante. Per il Moscato, sembra essere ancora più rilevante lo specifico "luogo d'origine". Nel caso dello Champagne, il vino più ricercato nel mercato statunitense, gli utenti tendono a essere più interessati a marchi specifici. Per il Cava, le parole chiave più frequentemente ricercate riguardano le "varianti di vino" e il "paese di origine". Questi risultati potrebbero suggerire che “prezzo” e “origine” sono gli aspetti importanti per il vino italiano. Diversi appaiono i risultati per lo Champagne: in questo caso le parole chiave sembrano riferirsi principalmente al “marchio” e al “regalo”. In questo caso il prezzo non è rilevante: del resto lo Champagne è considerato un prodotto premium o di lusso, e non sembra essere importante affinare la ricerca con altri termini aggiuntivi. Per il Cava gli utenti sembrano cercare prevalentemente dettagli informativi sulle “varianti di vino” e sul “paese di origine”, senza marchi specifici.
Nel complesso, con riferimento agli intenti dell’utente, è emerso un prevalente scopo informativo (parole chiave nelle categorie "varianti di vino", "paese di origine", "luogo di origine" e “marchio") e transazionale (parole chiave nelle categorie "luogo di acquisto", "prezzo e servizio di consegna" e "regalo e servizio connesso"). Non è stata identificata alcuna parola chiave relativa all'intento di navigazione. Questo potrebbe significare che gli utenti del web e i consumatori di vino non cercano spesso un sito specifico, che spesso non conoscono, ma cercano soprattutto di ottenere informazioni per l'acquisto.
Infine, la debole posizione del vino italiano nel mercato statunitense emerge dalla terza fase della ricerca, che evidenzia la scarsa visibilità dei siti di vini italiani, collocati in posizione intermedia tra quelli di vini francesi e spagnoli (Figura 1).

Figura 1 – Paesi in cui i siti web sono ospitati e visualizzati nelle SERP di Google negli Stati Uniti per le ricerche di vini italiani, francesi e spagnoli negli Stati Uniti.
Docente di Marketing
Wine Business Management
Wine Newsletter 03/2019 - Novembre
Uno studio sull’analisi delle parole chiave di Google per il vino italiano nel mercato statunitense ha focalizzato l’attenzione sulla ricerca del consumatore nel nuovo contesto online [de Luca P., Pegan G., Gonzalo-Penela C. (2019). Insights from a Google Keywords Analysis about Italian Wine in the US Market. Micro&Macro Marketing, N. 1, pp. 95-118.].
La connettività viene considerata la più grande rivoluzione nella storia del marketing (Kotler et al., 2017). Basti pensare che nel 2017 gli utenti di internet rappresentavano oltre il 50% (4,021 miliardi) della popolazione mondiale, con tassi di penetrazione diversi in relazione ai vari media disponibili (internet, mobile e social media) e ai diversi paesi. La Cina è al primo posto (751 milioni di utenti, 19%), seguita dall'Europa (674 milioni di utenti, 17%) e dagli Stati Uniti (287 milioni di utenti, 7%). L'Italia, con i suoi 43 milioni di utenti, rappresenta appena l'1% del totale mondiale (WeAreSocial & Hootsuite, 2018). Questi paesi occupano le stesse posizioni relative anche per quanto riguarda il numero di utenti di social media e mobile device (WeAreSocial & Hootsuite, 2018). Gli sviluppi tecnologici nel campo della connettività hanno portato anche al rapido sviluppo dei canali online per l'acquisto dei prodotti. Tali canali hanno creato una nuova e complessa customer experience in cui il cliente può interagire con un sistema integrato, attraverso una logica omnicanale, per cercare informazioni, trovare soluzioni, conversare, acquistare e commentare (Brynjolfsson et al., 2013; Gao & Su, 2017; UPS, 2016).
In questo quadro, anche nella recente prospettiva dell’inbound marketing (Halligan & Shah, 2009), l'obiettivo aziendale dovrebbe essere principalmente quello di conquistare l'interesse dei potenziali clienti attraverso il sito web, anche con il supporto dei motori di ricerca e i social media, ormai diventati fondamentali per veicolare l'attenzione e l’interesse dei potenziali clienti. Diversi aspetti del comportamento dei consumatori online sono tuttavia ancora poco chiari e richiedono approfondimenti in diversi settori e mercati (Huang et al., 2009; Lemon & Verhoef, 2016; Peterson & Merino, 2003). Tra questi, il settore vitivinicolo italiano presenta potenzialità ancora inespresse a livello internazionale. Nell'industria vitivinicola internazionale, infatti, si può ancora notare la contrapposizione tra la tradizionale presenza dei produttori del vecchio mondo e l’innovativa crescita dei nuovi paesi produttori (Maizza et al., 2017; Orth et al., 2007).
La comprensione dei comportamenti online sta dunque diventando un fattore critico di successo nella competizione internazionale, soprattutto per attori tradizionali come Italia, Francia e Spagna, storicamente legati alla produzione vinicola, ma con un approccio al mercato ancora non pienamente in linea con gli sviluppi delle nuove tecnologie (Cavallo et al., 2016; Dolan et al., 2017; Fernandez et al., 2017; Gebauer & Ginsburg, 2010; Paiano et al., 2013; Scorrano et al., 2015; Szolnoki et al., 2014).
Nonostante il posizionamento internazionale e la significativa crescita delle esportazioni (ISMEA, 2018), molte aziende del settore, così come la maggior parte delle PMI dell'industria agroalimentare italiana, non sono adeguatamente strutturate. Inoltre, nonostante siano state intraprese molte iniziative online in questo settore, alcuni studi hanno dimostrato che le strategie utilizzate da queste aziende sono orientate principalmente alla comunicazione piuttosto che allo shopping online (Carlucci et al., 2014; Fritz et al., 2009). Attualmente il 50% delle aziende italiane vende i propri vini online, direttamente o attraverso siti specializzati, e un altro 17% intende utilizzare questo canale nei prossimi anni. Tuttavia, nel mercato italiano l'acquisto di vino attraverso i canali di e-commerce è limitato, con solo il 2% degli acquisti di vino effettuati online. Il risultato è basso anche in confronto ad altri paesi, come Francia e Regno Unito, dove l’acquisto on line di vino è superiore al 10%, e Cina, con un dato superiore al 20% (Food, 2018). Una recente ricerca (3RDPLACE, 2017) ha evidenziato che il vino italiano è molto competitivo all'estero e sebbene il grado di conoscenza sia medio-basso, la percezione del vino italiano è positiva. Oltre un milione di contenuti digitali in inglese parlano di vino, ma solo 66.875 (7%) parlano di vino made in Italy, seppure con un incoraggiante 68% di contenuti positivi. Anche negli Stati Uniti il vino italiano è ben noto, ma sulle principali piattaforme di e-commerce del paese copre solo l'1% dell'offerta totale.
Di fronte a questi dati si è ritenuto utile studiare più approfonditamente il problema. Oggi, in internet, si cerca soprattutto attraverso i motori di ricerca, che diventano il principale strumento con cui si interroga la rete (Nielsen & Loranger, 2006) e le principali fonti di traffico per i siti web (Jerath et al., 2014; Netmarketshare, 2016). In questo contesto, il "tagging" – l’attribuzione di etichette, cioè parole chiave, per identificare i contenuti - diventa una funzione fondamentale. Il successo di un'azienda dipende infatti in larga misura dalla ricerca online, attraverso specifiche parole chiave, e dai risultati di questa ricerca (Chen et al., 2009). Mentre le aziende nate digitali sono già preparate, le aziende tradizionali, come le piccole imprese vinicole italiane devono imparare come ottenere un vantaggio competitivo da questi big data (McAfee & Brynjolfsson, 2012; Lemon & Verhoef, 2016).
Sulla base di queste considerazioni, il presente lavoro ha cercato di rispondere alle seguenti domande: cosa possono dirci i dati di ricerca online generati dagli utenti sul mercato vinicolo statunitense? Come possiamo interpretare le parole chiave di Google per capire le intenzioni dell'utente nel mercato del vino statunitense? Cosa può dirci Internet sulla visibilità dei vini italiani nel mercato statunitense?
Alla base dello studio c’è la classificazione dell’intento di ricerca da parte dell’utente online (Tabella 1)
| Intento di ricerca | Breve descrizione dello scopo dell’utente | Esempi |
| Informativo | Imparare qualcosa leggendo o guardando le pagine web | Dati, testi, documenti, multimedia |
| Navigazionale | Andare in uno specifico noto sito web | Pagine web, siti |
| Transazionale | Ottenere determinati prodotti o servizi | Acquisto di un prodotto, esecuzione di un’applicazione online, scaricare un contenuto multimediale |
L’attenzione è stata focalizzata sulla ricerca online di vini italiani e di altri vini europei, come i vini francesi e spagnoli, nel mercato statunitense. In particolare, nelle parole chiave di ricerca vinicola estratte nel 2016, i vini più cercati sono risultati essere il Prosecco e il Moscato, tra i vini italiani, lo Champagne tra quelli francesi, e il Cava tra i vini spagnoli. Successivamente l’analisi, condotta in tre fasi, ha permesso di evidenziare la diversità del nuovo viaggio del cliente nel contesto online per ogni variante di vino considerata, e i diversi ruoli degli elementi di differenziazione nel settore vitivinicolo.
Codificando e categorizzando le parole chiave, si è rilevato, ad esempio, che nel caso del Prosecco, le parole chiave relative al "marchio" sono più frequentemente ricercate rispetto a quelle connesse al "paese di origine", e che il "prezzo" è un termine di ricerca particolarmente rilevante. Per il Moscato, sembra essere ancora più rilevante lo specifico "luogo d'origine". Nel caso dello Champagne, il vino più ricercato nel mercato statunitense, gli utenti tendono a essere più interessati a marchi specifici. Per il Cava, le parole chiave più frequentemente ricercate riguardano le "varianti di vino" e il "paese di origine". Questi risultati potrebbero suggerire che “prezzo” e “origine” sono gli aspetti importanti per il vino italiano. Diversi appaiono i risultati per lo Champagne: in questo caso le parole chiave sembrano riferirsi principalmente al “marchio” e al “regalo”. In questo caso il prezzo non è rilevante: del resto lo Champagne è considerato un prodotto premium o di lusso, e non sembra essere importante affinare la ricerca con altri termini aggiuntivi. Per il Cava gli utenti sembrano cercare prevalentemente dettagli informativi sulle “varianti di vino” e sul “paese di origine”, senza marchi specifici.
Nel complesso, con riferimento agli intenti dell’utente, è emerso un prevalente scopo informativo (parole chiave nelle categorie "varianti di vino", "paese di origine", "luogo di origine" e “marchio") e transazionale (parole chiave nelle categorie "luogo di acquisto", "prezzo e servizio di consegna" e "regalo e servizio connesso"). Non è stata identificata alcuna parola chiave relativa all'intento di navigazione. Questo potrebbe significare che gli utenti del web e i consumatori di vino non cercano spesso un sito specifico, che spesso non conoscono, ma cercano soprattutto di ottenere informazioni per l'acquisto.
Infine, la debole posizione del vino italiano nel mercato statunitense emerge dalla terza fase della ricerca, che evidenzia la scarsa visibilità dei siti di vini italiani, collocati in posizione intermedia tra quelli di vini francesi e spagnoli (Figura 1).
Figura 1 – Paesi in cui i siti web sono ospitati e visualizzati nelle SERP di Google negli Stati Uniti per le ricerche di vini italiani, francesi e spagnoli negli Stati Uniti.
Il paradosso di Schrödinger dei Millennial
Richard Halstead
COO Wineintelligence.com
e Adjunct Faculty di Wine Business Management
A seconda della fonte a cui diamo credito, i consumatori Millennial nel Regno Unito possono essere considerati come una notizia molto positiva per la categoria del vino o una catastrofe in corso. Chi ha ragione?
A cosa servono quei Millennial? La domanda viene rivolta nei dipartimenti di marketing con crescente urgenza. Perché? Perché in molti mercati, Regno Unito compreso, il gruppo di consumatori nati all'incirca tra il 1980 e la metà degli anni '90 (le definizioni variano, ma questa è quella ampiamente accettata) stanno raggiungendo un'età in cui i loro comportamenti e i redditi disponibili stanno iniziando ad avere profondi effetti sulla forma di determinate categorie di prodotti e servizi.
A giudicare dai discorsi tenuti durante l’ultima conferenza della WSTA (Wine&Spirit Trade Association), il commercio del vino nel Regno Unito oscilla tra uno stato d'animo di silenzioso ottimismo e un panico contenuto a malapena alla prospettiva che le nuove generazioni di consumatori diventino mainstream. E se non gli piace il vino? E se non bevessero affatto alcol? O semplicemente bere un po' meno vino perché si dedicano allo yoga due volte a settimana e scelgono un gin tonic come drink per aperitivo del giovedì?
Fortunatamente, ci sono ragioni per essere allegri riguardo ai Millennials, secondo quelli che hanno partecipato ad un recente Briefing di Wine Intelligence. I Millennial non distruggeranno il settore vinicolo, ma neppure lo salveranno - almeno non senza uno sforzo da parte degli stessi operatori per portare la loroa offerta pienamente nel XXI secolo.
Il vino è stato tradizionalmente una bevanda per consumatori di mezza età e della classe media; il profilo odierno dei bevitori di vino sembrerebbe confermarlo: l'età media di un consumatore di vino mensile nel Regno Unito è di 50 anni e il suo reddito familiare medio è di circa il 25% superiore alla media nazionale.
I risultati di una ricerca di Wine Intelligence nel Regno Unito hanno confrontato il segmento dei 25-39enni nel 2019 rispetto allo stesso del 2009 in termini di consumo mensile di vino. La conclusione: la percentuale relativa della popolazione mensile di bevitori di vino rappresentata dal gruppo tra 25 e 39 anni è in effetti leggermente aumentata, salendo al 25% della popolazione di consumatori, rispetto al 23% nel 2009.
Prima di eccitarci troppo, la ragione di questa buona notizia potrebbe risiedere maggiormente nella più ampia demografia del Regno Unito. L'età media di un bevitore di vino mensile è aumentata negli ultimi dieci anni, da 48 a 50 anni, ma ciò è in gran parte dovuto alla crescita del segmento di 65+ (ora il 27% dei consumatori di vino mensili, rispetto al 21% nel 2009), con un leggero calo dei tassi di partecipazione tra gli anni 40-50. Questi cambiamenti nella popolazione dei consumatori nell'arco di 10 anni sembrano essere il riflesso di picchi demografici e depressioni all'interno della popolazione nel suo complesso tra i Boomer (ora per lo più over 60, con una maggiore speranza di vita) e i loro figli (ora alla fine dei loro 20 anni / inizio dei 30).
Ancora più importante per la categoria del vino, l'analisi longitudinale suggerisce che i 25-39 anni sono più coinvolti con la categoria del vino rispetto allo stesso segmento di età del 2009. Sono molto più propensi a concordare dichiarazioni come "il vino è importante per il mio stile di vita" e "mi piace prendere il mio tempo nella scelta del vino da acquistare".
I giovani hanno sempre speso di più per il vino delle persone anziane, principalmente a causa di due fattori:
Mentre i giovani potrebbero non abbandonare il vino, l'analisi dei nostri dati supporta la convinzione che il settore del vino deve lavorare di più per mantenere il suo posto in un mercato delle bevande alcoliche più competitivo e vivace. I nostri dati a lungo termine suggeriscono che la birra, in particolare la birra artigianale, il sidro e il gin hanno sperimentato un aumento dei tassi di partecipazione tra i consumatori mensili di vino negli ultimi dieci anni, sebbene i metodi di raccolta dei dati rendano difficile un confronto diretto.
Tuttavia, i dati suggeriscono anche che questa competizione proveniente da altre categorie di bevande non sia limitata ai Millennials. Anche tra i 40-55enni si assiste all’impennata nell'uso della birra artigianale e del gin, con categorie precedentemente fuori moda come il rum che stanno vedendo una crescita.
COO Wineintelligence.com
e Adjunct Faculty di Wine Business Management
Wine Newsletter 03/2019 - Novembre
A seconda della fonte a cui diamo credito, i consumatori Millennial nel Regno Unito possono essere considerati come una notizia molto positiva per la categoria del vino o una catastrofe in corso. Chi ha ragione?
A cosa servono quei Millennial? La domanda viene rivolta nei dipartimenti di marketing con crescente urgenza. Perché? Perché in molti mercati, Regno Unito compreso, il gruppo di consumatori nati all'incirca tra il 1980 e la metà degli anni '90 (le definizioni variano, ma questa è quella ampiamente accettata) stanno raggiungendo un'età in cui i loro comportamenti e i redditi disponibili stanno iniziando ad avere profondi effetti sulla forma di determinate categorie di prodotti e servizi.
A giudicare dai discorsi tenuti durante l’ultima conferenza della WSTA (Wine&Spirit Trade Association), il commercio del vino nel Regno Unito oscilla tra uno stato d'animo di silenzioso ottimismo e un panico contenuto a malapena alla prospettiva che le nuove generazioni di consumatori diventino mainstream. E se non gli piace il vino? E se non bevessero affatto alcol? O semplicemente bere un po' meno vino perché si dedicano allo yoga due volte a settimana e scelgono un gin tonic come drink per aperitivo del giovedì?
Fortunatamente, ci sono ragioni per essere allegri riguardo ai Millennials, secondo quelli che hanno partecipato ad un recente Briefing di Wine Intelligence. I Millennial non distruggeranno il settore vinicolo, ma neppure lo salveranno - almeno non senza uno sforzo da parte degli stessi operatori per portare la loroa offerta pienamente nel XXI secolo.
Il vino è stato tradizionalmente una bevanda per consumatori di mezza età e della classe media; il profilo odierno dei bevitori di vino sembrerebbe confermarlo: l'età media di un consumatore di vino mensile nel Regno Unito è di 50 anni e il suo reddito familiare medio è di circa il 25% superiore alla media nazionale.
I risultati di una ricerca di Wine Intelligence nel Regno Unito hanno confrontato il segmento dei 25-39enni nel 2019 rispetto allo stesso del 2009 in termini di consumo mensile di vino. La conclusione: la percentuale relativa della popolazione mensile di bevitori di vino rappresentata dal gruppo tra 25 e 39 anni è in effetti leggermente aumentata, salendo al 25% della popolazione di consumatori, rispetto al 23% nel 2009.
Prima di eccitarci troppo, la ragione di questa buona notizia potrebbe risiedere maggiormente nella più ampia demografia del Regno Unito. L'età media di un bevitore di vino mensile è aumentata negli ultimi dieci anni, da 48 a 50 anni, ma ciò è in gran parte dovuto alla crescita del segmento di 65+ (ora il 27% dei consumatori di vino mensili, rispetto al 21% nel 2009), con un leggero calo dei tassi di partecipazione tra gli anni 40-50. Questi cambiamenti nella popolazione dei consumatori nell'arco di 10 anni sembrano essere il riflesso di picchi demografici e depressioni all'interno della popolazione nel suo complesso tra i Boomer (ora per lo più over 60, con una maggiore speranza di vita) e i loro figli (ora alla fine dei loro 20 anni / inizio dei 30).
Ancora più importante per la categoria del vino, l'analisi longitudinale suggerisce che i 25-39 anni sono più coinvolti con la categoria del vino rispetto allo stesso segmento di età del 2009. Sono molto più propensi a concordare dichiarazioni come "il vino è importante per il mio stile di vita" e "mi piace prendere il mio tempo nella scelta del vino da acquistare".
I giovani hanno sempre speso di più per il vino delle persone anziane, principalmente a causa di due fattori:
- I giovani tendono ad acquistare solo quando necessario e non fanno quasi mai scorta, quindi tendono ad essere acquirenti ad un prezzo maggiore piuttosto che a cercare affari;
- I giovani usano il prezzo come proxy per la qualità, in una categoria in cui non tendono a conoscere tanto quanto un altro acquirente che ha 20-30 anni di esperienza in più nella categoria.
Mentre i giovani potrebbero non abbandonare il vino, l'analisi dei nostri dati supporta la convinzione che il settore del vino deve lavorare di più per mantenere il suo posto in un mercato delle bevande alcoliche più competitivo e vivace. I nostri dati a lungo termine suggeriscono che la birra, in particolare la birra artigianale, il sidro e il gin hanno sperimentato un aumento dei tassi di partecipazione tra i consumatori mensili di vino negli ultimi dieci anni, sebbene i metodi di raccolta dei dati rendano difficile un confronto diretto.
Tuttavia, i dati suggeriscono anche che questa competizione proveniente da altre categorie di bevande non sia limitata ai Millennials. Anche tra i 40-55enni si assiste all’impennata nell'uso della birra artigianale e del gin, con categorie precedentemente fuori moda come il rum che stanno vedendo una crescita.
Non più solo prodotto: ai manager e imprenditori vinicoli oggi serve esperienza, innovazione e intelligenza manageriale
di Gabriella Iacono
Area Leadership Dynamics
MIB Trieste School of Management
Area Leadership Dynamics
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2019 - Ottobre
Cosa significa oggi "intelligenza manageriale"?
Se partiamo dal concetto puro di intelligenza l'etimologia della parola ci porta al latino “intus legere” = leggere dentro, cogliere le informazioni, leggere il da farsi, nella pratica leggere l’azione migliore.
Quindi, "intelligenza manageriale" significa comprendere la realtà in modo profondo per coglierne il meglio e per costruire azioni corrette, virtuose, funzionali agli obiettivi.
Quali soluzioni per decidere il futuro devono perseguire i manager, gli imprenditori in un contesto che cambia? Quale approccio va usato per costruire un’"intelligenza manageriale”?
Abilità tecniche (QI) e intelligenza emotiva (EI) sono direzioni possibili ma non scontate da costruire. Il termine EI imperversa ormai ovunque ma il punto centrale da prendere in considerazione e COME i manager e gli imprenditori oggi sviluppano nuove abilità.
C’è ancora la convinzione che basta l’esperienza per portare avanti le imprese in un contesto che cambia oppure stiamo andando verso una visione di management che parte dal vissuto ma dà spazio ad una nuova visione di crescita personale?
Le imprese vitivinicole hanno costruito la loro storia partendo dal prodotto e basandosi moltissimo sull’esperienza dei padri fondatori, degli uomini della terra, i self-made men.
Oggi la valorizzazione delle aziende italiane nel mondo e l’innovazione tecnologica parlano lingue diverse, con la necessità da parte degli imprenditori di essere più consapevoli di come si muove il mercato, perché avere un buon prodotto non basta.
Nel mondo aziendale abbiamo sentito spesso raccontare storie di imprenditori/manager ricchi di talento, che non sono riusciti ad avere il meritato riconoscimento, e storie di altri imprenditori/manager dotati invece di competenze non eccelse, che hanno avuto grande successo nel business.
Realtà o leggenda? Forse la verità sta nel mezzo.
È necessaria una lettura attenta del presente. La turbolenza del mercato, l’incertezza e l’incapacità di leggere adeguatamente il contesto, l’ambiguità di alcuni segnali, rendono meno sicuro prevedere il futuro per chi deve lavorare su strategie di crescita della propria impresa.
È possibile che occorrano nuove “cassette degli attrezzi” ma forse anche una nuova forma mentis legata sempre più all’apprendimento costante che va oltre la sola esperienza, che tenga conto dell’innovazione legata alla tecnologia ma che guardi alle abilità manageriali con serio interesse.
C’è la necessità da parte degli imprenditori e dei manager di “rinnovarsi” nella modalità di pensiero della propria impresa e del proprio prodotto e nella valorizzazione del proprio capitale umano e questo necessariamente passa attraverso il paradigma del cambiamento e della formazione.
L'export tradizionale è in crisi?
di Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 02/2019 - Ottobre
Quando, a fine 2002, MIB ha progettato quello che sarebbe stato il primo programma di alta formazione in gestione d’impresa rivolto al mondo del vino italiano, il settore era diverso da oggi.
A differenza di oggi, 15 anni fa il settore agricolo non sentiva ancora il bisogno di forti competenze gestionali, soprattutto trasversali.
I mercati del vino mondiali hanno attraversato un periodo di cambiamento strutturale: è sempre più evidente la crisi dei modelli di consumo nei mercati tradizionali dell'Europa occidentale (Italia, Francia, Spagna o Portogallo), dove i consumatori più giovani si allontanano dal tradizionale bere vino quotidianamente verso un consumo più occasionale ed edonistico (a differenza di nuovi mercati dove sono appunto i giovani a trainare la crescita del settore).
Questa diminuzione dei consumi interni, il primo mercato per moltissime aziende, ha obbligato ad affrontare l’export, trovandosi però in diretta concorrenza con nuovi competitor e in mercati dove la presenza del vero canale di esportazione del vino italiano, ossia la ristorazione italiana all’estero (soprattutto nelle zone di forte emigrazione), gode di una rilevanza via via minore.
Se a questo aggiungiamo il progressivo consolidamento delle grandi aziende vinicole e, soprattutto, della distribuzione rispetto alla produzione, possiamo prevedere un impatto sensibile sulle scelte dei consumatori, con i segmenti basic e popular premium dominati da un ristretto numero di brand e un numero ancora minore di cantine. Tra l’altro, se in passato erano i produttori di fascia alta ad entrare nei segmenti inferiori con le c.d. “seconde linee”, oggi assistiamo al fenomeno opposto, con un riposizionamento verso l’alto di aziende strutturate e dalle maggiori capacità manageriali.
In generale, possiamo osservare come, in tutti i segmenti, a crescere siano le aziende che sanno investire sui propri brand e sulle capacità di servire i diversi mercati, attraverso una migliore conoscenza dei consumatori e della loro evoluzione. Ma per farlo bisogna disporre di professionalità adeguate, dalle assodate competenze funzionali e trasversali. Nelle grandi come nelle piccole imprese, perché anche le aziende familiari possono trovare un percorso di successo, come scrive Reka Haros che sarà anche quest’anno in aula WBM.
Nel Corso in Wine Business Management vogliamo trasferire ai nostri studenti solide competenze manageriali, migliorare le competenze funzionali ma, soprattutto, affiancarli nello sviluppo di capacità di pensiero strategico e di gestione del cambiamento all’interno dell’azienda vinicola. Di alcune di queste competenze “soft” ha scritto Gabriella Iacono, responsabile dell’area Leadership Development, in un altro articolo di questa newsletter. Competenze che fanno la differenza nel medio periodo, come testimoniano le interviste pubblicate dal Corriere Vinicolo ad alcuni nostri ex-studenti a distanza di anni dalla loro frequenza.
Quali mercati per i nostri vini?
Pierpaolo Penco
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Le colline del Prosecco patrimonio dell’UNESCO”. Così hanno titolato, con molta banalizzazione (anche nei commenti social seguenti), varie testate e articoli pubblicati a seguito del riconoscimento attribuito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene e alla dimensione tradizionale, paesaggistica e culturale della viticoltura legata al vino che qui si produce da secoli, il Prosecco.
In questi anni abbiamo avuto, tra gli studenti dei nostri Corsi in Wine Business, diversi partecipanti provenienti dalle diverse espressioni del “Sistema Prosecco”: DOCG Conegliano e Valdobbiadene, DOCG Asolo e DOC. Un sistema che, pur con diverse criticità, sta trainando la produzione, l’export e la redditività delle aziende agricole e vitivinicole di Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Raggiunto ormai il mezzo miliardo di bottiglie, di cui almeno l’80% è concentrato in 4 mercati (Italia, USA, UK, Germania), è il momento a nostro avviso di fermarsi a ragionare su quale sarà il prossimo futuro per quella che, oggi, nel mondo significa “bollicina italiana”, una precisa categoria sorta e cresciuta esponenzialmente in meno di 20 anni.
E con il Prosecco anche il Pinot Grigio l’85% della produzione nazionale viene da Nordest. Questa produzione detta i tempi ed il prezzo dei vini bianchi italiani da esportazione (almeno nel canale della GDO). Da un paio d’anni è stata costituita un’altra DOC interregionale, Pinot Grigio delle Venezie, il cui Consorzio di tutela si propone di elevarne il valore gestendone la produzione. Che ne sarà del Pinot Grigio che si rivolge ai segmenti più alti del mercato (penso a Collio, Isonzo, Colli Orientali)?
Per rispondere a questi ed altri temi di attualità sul “Sistema Vino” del Nordest MIB Trieste ha progettato una specifica Summer School, che si è tenuta a Portogruaro (VE) dal 22 al 26 luglio.
Dalla Summer School, che si è conclusa con una tavola rotonda in cui Presidenti o Vicepresidenti di alcuni dei principali Consorzi triveneti si sono confrontati con gli studenti sulle opportunità e le minacce dei differenti case study e dell’intero comparto, sono usciti diversi spunti di approfondimento che non mancheremo di pubblicare nelle prossime puntate di questa newsletter.
Responsabile Area Wine Business
MIB Trieste School of Management
Wine Newsletter 01/2019 - Settembre
Le colline del Prosecco patrimonio dell’UNESCO”. Così hanno titolato, con molta banalizzazione (anche nei commenti social seguenti), varie testate e articoli pubblicati a seguito del riconoscimento attribuito dall’Organizzazione delle Nazioni Unite alle Colline di Conegliano e Valdobbiadene e alla dimensione tradizionale, paesaggistica e culturale della viticoltura legata al vino che qui si produce da secoli, il Prosecco.
In questi anni abbiamo avuto, tra gli studenti dei nostri Corsi in Wine Business, diversi partecipanti provenienti dalle diverse espressioni del “Sistema Prosecco”: DOCG Conegliano e Valdobbiadene, DOCG Asolo e DOC. Un sistema che, pur con diverse criticità, sta trainando la produzione, l’export e la redditività delle aziende agricole e vitivinicole di Veneto e Friuli Venezia Giulia.
Raggiunto ormai il mezzo miliardo di bottiglie, di cui almeno l’80% è concentrato in 4 mercati (Italia, USA, UK, Germania), è il momento a nostro avviso di fermarsi a ragionare su quale sarà il prossimo futuro per quella che, oggi, nel mondo significa “bollicina italiana”, una precisa categoria sorta e cresciuta esponenzialmente in meno di 20 anni.
E con il Prosecco anche il Pinot Grigio l’85% della produzione nazionale viene da Nordest. Questa produzione detta i tempi ed il prezzo dei vini bianchi italiani da esportazione (almeno nel canale della GDO). Da un paio d’anni è stata costituita un’altra DOC interregionale, Pinot Grigio delle Venezie, il cui Consorzio di tutela si propone di elevarne il valore gestendone la produzione. Che ne sarà del Pinot Grigio che si rivolge ai segmenti più alti del mercato (penso a Collio, Isonzo, Colli Orientali)?
Per rispondere a questi ed altri temi di attualità sul “Sistema Vino” del Nordest MIB Trieste ha progettato una specifica Summer School, che si è tenuta a Portogruaro (VE) dal 22 al 26 luglio.
Dalla Summer School, che si è conclusa con una tavola rotonda in cui Presidenti o Vicepresidenti di alcuni dei principali Consorzi triveneti si sono confrontati con gli studenti sulle opportunità e le minacce dei differenti case study e dell’intero comparto, sono usciti diversi spunti di approfondimento che non mancheremo di pubblicare nelle prossime puntate di questa newsletter.